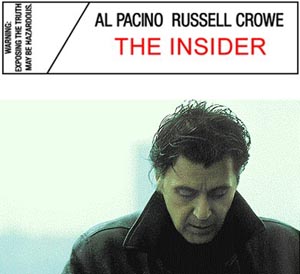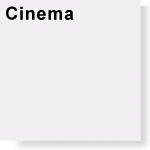
| Recensione/Insider Paola Casella
Insider, diretto da Michael Mann, scritto da
Michael Mann ed Eric Roth, con Al Pacino, Russell Crowe, Christopher
Plummer, Lindsay Crouse Insider ha una trama complessa e stratificata, che
inizia raccontando un conflitto e poi, a due terzi della narrazione,
passa a parlare di un altro, anche più drammatico e di maggiore
rilevanza sociale. La
storia, basata su un fatto realmente accaduto, anche se ampiamente
romanzato in fase di sceneggiatura, è quella di Jeffrey Wigand (Russell
Crowe), alto dirigente di un gigante dell'industria del tabacco (la
Brown e Williamson, uno dei sette nani, come vengono ironicamente
definite le multinazionali che si spartiscono il mercato del fumo
legale) che, dopo essersi opposto ai metodi illeciti con i quali la sua
azienda aumentava chimicamente il potenziale additivo dei propri
prodotti, viene licenziato e minacciato di ritorsioni qualora decidesse
di rendere pubblico ciò che ha scoperto. In parte per vendicarsi del
torto subito, in parte per togliersi un peso dalla coscienza, Wigand
decide di vuotare il sacco rilasciando un'intervista a "60 Minutes",
il programma di inchiesta più seguito d'America, trasmesso dalla rete
televisiva nazionale CBS. La decisione di Wigand è anche frutto delle
pressioni di uno dei produttori e autori del programma, Lowell Bergman
(Al Pacino), aggressivo e determinato prima nel fiutare la storia, poi
nel coltivarne la fonte e infine nel demolire le resistenze della sua
Gola profonda. Bergman è animato da furore messianico perché, oltre ad
avere ben presente ciò che fa audience, è convinto che "il
pubblico debba sapere": un hidalgo della notizia, un accanito
sostenitore dell'importanza di un'informazione onesta e senza peli sulla
lingua.
E' dunque uno choc per Bergman (oltre che per
Wigand, che per rilasciare l'intervista ha messo in gioco carriera e
famiglia) scoprire che la CBS, in procinto di essere acquistata dalla
multinazionale Westinghouse, rifiuta di trasmettere le rivelazioni
dell'ex dirigente per paura di rimanere invischiata in una costosa causa
legale (e si sa che "l'industria del tabacco non perde mai in
tribunale"). Quello
che sembrava un classico scontro Davide e Golia fra un ex dipendente e
il colosso aziendale che l'ha fatto fuori (e che comunque in questo
momento è il "nemico" del grande schermo più politically
correct, vista anche l'animosità personale di Bill Clinton contro
l'industria del tabacco) diventa una battaglia ideologica sulla libertà
di informazione, e su quanto la proprietà economica dei mass media
(soprattutto in un'epoca di merger multimediali e di megasinergie
aziendali) possa influenzare il contenuto dei "prodotti" di
informazione. Il tema è grande, non solo nel senso di vasto, ma
anche nel senso di importante. E
Michael Mann gli dedica un grande film, non solo nel senso di riuscito
ma anche di gigantesco: le inquadrature sono immense, i primi piani
mastodontici. Mann, che ha alle spalle una serie di film d'azione assai
ben confezionati - da L'ultimo dei Moicani a Heat - è, con Peter Weir,
uno dei pochi registi contemporanei ad esprimersi visivamente così in
grande, e a credere nel grande cinema.
Mann però non utilizza la vastità spaziale allo scopo
tradizionale del cinema americano: se un tempo il cinemascope serviva a
mostrare ampie distese territoriali (i campi di battaglia dei film di
guerra, le sconfinate praterie dei western), in Insider serve a
evidenziare ciò che è importante ai fini della trama: l'insignificanza
dell'uomo Lowell Bergman a mollo in un oceano enorme e agitato, la
solitudine di Wigand che gioca a golf in uno sterminato campo da golf
semideserto. La tendenza al gigantismo di Mann per sottolineare
il minimo dettaglio è ancora più evidente in certi primi piani di
Wigand, così grandi che un suo occhio arriva a occupare un terzo dello
schermo: e non si tratta solo della padronanza espressiva di un regista
che mette accenti narrativi con l'immagine, ma anche di coerenza fra
stile cinematografico e contenuto narrativo, poiché Insider ci insegna
a diffidare di ciò che ci viene propinato dai mass media, soprattutto
dalla televisione, perché tutto ciò che vediamo è manipolato e
manipolabile, ed essere visibile non significa necessariamente essere
vero (e infatti, nonostante i primi piani, non riusciamo mai a
oltrepassare la superficie esteriore di Wigand per capire fino in fondo
l'uomo). Inevitabile il
riferimento al Blow up di Antonioni, dove un particolare, ingigantito
all'eccesso, si rivelava più fuorviante che utile alla scoperta della
verità. Malgrado le sue dimensioni, Insider è un film sorprendentemente intimo, anche perché l'intera vicenda è raccontata attraverso un'ottica da, appunto, insider, anche a livello visivo: pensiamo alle scene in cui la telecamera è praticamente posizionata dietro l'orecchio di Wigand, e noi lo seguiamo mentre entra nella hall di un albergo, o in un'aula di tribunale, vedendo esattamente ciò che vede lui. Un simile grado di sovrapposizione visiva fa sì che non ci sia, fra noi e il supertestimone, alcuna distanza critica o emotiva. Semplicemente viviamo in tempo reale le sue disavventure, affrontandole con crescente disagio, ma anche con un coinvolgimento diretto che fa sì che le due ore e mezza del film trascorrano senza accorgercene. Lo stesso scopo ha anche la colonna sonora, che commenta in modo emotivo e spiazzante persino i passaggi più didascalici dell'iter legale: come Peter Weir, Michael Mann lascia al commento musicale il compito di veicolare nel modo più immediato possibile quanto di irrazionale e incontrollabile sottende anche la più disciplinata delle vicende umane.
Il risltato è che un film diretto con
precisione matematica e con un rigore formale al limite della pignoleria
abbia sul pubblico un impatto emotivo assolutamente viscerale.
Anche la sceneggiatura, un perfetto esempio di quel "sadismo
narrativo" di cui si parla nei corsi di scrittura creativa, ha la
sua parte: incalzante e senza tregua, mette continuamente i due
protagonisti a confronto con scelte sempre più drammatiche,
restringendo le loro opzioni (di qui il crescente senso di claustrofobia
di certe scene pur visivamente immense) e alzando il livello delle
conseguenze di quelle scelte. Il
ritmo narrativo è quello del thriller d'azione - basti pensare
all'incipit della vicenda Wigand-Bergman, con quello scambio frenetico e
inquietante di messaggi via fax - anche
se il film è in realtà un excursus morale, una parabola su quali
compromessi siamo disposti ad accettare, e quale sia il nostro prezzo. Anche le caratterizzazioni dei protagonisti
diventano sempre più estreme, e in tempo reale vediamo due esseri umani
trasformarsi in due personaggi da tragedia greca (o scespiriana), ognuno
con il suo tallone d'Achille che, guarda caso, è in fondo lo stesso:
l'imperativo di "esserci", anche nel senso di rappresentare un
modello, per chi li ama. Nella
biografia di Bergman, appena accennata, questa esigenza è una diretta
conseguenza dell'abbandono subito dal padre; in quella di Wigand deriva
dal senso di colpa per aver abbandonato una moglie malata e una figlia
indifesa. Questo fa sì che due personaggi apparentemente
molto diversi - l'uno dirigente e scienziato, l'altro giornalista e
umanista; l'uno sostenitore del quieto vivere e membro della middle
class affluente, l'altro agitatore nato e intellettuale radical chic -
appartengano alla stessa storia, accorgimento narrativo indispenabile
perché una storia "funzioni".
Va a Mann e al suo cosceneggiatore Eric Roth, già autore di
Forrest Gump, il merito di aver minimizzato le differenze fra i due
protagonisti, soprattutto quelle politiche (Wigand è un repubblicano di
quelli che credono nel diritto costituzionale a tenersi un arsenale in
casa, Bergman un democratico liberal di quelli che vivono ancora col
mito dei Chicago Eight - e infatti ancora adesso il vero Bergman vive e
insegna a Berkeley) per sottolineare invece i comuni principi.
Il che è anche un modo di dire che certi valori - l'integrità
personale, la coerenza, l'onestà - non dovrebbero appartenere a nessuno
schieramento politico, ma alla dignità umana in generale. La magistrale recitazione dei due
protagonisti (e di Christopher Plummer nel ruolo dell'anchorman Mike
Wallace, di cui quale parleremo in seguito) rispecchia esattamente lo
stesso criterio: speculare e contraria (ricordiamo che, nel thriller
Heat, Mann aveva raccontato un altro duo di "facce della stessa
medaglia", riunendo per la prima volta sul grande schermo Al Pacino
e Robert De Niro, nei ruoli complementari di un poliziotto e della sua
preda). Se Pacino, in grande forma, recita con enfasi e passione il
classico cane sciolto idealista e insubordinato (remember Serpico?),
Russell Crowe riduce al minimo la gestualità (e ricordiamo quanto fosse
invece "fisica" la sua performance in LA Confidential) e
l'espressività facciale per calarsi nei panni di Jeffrey Wigand, un
uomo qualunque entrato in un gioco più grande di lui, che davanti alla
palese ingiustizia, più ancora che alla pericolosità delle pratiche
della Brown e Williamson, tira fuori un'ostinazione da mulo, più ancora
che un coraggio da leone. La performance di Crowe è più degna di nota di quella di Pacino (e infatti gli è valsa una nomination all'Oscar, sfuggita invece al piccolo italoamericano) perché il suo ruolo è molto più ingrato e "sottopelle": Wigand non esplode mai, al massimo implode, e silenziosamente. Crowe, che era stato scelto personalmente da Sharon Stone come suo compagno in Pronti a morire per il suo "magnetismo sessuale", appare in Insider ingrassato e (artificialmente) invecchiato, e riesce a dare a un personaggio sfuggente e sgradevole una qualità ipnotica che lo rende comunque il perno della vicenda. Come dire che la statura morale può trasparire anche dal più opaco degli esseri umani. Allo stesso modo la storia di Insider, che si
presterebbe a decine di scene madri, e a numerose sequenze di esultanza
all'americana stile"gimme five", è quasi del tutto privo di
retorica. Quando la moglie di Bergman gli dice "Hai vinto" (e
glielo dice in modo sommesso, a letto, in un momento di intimità
domestica) lui replica perplesso: "Vinto cosa?".
La telecamera non indugia sui (pochi) successi dei protagonisti,
che non si autocompiacciono mai. L'unica
scena celebrativa (per durata, per ampiezza visiva) è quella in cui
Wigand, dopo aver testimoniato contro la Brown e Williamson, si lascia
andare ad un sorriso di sollievo. Ed
è una scena muta, filmata con una carrellata circolare che allo stesso
tempo ne abbraccia e contiene l'emozione.
E' anche l'unica pausa nell'incalzare degli eventi,
che concede al protagonista un attimo di tregua: ricorda da vicino
quella di Thelma e Louise nella quale Susan Sarandon, lanciata in fuga
attraverso i grandi spazi del Southwest, ferma l'auto ed esce a
respirare l'aria della notte. Anche
quella scena è muta, eppure anche lì si ha l'impressione di sentire il
rumore del vento. Se la storia e il grosso del tempo filmico
appartengono a Wigand e Bergman, la caratterizzazione più memorabile è
tuttavia il cammeo di Christopher Plummer nel ruolo di Mike Wallace.
Wallace, sconosciuto da noi, è una figura leggendaria del
giornalismo americano, una specie di Enzo Biagi d'oltreoceano.
O meglio: un'icona televisiva che, all'integrità professionale
di giornalista di inchiesta alla Zavattini, unisce un appeal da star
mediatica alla Mike Bongiorno (o alla Emilio Fede, nella sua valenza
rileccata e piaciona). Wallace, quello vero, è furioso perché il
ritratto che Insider fa di lui è quello di un aziendalista pronto a
cedere la propria autonomia giornalistica in nome della stabilità della
corporation che gli paga lo stipendio (da favola).
Forse gli pesa anche la connotazione narcisista con la quale
Plummer colora (e parliamo anche di guance imbellettate) la sua
caratterizzazione. Ma non
dovrebbe: Plummer, Mann e Roth hanno fatto del personaggio di Mike
Wallace quello in cui lo spettatore può maggiormente identificarsi,
perché è il più riconoscibilmente umano.
Wallace sta a Insider come Pietro sta al Vangelo: non un profeta
coraggioso ma un uomo fallibile, pronto ad ammettere la propria
fallibilità. Indimenticabile
la scena (muta, anche quella) in cui ognuno dei tre protagonisti
principali nel momento della messa in onda dell'intervista televisiva
ottengono il rispetto cui più tengono al mondo: quello delle figlie per
Wigand, quello della moglie per Bergman, quello di sé per Wallace. Insider potrebbe chiudersi sulla scena in cui
Wallace entra nella sala regia di "60 Minutes", rassegnato ad
affrontare le reazioni dei colleghi quali che esse siano, invece che su
quella di Bergman che esce dal palazzo della CBS come Donchisciotte.
Perché Insider è un film che preferisce parlare di uomini,
piuttosto che di eroi. Articoli
collegati:
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui
|



| Home | Rassegna italiana | Rassegna estera | Editoriale | Attualita' | Dossier | Reset Online | Libri | Cinema | Costume | Posta del cuore | Immagini | Nuovi media | Archivi | A domicilio | Scriveteci | Chi siamo |