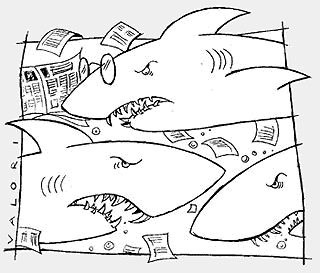| Pochi pesci in un
piccolo stagno
Giuseppe Turani con Gino Gullace
Articoli
collegati:
Merito dei
giornalisti? "Più che altro, è una conseguenza del fatto
che non c'è un rapporto così stretto tra l'editore e la redazione. Il
sistema di trasmissione degli interessi, degli input, degli ordini non
è così automatico come la gente pensa. E io alla figura dell'editore
fisso nello stabile della redazione non ci ho mai creduto. Gli editori
sono dei signori mediamente ricchi che ogni tanto vanno anche al mare,
al cinema, non stanno fino alle undici di sera a leggere
il loro giornale". Qual è la
peculiarità dell'assetto proprietario dell'editoria italiana? "Da noi c'è un capitalismo molto piccolo e
poco sviluppato. Economicamente parlando, siamo un piccolo stagno. Ci
sono un paio di gruppi che contano dieci volte più degli altri e il
meccanismo risulta perciò bloccato. Metteteci poi che la televisione è
per definizione organizzata in duopolio, e diventa perfettamente inutile
fare dibattiti sulla libertà di informazione. Prima di tutto cominciamo
a smontare il duopolio televisivo". Dunque
bisognerebbe limitare per legge la proprietà dei mezzi di informazione,
in modo da aumentare il numero degli editori? Secondo lei sulle
redazioni italiane vengono effettivamente esercitate pressioni da parte
del gruppo di interessi rappresentato dall'editore? I manuali di
giornalismo riportano immancabilmente l'episodio di Albertini, direttore
del Corriere della Sera, che cacciava dalla redazione l'editore,
presentatosi per discutere il contenuto di un articolo, intimandogli di
ripresentarsi solo al momento della riscossione dei dividendi. Secondo
lei, oggi, l'autonomia del giornalista è un'utopia o una possibilità? "Dipende molto dal carattere, dalla statura,
dal peso specifico delle singole persone. Se metti mio cugino a dirigere
un giornale, l'editore gli fa fare quello che vuole. Se metti, invece,
una personalità di grande peso e livello, all'editore risulta un po' più
difficile imporsi, anche perché il direttore ha il suo buon nome da
difendere. Si torna comunque al problema di prima: se c'è un
capitalismo articolato e una stampa articolata, posso anche, come
direttore, ribellarmi all'editore, nel senso che posso andarmene in un
altro posto. Se sono un bravo professionista, dopo due ore ho la
scrivania pronta in un altro giornale. Essendo il nostro meccanismo così
ristretto, invece, per un direttore opporsi alla proprietà non è così
semplice". La fine delle
dinastie editoriali è stata un bene o un male? "Beh, sono finite anche le dinastie tessili,
quelle dell'industria meccanica...il capitalismo cambia, ci sono quelli
che si adattano e quelli che non si adattano, e subentrano nuove
figure". Come vede l'arrivo
di editori stranieri che investono nei gruppi editoriali italiani? Eppure sono stati
proprio gli editori stranieri arrivati in Italia a chiedere nuove regole
per limitare lo starpotere tv e redistribuire le risorse della pubblicità... "Sono perfettamente d'accordo, anche se poi
sono dell'idea che chiunque dovrebbe poter fare qualunque cosa gli venga
in mente. Questa regola per cui chi possiede quotidiani non può
possedere reti televisive è arcaica. Stabiliamo che uno possa avere un
solo canale tv e poi però non rompa più le scatole. E la prima a farlo
dovrebbere essere proprio la Rai. Nell'attuale duopolio televisivo, la Rai con tre
canali e Berlusconi con tre, è necessario un osservatorio ciclopico
dove si contano i secondi dei vari interventi di politici. Se invece ci
fosse in Italia una legge che dice, chiunque può possedere un solo
canale e basta, avremmo sei reti tv diverse e forse non ci
preoccuperemmo troppo di contare i minuti che Bertinotti ha avuto a
disposizione su Rai3 o su Rete4, perché Bertinotti parlerebbe dove gli
capita, un po' qui e un po la'. Con due soli network è inevitabile che
si vada a fare tutti i conti.". Secondo lei, la
connotazione del prodotto giornalistico come business non snatura un po'
quella che dovrebbe essere la missione ideale del giornalista? "Non si può pretendere che esista un
giornalismo fatto esclusivamente a fin di bene. Ormai tutto gira intorno
alle imprese, e i giornalisti, giustamente, vogliono guadagnare dei bei
soldi, come tutti. Se non fosse così, i talenti migliori andrebbero a
fare altre professioni. Solo pochi hanno la vocazione del monaco, ed è
perché hanno da risolvere il problema del loro rapporto con Dio. I
giornali, per fortuna, sono fatti da laici. E quindi io sono per dei
giornali che funzionino come delle imprese. Quando a Milano si pose il problema del salvataggio
del Corriere, dopo la fine di Rizzoli, si erano inventati 27 mila
soluzioni diverse. C'era anche chi voleva fare intervenire i più grandi
gruppi bancari, che però avrebbero dovuto delegare la nomina del
direttore a una specie di consiglio superiore dei rettori delle
università. Io dico che la migliore garanzia per il lettore e per il
cittadino è quella di vivere in un paese in cui c'è un capitalismo
articolato e variegato con tanti protagonisti, una di quelle società,
insomma, che si chiamano aperte". Come mai nei
grandi giornali, o anche in tv, si fanno sempre meno inchieste? "Ma perché l'inchiesta è ormai materiale per
giornalisti sfigati. Se vuoi davvero fare carriera, coltiva la tua
scrivania e diventa magari cronista parlamentare".
Articoli
collegati:
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui
|



| Home | Rassegna italiana | Rassegna estera | Editoriale | Attualita' | Dossier | Reset Online | Libri | Cinema | Costume | Posta del cuore | Immagini | Nuovi media | Archivi | A domicilio | Scriveteci | Chi siamo |