
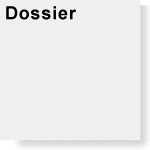
| Pubblicita': la si odia o la si ama?
Emanuele Pirella Articoli collegati Pubblicita': la si odia o la si ama? Pubblicita'/Una carrellata di immagini Pubblicita'/La sigla audio di Carosello Documenti/Le forme della pubblicita’ (Attilio Bertolucci, 1955) Pubblicita'/Benvenuti nell'"economia dell'attenzione" Pubblicita'/Come far cliccare il navigatore Pubblicita'/Una galleria di banner vincenti Il pezzo che qui pubblichiamo è l'introduzione a un importante studio sull'attitudine degli italiani nei confronti della pubblicità dal titolo "La pubblicità. La si odia o la si ama? - 84 domande e risposte su "gli italiani e la pubblicità". La ricerca è stata curata da Enrico Finzi, presidente di Astra e di Demoskopea e commissionata dalla Pirella Göttsche Lowe
Molti ci hanno chiesto come mai avessimo commissionato una indagine
come questa. La domanda sottintendeva più stupore che ammirazione. Un’agenzia di
pubblicità sa spendere soldi, spesso, in modi più creativi. Può fare una bella
convention in Tunisia, mandare fiori freschi ogni mattina alle mogli dei clienti, arredare
l’ufficio dell’amministratore delegato con mobili d’antiquariato. Noi, per
la seconda volta, ci siamo interrogati sulle reazioni dei consumatori italiani alla
pubblicità. Lo avevamo fatto nell’84, lo abbiamo rifatto adesso.
"Non avrai altro jeans all’infuori di me" e "Chi mi ama, mi segua" scrivevo un po’ di anni fa per dei jeans. "O così o Pomì" è di qualche anno più tardi, e seguiva il suggerimento di un account executive. E "Repubblica sveglia l’Italia" con un Craxi colto, in una foto di repertorio, durante un’assemblea del suo partito, mezzo addormentato. E Gatorade: "Vince la sete... e riparti di slancio". E "Altissima, purissima, Levissima". E "Io esiste" per il lancio del mensile Max o "Uoma" per il rilancio di Amica. E "Chi c’è c’è, chi non c’è, non c’è" per il lancio di un liquore al limone. O la campagna per Volvo, quella per Averna, quella per Bailey’s. Loro Piana, Santa Margherita, Artemide, Alessi. Non c’è cliente, piccolo, medio, grande che sia entrata, con un’immagine di marca netta e promettente, nell’immaginario di tutti. L’elenco è lungo e ingiustamente parziale. Ma serve solo a dimostrare diciotto anni di coerenza nella qualità, nella qualità pubblicitaria. Siamo l’unica agenzia italiana che ha vinto un Leone di bronzo nel 1997 e un Leone d’oro nel 1998 al Festival Internazionale di Cannes. Ma mai come oggi sembrano saltati i criteri di giudizio unitari, la percezione condivisa che una cosa è bella o brutta, giusta o non giusta, utile o dannosa. In assenza di una cultura comune del comunicare, sembra che vada bene tutto e il contrario di tutto. E’ la coda di quegli anni Ottanta che sono stati i grandi e vitalissimi corruttori del nostro mestiere. Non per nulla Roberto D’Agostino li ha definiti come "la Belle Epoque della nostra memoria. C’era il post moderno nell’architettura di Portoghesi, il Nome della rosa di Umberto Eco, il pensiero debole di Gianni Vattimo, la transavanguardia di Achille Bonito Oliva". Gli anni della stupidità: così sono stati giudicati da un bello stuolo di osservatori gli anni Ottanta. Difficile avanzare dei però nei confronti di un’etichetta paradossale, certo, ma perentoria. O invocare dei diminutivi, quasi ad attenuare la colpa della presenza di noi tutti dentro un decennio stupidino. Sicuramente sono stati anni muscolari, nei quali l’esibizione del tanto ha trionfato sulla quieta produzione del meglio. Tanta velocità: gli aerei privati hanno portato gli importanti da Milano a Roma a Milano a Roma per quattro differenti meetings nel corso della stessa giornata. Tanto denaro: non solo i miliardi di lire del deficit italiano, ma anche e soprattutto i miliardi guadagnati in Borsa, i miliardi delle classifiche degli uomini più ricchi della Terra, i cinque, sei, otto, dieci milioni al metro quadrato degli appartamenti nei centri storici della città, i miliardi dei quadri alle aste di Sotheby. Tanta carta: i giornali si sono gonfiati di pagine, di supplementi, di speciali, di inserti, di depliant, di pubblicità. Infine, tanta pubblicità. E’ all’inizio degli anni Ottanta che Berlusconi comincia ad
agire come metal detector di budget sommersi. La leggenda racconta il diverso modo di
affrontare i possibili clienti pubblicitari di quello che, allora, era a capo di una
piccola emittente privata chiamata prima Telemilano, poi Canale 5. Un camper attrezzato ad
ufficio, a camera da letto, a salotto e cucina ospitava Silvio Berlusconi nella sua caccia
agli imprenditori sconosciuti. Da Empoli a Taranto, da Pordenone a Settimo Milanese, da
Zola Predosa a Pomezia: l’autista guidava la notte da un giacimento all’altro
dell’economia sommersa. Alla mattina alle 9, Berlusconi usciva dal camper fresco di
dopobarba e pronto all’incontro. Ogni puntino sulla carta geografica, una riunione
con un industriale; ogni industriale incontrato, l’impegno ad investire una bella
cifra su Canale 5. Sotto, infatti, a grattarci, c’è il già fatto, il già detto, il già visto. Molta parte della pubblicità anni Ottanta ha raccontato il già raccontato, ma gonfiandolo. Perché girare uno spot a Cinisello Balsamo quando lo si può girare in Australia? Perché girare un trenta secondi con cento milioni di spesa quando lo si può pagare seicento milioni? Perché fare una campagna pubblicitaria da soli, cercando qualche idea originale, con tutti i rischi che questo comporta, quando la si può copiare tale e quale da una campagna americana che ha avuto grande successo? E’ questo, infatti, per chi volesse fare una piccola cronaca della
pubblicità italiana ciò che divide il modo di fare degli anni Settanta da quello degli
anni Ottanta. Chi mai aveva voglia di dare credito alla pubblicità negli anni che
seguivano il Sessantotto? Non era disattenzione, era proprio un reciso negarsi
all’ascolto. E il pubblicitario, per parlare ad un pubblico che non voleva starlo a
sentire, cercava di fare come i bambini con la madre arrabbiata che li ha messi in
castigo. Cercava di farsi piccolo, dolce, ironico, di iniziare il discorso con la voce
bassa bassa, per farsi perdonare, magari abbracciare, per sorridere poi insieme. Era il
decennio dell’ironia, nei quali il messaggio pubblicitario scontava un complesso di
colpa. E le campagne erano avvolgenti, caute, volutamente spoglie e minimali. Così, stereotipo dopo stereotipo, in quegli anni abbiamo visto tanti
spot che cercavano di inserire il prodotto all’interno di stili di vita inarrivabili.
Era il trionfo di "abbiamo l’esclusiva", delle telefonate dalle macchine,
dalle barche a vela per birre e whisky, delle cavalcate selvagge e snob, delle case da
rivista di arredamento americana. E poi lo spot asintattico, salterino, pseudocolto, lo spot di poesia.
Gli anni Ottanta l’hanno visto apparire timidamente qua e là, infittirsi, diventare
un diluvio, stancare al primo sguardo. Era in bianco e nero, molto spesso, perché la
poesia mal si concilia con il colore. Non aveva dialoghi, non aveva parole; solo una
canzone, meglio se nota, a far da spiedino alle immagini. Imitava la maniera dei
videoclip, anche se non teneva in conto che un videoclip dura tre minuti e uno spot trenta
secondi. I sapori, quindi, si succedevano a contrasto, come nell’agrodolce: bianco e
nero, poi colore, poi qualche intervento grafico, poi lei, poi un paesaggio, poi una mano,
poi qualche intervento grafico, poi il colore sfuocato, poi, per finire, ancora bianco e
nero. Insomma, si era alla ricerca del sublime, ma quasi sempre ci si fermava un po’
prima: ad una sequenza da album fotografico. La comunicazione persuasiva è tutta un’altra cosa. Non è far
dire alla gente: "E’ vero, le cose stanno proprio così". E’ far dire:
"Che strano? Non sapevo che le cose potessero stare così". Non ciò che è
atteso, va comunicato; ma l’inaspettato, l’inatteso, ciò che, sorprendendo,
crea il desiderio. E’ lo scarto dalla norma. Oggi ci rivolgiamo ad un pubblico che è
molto cambiato. Non mi riferisco a quel cambiamento che accese di sinistra gioia luterana
gli occhi di molti ricercatori a metà degli anni Novanta, quando arrivarono gli hard
discount, le marche private e la recessione. Calavano i consumi, le marche restavano sugli
scaffali, i cittadini sembravano voler disobbedire a tutto: alle ideologie, ai partiti, ai
consigli per gli acquisti. E i sociologi, festosi per quell’aria penitenziale e
ribellistica, predicavano una pubblicità informativa, tutta tesa a raccontare gli
ingredienti, i segreti di fabbricazione. L’Unione Consumatori, il Giurì e
L’Antitrust come direttori creativi. Allora meglio il gran mistificatore Reagan. Questi anni ultimi Novanta non sono stati gran che in nessuna delle
arti importanti. Si capisce che non sono passati sotto lo schiacciasassi normalizzatore
della nostra comunità che obbliga a mettere il nome del prodotto nel titolo, meglio se
all’inizio. E bello grande il prodotto. Più grande, ho detto. "Think
small" era il primo titolo di una memorabile campagna americana per la Volkswagen.
Con un’auto piccola piccola in una grande pagina bianca. Le vendite di
quell’auto quadriplicarono. E obbliga a mettere nella campagna il consumatore al
quale ci si rivolge. Ma che sia un po’ più bello, un po’ più ricco, un
po’ più di quanto sia in realtà. I pastori sardi, sottoposti alla maturazione forzata di sei reti
televisive più altre due, più quelle digitali, ne sanno ormai più di Spielberg. E la
cosa che chiedono è di non essere presi per scemi. Tutti sanno ormai tutto e sono capaci
di capire un annuncio pubblicitario nuovo, fresco, creativo. Pubblicita': la si odia o la si ama? Pubblicita'/Una carrellata di immagini Pubblicita'/La sigla audio di Carosello Documenti/Le forme della pubblicita’ (Attilio Bertolucci, 1955) Pubblicita'/Benvenuti nell'"economia dell'attenzione" Pubblicita'/Come far cliccare il navigatore Pubblicita'/Una galleria di banner vincenti |



| Home | Rassegna italiana | Rassegna estera | Editoriale | Attualita' | Dossier |Reset Online |Libri |Cinema | Costume | Posta del cuore | Immagini | Nuovi media |Archivi | A domicilio | Scriveteci | Chi siamo |
