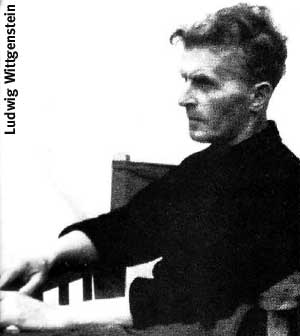Colui che separò il naturalismo
dall'empirismo
Richard Rorty
Articoli collegati:
Colui che separò il
naturalismo dall'empirismo
Chi può dirsi suo discepolo?
Al gioco del linguaggio
L'andar per funghi e l'arte
della filosofia
Gli usi di un filosofo,
come e perché
Questo articolo è apparso sul numero 64 di Reset, del
gennaio-febbraio 2001
Il Wittgenstein venerato dai docenti di filosofia non è l’asceta
insensibile, infelice, tormentato, represso, incline a drammatizzare
le proprie vicende personali, che viene ritratto (non senza
accuratezza) nel film di Derek Jarman e nell’eccellente biografia di
Ray Monk. E non è nemmeno l’autore di aforismi le cui trovate
folgoranti sono citate di continuo da intellettuali che non hanno idea
del perché i filosofi considerino importante la sua opera.
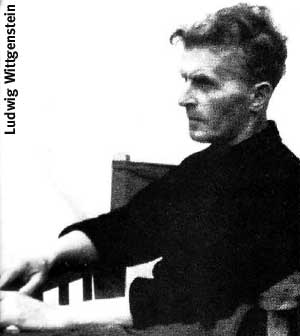
È invece un pensatore che, nelle sue ultime opere, ha contribuito a
farci conseguire uno dei principali progressi filosofici dei tempi
più recenti: la separazione tra
naturalismo ed empirismo.
Il naturalismo è una buona idea. Significa considerare gli esseri
umani in quanto prodotti dell’evoluzione biologica, senza una
componente immateriale misteriosa quale ad esempio l’anima
immortale, o l’ego cartesiano. Essere naturalisti significa prendere
sul serio Darwin, e interpretare l’interesse degli uomini per
verità e bontà come parte dei tentativi di una certa specie
biologica (una specie che ha avuto in dono una rete neurale
insolitamente complessa) di rispondere alle proprie esigenze. I
naturalisti contemporanei insistono nel dire che ciò che ci rende
umani è la capacità di utilizzare il linguaggio, di scambiarci segni
e rumori (prima allo scopo di collaborare a progetti di tipo pratico,
in seguito per dar vita a una cultura superiore), più che il possesso
di un ingrediente extra, di cui gli animali sono privi.
L’empirismo è una cattiva idea. Significa pensare che tutta la
nostra conoscenza è solo un problema di “elaborazione di
informazioni sensoriali”. Fondato da Locke e da Hume, l’empirismo
ha ben poco a che vedere con il naturalismo e tutto a che vedere con l’irrimediabilmente
obsoleta immagine cartesiana, della mente come misterioso teatro
interiore nel quale le “idee” sono proiettate su di uno schermo,
davanti a un altrettanto misterioso spettatore immateriale. Se ci
sbarazzassimo di questa immagine, non porremmo più quel pessimo
genere di domande cui è impossibile rispondere, del tipo: “L’immagine
del mondo che ci costruiamo elaborando concettualmente le impressioni
sensoriali, somiglia veramente al mondo che ci trasmette queste
impressioni?”, oppure: “Il fatto che tu ed io usiamo lo stesso
linguaggio significa che nella nostra mente abbiamo le stesse idee,
oppure tu magari quando dici ‘viola’ intendi quello che io chiamo
‘rosso’, e viceversa, perché il nostro spettro dei colori è
invertito?”; o ancora: “Una persona cieca dalla nascita intende
per il termine ‘rosso’ la stessa cosa che intendiamo noi?”.

Questi insensati interrogativi scettici tormentano i filosofi fin dai
tempi di Locke. Nelle sue Ricerche filosofiche, Wittgenstein ne ha
fatto piazza pulita. Molti filosofi precedenti, compreso Hegel, ci
avevano provato. Ma Wittgenstein ha riportato un sostanziale successo
laddove altri avevano fallito. Ciò è accaduto in parte perché
Wittgenstein ha sostituito all’“esperienza”, in quanto dato
fondamentale della filosofia, il “comportamento linguistico”. In
parte perché le sue armi erano l’irrisione e l’ironia sardonica,
più che la costruzione sistematica o il ragionamento logico.
Particolarmente memorabile è il suo farsi beffe dell’idea delle “sensazioni
private, la cui qualità percepita è incomunicabile agli altri”.
Nella sua versione più citata, assume la forma dell’analogia con
una comunità in cui ciascuno sostenga di avere una scatola con dentro
un insetto, insetto che nessuno potrà mai guardare se non il suo
proprietario. Wittgenstein sosteneva che il gioco del linguaggio sugli
insetti sarebbe allora stato condotto in modo tale che non avrebbe
avuto alcuna importanza quello che c’era nelle scatole, e nemmeno il
fatto che le scatole potessero essere vuote. Il comportamento
linguistico prodotto dal guardare all’interno delle scatole sarebbe
stato comunque il medesimo.
Il punto filosofico che l’analogia vuol dimostrare, è che, fintanto
che continuiamo a rispondere a oggetti che sono a disposizione di
tutti (compreso il comportamento linguistico di altri esseri umani)
come facciamo normalmente, quali siano le “informazioni sensoriali”
private che riceviamo ed elaborariamo è una questione priva di
importanza. È possibile, sosteneva Wittgenstein, giudicare sia in
base agli insetti, sia in base alle impressioni private non
comunicabili.
Un altro risultato importante conseguito da Wittgenstein è stato l’averci
aiutato a superare l’influenza della fuorviante affermazione di
Russell, secondo cui “la logica è l’essenza della filosofia”.
Dopo aver glorificato la logica nelle sue opere giovanili, l’ha poi
riportata alle giuste proporzioni in Ricerche filosofiche. È
difficile esagerare l’effetto suscitato nei filosofi che ascoltavano
l’autore del Tractatus logico-philosophicus (1919), un volume
pionieristico che proclamava di aver risolto tutti i problemi della
filosofia operando una svolta radicale nella teoria logica, chiedersi
trent’anni dopo “Perché mai abbiamo pensato che la logica fosse
qualcosa di sublime?”
Osservare la svolta a 180 gradi che Wittgenstein ha impresso alla sua
interpretazione del rapporto tra logica e linguaggio, contribuirà a
vaccinare i futuri filosofi contro l’idea che i problemi filosofici
si possano risolvere (o magari dissolvere) inventando un apparato
logico più preciso. Al posto della “struttura” sublime,
immateriale, che formava l’impalcatura per tutti i linguaggi
possibili, Wittgenstein ci ha aiutati a inserire l’idea delle
necessità pratiche che tutti i linguaggi reali sono finalizzati a
servire.
L’opera più tarda di Wittgenstein ha sortito l’impatto maggiore
in Gran Bretagna, in America e nel resto del mondo anglofono. Per un
certo periodo di tempo sembrò che tale impatto dovesse modificare il
carattere stesso di questa disciplina e l’immagine di sé che
avevano i docenti di filosofia. Sembrava che questo suo tentativo di
dissolvere i problemi filosofici (e in particolare quelli scettici),
contrapposto al tentativo di risolverli, dovesse diventare il modello
dell’impegno filosofico del futuro. Purtroppo ciò non è accaduto.
I filosofi anglofoni sono tornati a quelle che erano le loro cattive
abitudini pre-Ricerche filosofiche. È accaduto in parte perché la
filosofia professionistica è costretta a prendere i problemi
tradizioni più seriamente di quanto faceva Wittgenstein, se vuole
proporsi al pubblico come una disciplina para-scientifica. È
difficile prendere sul serio una professione che afferma di non fare
altro che dissolvere gli pseudo-problemi creati in primo luogo da
quella professione stessa.
Un altro motivo del declino della reputazione di Wittgenstein in
quella parte del mondo potrebbe risiedere nel fatto che i filosofi si
annoiano facilmente, e che la breve vita di ogni rivoluzione
filosofica (come quelle di Hegel, di Russell, di Bergson o di
Heidegger) copre di solito appena un paio di generazioni accademiche.
Quali che ne siano le ragioni, è certamente vero che ci sono molti
meno corsi di studio dedicati a Wittgenstein in Gran Bretagna e in
America oggi di quanti ve ne fossero trent’anni fa. Nelle regioni
non-anglofone del mondo, però, sembra che Wittgenstein possa
conquistare un posto permanente nel canone filosofico. Filosofi come
Tugendhat e Apel in Germania, Gargani in Italia, Bouveresse e Cometti
in Francia, sono stati profondamente influenzati dalla sua opera.
L’importanza dei suoi scritti è oggi meglio riconosciuta nell’Europa
continentale che oltre Manica o oltre Atlantico. Questo perché i
filosofi dei paesi non anglofoni sono più interessati dei loro
colleghi anglofoni a narrare storie a lungo termine riguardanti lo
sviluppo di problemi semi-tecnici mediante metodi para-scientifici.
Così sono meglio in grado di prendere sul serio l’affermazione di
Wittgenstein, secondo cui i problemi filosofici si dovrebbero
dissolvere anziché risolvere, e che il trattamento di un problema
filosofico è simile al trattamento di una malattia.
Articoli collegati:
Colui che separò il
naturalismo dall'empirismo
Chi può dirsi suo discepolo?
Al gioco del linguaggio
L'andar per funghi e l'arte
della filosofia
Gli usi di un filosofo,
come e perché
i e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti
da fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui
Archivio
Attualita' |