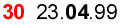


| Guerra/Arkan: 47 candeline per un carnefice
Alberto Nerazzini Articoli collegati
A Belgrado, fare il nome di Zeljko Raznatovic ha sempre scatenato reazioni diverse. Qualche tempo fa, il brillante giornalista Milos Vasic, forse il più conosciuto tra i pochi cronisti indipendenti della capitale jugoslava, con tono lapidario parlava di lui come della "peggior vergogna del popolo serbo". Ma per buona parte di quello stesso popolo, Arkan è sempre rimasto un eroe nazionale, un "grande serbo". C'era anche chi lo difendeva dall'Italia, vantandosi di conoscerlo personalmente. Basti pensare a due celebrità del nostro campionato di calcio, il serbo-croato Sinisa Mihajlovic e il montenegrino Dejan Savicevic. Entrambi hanno sempre approfittato di ogni occasione buona per difenderlo apertamente dalle accuse di genocidio che mezzo mondo gli rivoltava contro. Tutto questo, dicevamo, accadeva solo qualche anno fa. Gli scontri in Bosnia si erano da poco conclusi, e in una cittadina dell'Ohio, Dayton, le parti in conflitto raggiungevano, con la benedizione americana, un accordo di pace.
Arkan era tornato a vivere stabilmente a Belgrado, e dalla pulizia etnica era passato direttamente alla gestione dei suoi mille loschi affari. Da allora molto e forse troppo poco è cambiato. La guerra è tornata nei Balcani, in questa terra dove il risentimento e l'odio etnico sembrano essere stati sempre di casa (anche se questa - può apparire banale, ma è bene ricordarlo - è una guerra diversa). E in tempi come questi si torna a parlare del signor Raznatovic, per tutti Arkan, il comandante delle terribili "Tigri", le truppe paramilitari serbe, mentre nel Kosovo bruciano i villaggi degli albanesi e lunghi fiumi umani, lenti e disperati, valicano i confini macedone e albanese. Dopo otto anni di conflitti, oltre 250 mila morti e migliaia di villaggi divorati dalle fiamme, dalla Croazia alla Bosnia, dalla Bosnia alla Serbia, le immagini di queste settimane ci risultano famigliari. E di questa ennesima tragedia conosciamo già i protagonisti. Ma a Belgrado le centinaia di migliaia di persone che poco più di due anni fa, nell'inverno 1996-1997, manifestavano contro Milosevic sono un ricordo lontano, lontanissimo. Di quella opposizione forte e impressionante, fino a poco tempo fa sfinita, ora non c'è più traccia. Uno dei leader di quelle piazze, Vuk Draskovic, dopo essere passato dalla parte di Milosevic e avere ottenuto la nomina di vice presidente del Consiglio della Federazione jugoslava, non ha perduto la caratteristica aggressività che oggi, però, scaglia contro le bombe della Nato. In questa Belgrado snervata, dove l'effetto coagulante dei missili che arrivano da occidente ha spento le ultime voci indipendenti dal regime e ha riunito un popolo, sabato 17 aprile Arkan festeggia il suo quarantasettesimo compleanno. Quarantasette anni vissuti appieno, durante i quali ha impersonificato mille ruoli diversi: rapinatore di banche, pasticciere, uomo politico, sporco imprenditore, proprietario di una squadra di calcio, prolifico padre di famiglia e, soprattutto, orribile criminale nelle guerre di Bosnia e Croazia.
Figlio di un ufficiale della Jna, l'armata popolare jugoslava, l'ultranazionalista serbo Arkan nasce a Brezica, in Slovenia. Dalla più tenera età mostra un'eccezionale vivacità: ha soltanto nove anni quando scappa di casa per la prima volta e ne ha meno di diciotto quando viene arrestato per la rapina in un bar di Zagabria e conosce il primo di una lunga serie di penitenziari. Negli anni Settanta si aggira per l'Europa, svolgendo attività spionistica per conto dell'Udba, la polizia segreta jugoslava, anche compiendo missioni contro emigrati poco graditi al Partito. In cambio i servizi gli offrono protezione, armi e documenti falsi, tutti mezzi che Arkan sfrutta per la sua carriera di insaziabile rapinatore: in Svezia, in Olanda, in Belgio e anche in Italia, dove è imprigionato a San Vittore e organizza una rivolta nel carcere. Negli anni Ottanta, dopo numerose evasioni, condanne per venticinque anni e un bottino non indifferente, fa ritorno a Belgrado. Acquista una bella casa e diventa rapidamente il leader della tifoseria della Stella Rossa, la Crvena Zvezda, la Signora del calcio jugoslavo. Proprio sugli spalti del Marakana si forma l'Arkan nazionalista: unisce le diverse fazioni in cui sono divisi gli ultrà in nome di Slobodan Milosevic e in dono dalla dirigenza della squadra riceve una pasticceria, che diviene il "covo" dei suoi uomini. Quando inizia la guerra con la Croazia, i vertici jugoslavi pensano a lui per organizzare le milizie di volontari. Volontari che Raznatovic non fatica a reclutare, attingendo tra i tifosi del Marakana e nelle carceri belgradesi, imbottite di criminali comuni in cerca di avventura. Alla fine del 1991 è già il Comandante della Guardia volontaria serba, le addestratissime "Tigri" protagoniste dell'orrore di Vukovar. I già citati Savicevic e Mihajlovic di certo ricorderanno quella giornata del dicembre 1991, quando, reduci dalla vittoria nella Coppa Intercontinentale a Tokyo, ad accogliere i giocatori della Stella Rossa, la loro squadra di allora, all'aeroporto di Belgrado trovano l'"amico" Raznatovic. E da qualche parte, forse, conserveranno ancora il curioso dono, una zolla di terra della Slavonia a testa, ricevuto dalle mani di Arkan con la promessa di "liberarla" tutta. Le "Tigri" rimangono in attività fino all'ultimo giorno di guerra in Bosnia, distinguendosi per le efferatezze gratuite e coordinando le ondate di pulizia etnica a Banja Luka, Sanski Most, Prijedor. Se oggi Arkan è miliardario, lo deve principalmente alla guerra: gli innumerevoli saccheggi, il contrabbando di armi, benzina, armi e sigarette, il traffico della macchine rubate. Tutte fonti delle ricchezze che il Comandante ha sempre ostentato nella sua vita belgradese. Nel giorno del suo compleanno numero quarantasette, per Arkan in realtà da festeggiare non c'è molto. Nei giorni scorsi il procuratore capo del Tribunale dell'Aja, la canadese Louise Arbour, ha finalmente ufficializzato il suo mandato di cattura, rendendo pubblica un'incriminazione per crimini contro l'umanità risalente al 30 settembre del 1997. La Corte dell'Onu aveva deciso di tenere segreti gli atti d'accusa e il mandato nella speranza di facilitare un arresto al di fuori dei confini jugoslavi. Speranza in fondo vana, poiché Raznatovic già da anni non viaggiava all'estero, essendo rincorso da una sfilza di ordini d'arresto dell'Interpol per rapina e omicidio (sono ben 177 le polizie dei Paesi con dossier intitolati a suo nome). Va comunque segnalato che, a differenza del governo di Milosevic, pronto a rifiutare il mandato di arresto per Arkan, lo stesso uomo incriminato ha deciso di contattare il Tribunale per mezzo del suo avvocato, come ha confermato il procuratore Blewitt, annunciando di essere in attesa della deposizione. Ciò non toglie che Raznatovic, in seguito alla pubblicazione del mandato di cattura, che è soprattutto un preciso avvertimento al Presidente jugoslavo, abbia approfittato delle telecamere della Cnn per attaccare la Corte dell'Aja: "È un tribunale politico", ha detto, "appositamente creato in funzione antiserba". Le stesse parole usate nel febbraio 1996, quando furono consegnati all'Aja due alti ufficiali serbo-bosniaci, e Arkan insultò i componenti del Tribunale, "diretti discendenti dei fascisti responsabili del genocidio dei serbi e degli ebrei".
Per quanto riguarda la guerra del Kosovo, di certo Arkan non è stato colto di sorpresa. L'intervento della Nato era diventato inevitabile: lo avevano cercato sia l'intransigenza di Milosevic, sia quella degli americani (lo stesso Henry Kissinger ha criticato Clinton per aver portato a Rambouillet una soluzione inaccettabile per i serbi). E da giorni sui giornali dei Paesi in guerra si susseguono le notizie sul temuto Arkan, che in Kosovo ripeterebbe le schifose azioni di guerra cui ci ha abituato negli anni passati. Proprio in queste ultime ore dal sottosegretario alla Difesa britannico, George Robertson, abbiamo appreso che anche il generale Ratko Mladic, ex comandante dell'esercito serbo-bosniaco, è tornato in attività. Niente di più probabile. Ma rimane la sensazione di un'informazione generalmente precaria e faticosa, anche da questa parte. E con ciò non intendiamo fare alcun paragone con la tremenda propaganda, o meglio disinformazione che Milosevic ha organizzato nel suo Paese (siamo poi così sicuri che i serbi di Belgrado non siano a conoscenza di ciò che sta succedendo in Kosovo? Alcuni degli interlocutori di Santoro, l'altra sera, dal ponte Brankov citavano la Cnn e i quotidiani stranieri. Il meccanismo complesso messo in moto dal Presidente jugoslavo è piuttosto ancora frutto della disinformazione pre-bellica che ha caratterizzato la fine degli anni Ottanta e di cui Paolo Rumiz parla nel suo Maschere per un massacro, Editori Riuniti, 1996). Arkan ovviamente nega di essere presente in Kosovo, né di avere inviato i suoi uomini. Le smentite, più che altro di tipo sentimentale, arrivano per mezzo del suo portavoce e socio in affari, il molisano Giovanni Di Stefano, detto Johnny, raggiunto telefonicamente a Bruxelles, dove, in veste di rappresentante del governo dell'"amico Milosevic", lavora per una soluzione politica del conflitto: "Arkan non si è mai spostato da Belgrado. Non ucciderebbe mai un albanese del Kosovo", giura Di Stefano, "è profondamente legato a quella terra e a quella gente. La stessa madre di Arkan è di Pristina, la città che nel 1992 lo ha eletto come indipendente nel Parlamento jugoslavo" (il partito di Raznatovic e Di Stefano, l'Ssj, Partito dell'unità serba, oggi conta solo 3 deputati montenegrini). Johnny Di Stefano è anche vicepresidente della squadra di calcio Campione di Jugoslavia Obilic Belgrado, acquistata tre anni fa da Raznatovic. Nelle partite giocate in Europa è stata la moglie e presidente del team Ceca a seguire l'Obilic, appunto perché Arkan è stato costretto a restare a Belgrado per evitare un arresto. E il fatto che il nome della squadra, intitolata all'eroe serbo Milos Obilic - che, per la tradizione, sul Kosovo polje, nel 1389, uccise il sultano turco Murad I - testimonierebbe ancora una volta l'amore di Arkan per quella terra, "culla" della Serbia. Ragioni sentimentali a parte, rimane la tragedia di un popolo. E potrebbe anche essere come Arkan vuole farci credere, cioè che le sue truppe non siano ancora entrate in azione. Anche perché, come ha detto qualcuno, oggi Raznatovic è "il principale prodotto serbo di esportazione giornalistica": riempie le pagine dei giornali, con la sua miscela di terrore e folklore. È stato scritto molto. Per esempio che può contare su 30 mila uomini, quando le "Tigri" di oggi non sarebbero più di mezzo migliaio. Uomini comunque pronti a combattere in caso di un intervento di terra, mentre per le espulsioni e la pulizia etnica possono bastare i regolari dell'esercito federale. Ciò che è certo è che, anche tra "effetti collaterali" e "profondi rammarici", questa guerra deve continuare e non sarà pulita, come ha dichiarato il ministro degli Esteri statunitense Cohen. E per il tanto atteso epilogo della storia del criminale Arkan bisogna attendere la caduta di Slobodan Milosevic.
Articoli collegati
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui
|



| Home | Rassegna italiana | Rassegna estera | Editoriale | Attualita' | Dossier |Reset Online |Libri |Cinema | Costume | Posta del cuore | Immagini | Nuovi media |Archivi | A domicilio | Scriveteci | Chi siamo |



