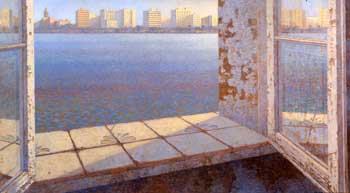La luce è la luce è la luce
Maurizio Fagiolo dell’Arco
Articoli collegati:
Giuseppe Modica a Mazara
del Vallo
Chi è Giuseppe Modica
La luce è la luce è la
luce
PRIMAVERA 2002
Ritorno al paese avito
Alla ricerca della pittura, una domenica mattina. Lo studio di
Giuseppe Modica è in via dei SS. Quattro. Il taxi mi lascia vicino
a quel Moby Dick colossale che è il Colosseo (ci sono voluti secoli
per scarnificare la grande balena, ma ancora resiste), sorpasso la
Hostaria al Gladiatore e l’ufficio delle tasse, costeggio posti
nuovissimi (locali alternativi, la danza del ventre), entro nella
chiesa di San Clemente a rivedere la più incredibile pinacoteca di
pittura settecentesca romana (è chiusa la cripta, dove si trova il
primo documento di lingua volgare italiana), vedo da lontano la
chiesa dei Santi Quattro Coronati dove si cela uno dei dipinti più
sensualmente berniniani del Baciccio (le monache di clausura non mi
fanno entrare). E sono al numero 31, dove al secondo piano mi
aspetta il vecchio amico Beppe. Mi saluta dal ballatoio.
L’ho un po’ trascurato nel mio recente periodo barocco. Ha
dipinto molto in questo ultimo tempo, e devo vedere tutti i quadri
dai quali questa monografia deve partire.
Le stanzette in via dei SS. Quattro sono piccole, lo studio non è
diverso da quando in quello spazio viveva una piccola famiglia. Ma
lo spazio è rischiarato dai quadri. Tanto, il lavoro di tre anni,
che ho visto in qualche fiera di Bologna o in sporadiche occasioni,
ma che riesco a vedere oggi nella giusta sequenza. Una dozzina di
quadri grandi e impegnati che nell’azzurro del cielo-mare
ripropongono i problemi di sempre: la divina proporzione, la
metafisica della luce, il fascino dell’assenza, lo spessore della
memoria...
Vedo molti quadri, e alla fine ne scelgo nove, per introdurre il
lettore nella pittura recente del mio campione: nove come le muse,
un numero perfetto. Non ci sono sobbalzi di qualità nella pittura
recente di Modica, perché la precisione dell’immagine si unisce
alla sicurezza della tecnica. E allora, ecco un flash su quei nove
quadri che ho allineato nella mia ideale antologia.
Compenetrazione-visione (salina), 1999. Un quadro che vede affiorare
il mare, con le saline, da una vecchia finestra decentrata. Mal
verniciata quella finestra, vecchia e scrostata, che riflette l’interno
sommato all’esterno, presentandosi come una soglia o meglio un
diaframma; uno schermo che sa catturare l’assenza di diverse
presenze. Un tema sperimentale risolto con geometrica severità,
cangiando il vetro in specchio, modificando la piatta visione in uno
sfaccettato cristallo.
Luci della notte (finestra), 1999. Qui la sorpresa è determinata
dal formato dell’opera: molto allungata, quasi tre quadrati in
altezza, si presenta come uno squarcio di cielo più che come un
quadro. La rappresentazione è semplice: una porta-finestra che si
apre sulle luci inquietanti di una notte mediterranea. La solita
visione decentrata spinge l’occhio dello spettatore a cercare un
centro, un asse che il pittore non ha voluto indicare. Il quadro
sollecita, quindi, il suo spettatore a completare mentalmente il
quadro, e allargarlo sulla sinistra o immaginarlo più esteso verso
l’alto. Un gioco che ferma l’attimo in un frammento di universo.
Compenetrazione-visione, 2000. Questa è una tavola, e la pittura
diventa precisa come in un maestro pierfrancescano. La
porta-finestra, stavolta, si apre su un interno, con le ceramiche
sbreccate di Caltagirone, ma riflette nel suo corpo il miraggio
della pianura e dell’acropoli. Un quadro cattura antiche
suggestioni (la finestra di Balla), il confronto con il tempio (dechirichiano)
e la dannazione moderna della città. Nei due quadrati verticali, si
rispecchia l’icona dello spazio e del tempo.
Luci della notte (immersione ed emersione dello sguardo), 2000. L’aveva
detto Leonardo Sciascia quindici anni fa che nello stesso quadro
Modica sembra far muovere la luce, cambiare l’ora e la stagione. E
qui l’esperimento si può controllare a colpo d’occhio: il
régard di Modica diventa filmico e non più soltanto pittorico: il
quadro è la pellicola impressionata da un lunghissimo
piano-sequenza alla Godard che viene inchiodato nel tempo fermo
della tavola di superficie. Mistero di una visione ottenuta per
somma di visioni, ma anche per sottrazione di memoria.
Quasi lo “Spasimo”, 2000-2001. Qui l’interno nell’esterno
(ricordate il metafisico?) diventa leggenda. L’antica chiesa
siciliana (lo Spasimo) si dissolve nella chiesa senese (San
Galgano), tanto per dire che Isola e Continente slittano come slides
intelligenti. L’albero si somma all’architettura, il pavimento a
mattonelle si rispecchia nel blu del cielo. Quadri come questi danno
il senso di un lungo viaggio che non è mai avvenuto o meglio si è
verificato tutto nella stanza della memoria. Viene alla mente l’eroe
di de Chirico che rema sulla sua barchetta, nel mare increspato che
si colloca sul parquet della sua stanza borghese. Ha scritto un
giorno Modica: “La realtà che viaggia dal qui presente alla sua
rifrazione speculare per poi ritornare a noi acquista il fascino del
viaggio e del percorso (la realtà ci viene restituita attraverso l’avventura
del tempo e lo spiazzamento della rifrazione)...”.
Sole, 2001. Il solito quadro verticale, composto di due quadrati:
una striscia di cielo. E stavolta c’è il sole sul sale. Pellizza
da Volpedo rischiara il balcone del suo amico Balla. Sono i
protettori della pittura d’un divisionista del Duemila, l’operazione
colorata e netta del movimento del tempo fermo. L’enigma dell’ora
svaria nella malinconia d’una bella giornata.
L’albero nella cava, 2001. L’avrà dipinta venti volte Modica,
questa cava, che somiglia a una visione lontana di Manhattan. L’albero
si sovrappone al paesaggio moderno in una visione sovrumana, troppo
disumana.
Lo sguardo di Medusa, 2001. Quell’occhio in primo piano (ricordate
il metafisico? “Bisogna scoprire l’occhio in ogni cosa”)
vigila lo sfondo del mare e la stereometria delle saline, ritrovando
l’enigma del faro e del sole. Il riflesso di un riflesso di un
riflesso.
Luci della notte (inseguire la pittura), 1999-2000. E questo è un
punto d’arrivo. Un quadro quasi quadrato, di formato monumentale,
che inquadra una porta finestra divisa in dodici riquadri: le ore
del giorno o i mesi dell’anno si riflettono sulla tela luminosa.
Nei vetri (appannati o scheggiati) si riflettono tutte le qualità
della luce: la luna, la lampadina che si rispecchia dall’interno,
il tramonto, un fuoco enigmatico, la luna, le lampare, le luci sul
molo. Ancora una casistica di riflessi e di tecnica. Per Modica si
tratta di un punto d’arrivo, ma anche di un nuovo punto di
partenza: complesso e misterioso.
Non è facile definire il valore che la luce assume in Modica. Forse
si può comprendere soltanto con la sua tautologia. Ricordate
Gertrude Stein? “Una rosa è una rosa è una rosa”. Allo stesso
modo, si potrebbe dire per il lavoro degli ultimi dieci anni di
questo pittore mediterraneo: la luce è la luce è la luce.
AUTUNNO 1972
Preistoria di un pittore
Sono apparsi in questi trent’anni, a proposito della pittura di
Modica, decine di cataloghi, più o meno lussuosi, qualche libro,
plaquettes raffinate. Molti, moltissimi si sono accorti di questo
pittore che grida il suo silenzio. Critici e letterati ci hanno
condotto pazientemente nel suo labirinto, con fili d’Arianna
efficaci e sofisticati. Eppure, sono ancora avvolti nelle brume gli
inizi di Modica. Sembra incredibile, ma alcuni vengono qui svelati
per la prima volta: forse perché Modica è riservato almeno quanto
è cocciutamente silenzioso!
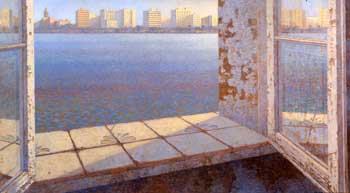
Lo sguardo circolare - la città in orizzontale
-1999
olio su tela, cm. 100x180
Ha trovato però qualcuno più cocciuto di lui, in
questo particolare settore.Quali sono gli inizi di un artista? quali
orizzonti ha conosciuto? quale è stata la sua infanzia? E già,
oggi sembra facile affermare che questo metodo appartiene allo
psicanalista; da parte mia ho imparato a praticarlo sul corpo della
pittura metafisica, accorgendomi che, senza approfondire la “tragedia
dell’infanzia”, non avrei mai capito Savinio, senza comprendere
l’“infanzia tenebrosa” non avrei mai stanato de Chirico, senza
afferrare il senso degli studi dechirichiani al Politecnico, non
avrei mai compreso l’enigma della Metafisica.
E allora, ecco il risultato di quelle inchieste condotte in
occasione di questo libro. Modica ha lasciato Mazara del Vallo per
trasferirsi a Palermo: a 19 anni, è una matricola della facoltà di
architettura. Un anno dopo, un gruppo di amici decide di trasferirsi
nel Continente (non sembra un racconto pirandelliano?) e Modica
decide di seguirli, tanto più che vanno a Firenze. E lui non cerca
altra verità che quella dei musei, altra vita che quella delle
architetture e dei quadri. Ecco che cosa significa per un ventenne
con gli occhi pieni di luce la scelta di una città (Firenze); e poi
di un’altra, definitiva (Roma).
A Firenze, Modica si iscrive alla facoltà di Architettura dove
studia tre anni: non sono pochi gli esami e non sono senza
significato le materie scelte: tutti esami che hanno a che fare non
con la parte tecnica ma con il versante più storico (artistico)
dell’architettura; e sono ben venti. Abbiamo ritrovato in fondo
all’ultimo cassetto dello studio una interessante tesina, sul
problema spaziale, etnico, topologico del fico d’India: il
sottotitolo della tesina potrebbe essere utilizzato anche per i
quadri dipinti oggi (“Riduzione analitica tra presenza e assenza”).
Poi arriva la decisione forse maturata a lungo: l’iscrizione all’Accademia
di Belle Arti, a Firenze, là dove le file di giapponesi assediano
il marciapiede per consumare con gli occhi il David di Michelangelo.
Segue regolarmente i corsi di pittura fino al diploma che arriva nel
1978, a venticinque anni. Il docente che Modica ricorda ancora con
affetto e rispetto è il suo professore di pittura, Gustavo
Giulietti, di origine siciliana: gli comunica soprattutto l’amore
per le tecniche e la perizia esecutiva della pittura.
Intanto è iniziata la vicenda pubblica della pittura. La prima
mostra è in un locale del Comune di Mazara del Vallo nel gennaio
1973; la seconda nel giugno dello stesso anno, nel “Club Famiglia
Trapanese” di Palermo. Modica sta per compiere vent’anni. A
Firenze, la prima mostra personale arriva soltanto nella primavera
1976, ed è nella Galleria La Stufa in via Cavour. La pittura di
questi anni è orientata (stavo per dire disorientata) tra
oggettività, astrattismo, new dada, concettualismo, iperrealismo.
“Presentare un giovane (scrive Elvio Natali nella presentazione
della mostra del 1976) ancora sprovvisto di una documentazione
critica di rilievo ha il sapore dell’avventura”. Ma il critico
parlava già di “metafisica” e di “personaggi (ovviamente
pirandelliani). La luce mette a fuoco l’oggetto in questi quadri
che vedono comporsi le varie presenze in Situazioni (questi sono i
titoli seguiti da un numero che il pittore assegna ai quadri
esposti).
M.F.d’A. Ma come facevi a sopravvivere, un mazarese a Firenze?
G.M. All’inizio, vivevo con piccoli aiuti della mia famiglia, che
ho cessato di chiedere quando ho completato gli studi all’Accademia.
Ero però molto fortunato. Un gallerista di Firenze, Raffaello
Banchelli, mi acquistava un quadro al mese per 250.000 lire, e poi
venne negli anni seguenti un gallerista di Colonia (Herbert Reich
che ancora mi segue) che mi acquistava una tela 50x70 ogni mese per
500.000 lire.
M.F.d’A. E quali sono i pittori che amavi o frequentavi?
G.M. Ricordo la pittura di Silvio Loffredo e Piero Vignozzi (ricordo
anche la pittura del decennio precedente di Fernando Farulli). E,
tra gli astratti fiorentini, seguivo Gualtiero Nativi e Vinicio
Berti. E poi c’era Adriana Pincherle, molto più anziana di me che
era una nostra buona amica. Mi ricordo che le tenni piccoli corsi di
incisione, una tecnica che praticavo anche per sopravvivere. Insomma
non me la cavavo troppo male.
In una mostra collettiva che si tiene a Pistoia, L’altra
realtà (1982), Pier Carlo Santini scrive una paginetta profetica su
questa pittura (caro Pier Carlo, un pancione e un sigaro al primo
sguardo, un cervello instancabile dopo il primo scambio di idee).
Il più giovane del gruppo, Giuseppe Modica, esce dall’Accademia
di Firenze appena tre anni fa, con una vocazione però manifestatasi
assai precocemente. Le opere degli ultimi due anni, pur tesorizzando
le esperienze anteriori, si discostano da quelle tensioni che
caratterizzano i grandi quadri precedenti con scene incombenti
traversate da strutture contrapposte che proiettano ombre cupe,
drammatiche. C’è qui il senso di desolazione che ci prende di
fronte alla città lacerata, ridotta a un cantiere; e questo
abbandonato, deserto. Anche Modica compone e ordina le sue “allegorie
del tempo”, come lui stesso le chiama, per pochi elementi
immediatamente percepibili, chiaramente connessi, isolati.
Questa riduzione, ovviamente, accresce ed esalta il valore degli
episodi, indipendentemente dalla loro consistenza dimensionale.
Anziché cercare l’evidenza illusiva delle forme, per renderle
più pregnanti e aggressive, Modica le semplifica, le spoglia di
fisicità, le depura. Le sue fonti, tra cui, ancora, è da
considerare la fotografia, possono trovarsi nella miriade delle
immagini che incontriamo un po’ dovunque, su cui poi l’artista
compirà le sue scelte e il suo giudizio.
Nello stesso anno, la Galleria La Soffitta (Casa del Popolo,
Colonnata a Sesto Fiorentino) ospita una mostra personale presentata
da Renzo Federici, un curioso della pittura, che scrive altri
spiccioli di profezia. Modica ha quasi trent’anni.
Si direbbe, il suo, un mondo di desolazione urbana, di angoli
oscuri e dissestati, nei quali la vita intera sembra sintonizzata
sulla cadenza lentissima e spietata dei tarli, sul passo felpato e
cieco delle talpe o delle muffe. Dove nulla può più muoversi se
non secondo un disegno larvale e tardo, ma che certamente si
compirà. Qualcosa come una contaminazione tra vecchio film parigino
e crudele fotogramma di fotografo realista americano.
Già la luce in questi quadri è sempre notturna, o meglio di quel
crepuscolo o tardo pomeriggio che negli anfratti della città arriva
presto e dura lunghissimo, scolorito e immoto, come una privazione o
una condanna. E non ha riverberi o sussulti: è quieto e opaco,
calando come un bagno sordido, un fall-out da cui non ci si salva, e
installandosi perpetuo. Anziché esaltare le cose, o almeno i loro
contorni estremi, e certe loro materie umbratili, scivola su di
esse, le avvolge di una mucillagine tremolante, fino ad intaccarne l’oggettiva
consistenza, il positivo vigore. E se certe apparenze s’allentano
entro a questo vischio, altre ne risultano come risecchite e
volatilizzate in un arido polverìo.
Poi gli orizzonti si allargano per Modica. Lo troviamo più di
frequente, nel quartiere popolare del Celio, a un tiro di schioppo
dal Colosseo: lo accoglie una modesta pensione in via dei Santi
Quattro, insieme alla compagna Carla che ha conosciuto nella mostra
presso la Galleria La Stufa. Modica continua a nutrirsi di pittura
nei musei, e ora anche nelle mostre d’arte: ma ogni estate, per
lunghi mesi, ritorna nel suo paese natale a fare il pieno di luce.

Lo sguardo circolare. Agrigento -1999
olio su tela, cm. 100x200
ESTATE 1983
La luce ritrovata
Tra il 1983 e il 1990, la pittura di Modica sboccia alla luce.
Affiorano i motivi che sono ancora oggi presenti nei suoi quadri, lo
affiancano alcuni critici e scrittori che ancora oggi lo amano,
viene anche qualche modesto successo dal quale però il prudente
pittore riesce a difendersi. In una mostra che si tiene nell’estate
1984 nella Pinacoteca Comunale di Saponara (un paese vicino a
Messina) appaiono, nella trama dell’iperrealismo, le visioni di un
nuovo Modica. Alcuni motivi come la vetrina con il riflesso solido
del mare, oppure le onde che si riflettono nel cielo, presenti in
alcuni quadri del 1983, li ritroveremo nel lavoro di vent’anni.
In catalogo si leggono alcuni Appunti di lavoro firmati dal pittore.
Le parole sembrano bilanciare il peso delle immagini: Savinio e la
memoria, la metafisica e il mito. Un nuovo start, per un pittore
trentenne.
Scoprire e rivelare non è solamente compito dell’archeologo, che
spesso analizza ed entra scientificamente nella storia per trovare i
precisi connotati dell’epoca e del tempo [...]
Così ora individua il presente e il plumbeo trascorerre del
quotidiano e contemporaneamente il mito, la proiezione fantastica
che ad esso (il quotidiano) sono legati in chiave dialettica. [...]
Dal profondo del tempo, ovvero dello “spazio del tempo” emerge
la memoria. [...]
Le immagini vengono messe a fuoco dalla ragione la quale
contribuisce a rendere trasparente e chiaro, a portare in superficie
(concetto caro a Savinio), alla luce questi elementi nascosti e
dispersi nelle acque torbide della nostra memoria.
Un pittore siciliano lo appoggia proprio mentre Modica sta per
affrontare il “salto vitale” a Roma. Bruno Caruso presenta la
nuova pittura di Modica in una mostra a Roma (Galleria Incontro d’Arte
1985) replicata a Palermo (Galleria La Tavolozza 1986). Parla di un
mondo sul quale avverte l’incombere di una catastrofe: riesce a
leggere nella pace quotidiana della veduta l’incubo della visione.
I luoghi eletti di quest’artista singolare, apparentemente
sfolgoranti di luce pareva fossero stati improvvisamente oscurati da
un’eclisse parziale che ne aveva sfocati i contorni, così che le
due situazioni di luce e di ombra finivano per coesistere nella
visione totale dei suoi quadri: con la debita conseguenza di
provocare un’atmosfera irreale ed inquietante carica di quell’elettricità
che abitualmente precede i cataclismi. [...] Ma guardando con
attenzione quei luoghi ci si accorge che altri non sono che i luoghi
della nostra vita quotidiana, forse troppo crudelmente spogliati e
mascherati dei camuffamenti delle convenienze e delle illusioni. E
velati da una nebbiolina che nella realtà potrebbe apparire persino
irreale (e che potremmo chiamare foschia, caligine o riverbero), ma
che nella metafora ci appare densa di avvertimenti.
È indispensabile citare a questo punto un breve articolo apparso
sul “Corriere della Sera” a firma Leonardo Sciascia (26 febbraio
1986). “Pittore per letterati”, Modica inizia con la conquista
proprio del più grande; il simbolo quasi di quella Sicilia
orgogliosa e gattopardesca che non si ritiene inferiore a nessuno.
Si legge in questa pagina illuminata, una felice intuizione sulla
mutazione della luce all’interno dello stesso quadro: è
certamente una metafora letteraria, ma è anche una nuova verità
per l’analisi inquieta di Giuseppe Modica.
Nelle fantasie di Modica, enormi pietre squadrate emergono dal mare
di Mazara a formare fantasmagoriche cale, rifugi non rassicuranti:
tutte non si sa se disegnate dalla corrosione dell’acqua o se dall’acqua
cancellate - e ne resta qualche traccia - dei rilievi, delle figure
e decorazioni che in tempi immemorabili recavano. Alcune sono
sovrastate dalle cupole rosse di San Giovanni degli Eremiti, altre
da presentimenti di giardini, di agrumeti. I tempi slittano, si
intersecano, trovano rispondenze, trasparenze, fusioni. In uno
stesso quadro, la luce dà l’illusione di mutare, di star mutando:
e che ne ricevano la vicenda i colori, le forme. Grande
sensibilità, grande perizia.
L’anno dopo, la pittura geologica di Modica, il suo enigma marino,
conquista un vecchio innamorato della pittura, il mio amico Marcello
Venturoli (Galleria Incontro d’arte, maggio 1987). Già il titolo
della presentazione rivela un destino: “Dipingere il tempo”. E
poi Venturoli coglie alla perfezione i suoi punti di riferimento nel
“realismo magico” e nella “metafisica”; e infine riesce a
avvertire nel futuro del pittore una intenzione “più ‘astratta’
e pura”.
Non è pittore limitato e limitante, se la sua area di elaborazione
è volta verso gli esempi che ho detto, incombe sulla sua pittura la
nobile aura del Museo, quel far classico, che ha sovente esercitato
nei pittori di ieri una pressione negativa, e in quelli di oggi
quasi uno sgomento, specie quando questi non si piegano agli
svolazzi e ai chiaroscuri, alle calligrafie e alle simmetrie degli
“anacronisti”. [...] Si tratta di una pittura minuta eppure
trasparente, fuori dalle larghezze di imbastitura di chi si è
formato sugli impressionisti, eppure armoniosa nel tono, solitamente
fra gli ocra e gli azzurri come se il quadro fosse stato vissuto dal
principio alla fine non sub specie grafica ma cromatica.
Ancora un anno, ed è destinato ad arrivare il paladino di ogni
metafisica: Vittorio Sgarbi, ferrarese (tutti i ferraresi sono matti
o geniali, certificò Giorgio de Chirico). Presenta la mostra
organizzata dalla Galleria La Tavolozza (Palermo febbraio 1989) con
un titolo, L’ammodicazione del sogno, matto o geniale come lui.
È difficile sottrarsi al fascino dei suoi quadri azzurri e
infiniti, perché lui insiste su diversi luoghi comuni della nostra
psicologia e della nostra cultura: il risultato mantiene un
carattere di profonda originalità. Certo noi vediamo ciò che
sappiamo, ma la forza dell’arte è la conservazione dello stupore
del quotidiano, della capacità di meraviglia, principio maturato
nell’estetica barocca: “è del poeta il fin la meraviglia”.
Noi restiamo stupiti di fronte ai risultati di Modica. Anche se la
meraviglia non è nell’eccesso, nella mostruosità, nelle
deformazioni. Dunque Modica passa indenne attraverso il mito del
sogno, della luce mediterranea, della metafisica, del surrealismo.
Guardiamo e troviamo un mondo che in qualche modo ci appartiene:
anche la classicità della Sicilia, la tradizione della Magna
Grecia, i templi, il mare, e poi perfino gli ammiccamenti alle mode
letterarie incrociati con il fascino delle proprie antiche radici.
In un dipinto come la Terrazza di Pessoa vediamo un balcone sul mare
con le piastrelle sbrecciate come sarebbe, come è, in un palazzo di
Palermo, in una gattopardesca dimora. Ciò che preme a Modica è
evocare, alludere a un intero mondo con limpidi frammenti di
visione, smuovere stratificazioni di pensieri, ed emozioni sepolte,
o forse mai a noi appartenute, ma che egli ci fa credere nostre.
Lo vogliamo dire? Ormai les jeux sont fait. Un pittore ha
conquistato un suo microcosmo e soprattutto ha intuito come
dipingerlo; d’altra parte (difficile che le due cose vadano
insieme), un pittore ha trovato qualcuno che lo capisce, e anzi una
critica molto ricettiva e autorevole. Dal 1985 lo seguo anch’io,
ma i tempi non sono maturi perché parli del suo lavoro.
AUTUNNO 1991: INTERMEZZO
Le stanze inquiete
Il testo che segue accompagnava una mostra antologica che si è
tenuta a Aosta, Giuseppe Modica. Le stanze inquiete, Tour Fromage,
12 ottobre 1991-12 gennaio 1992. L’ha voluta Janus, ed era
accompagnata da un ermetico repertorio di simboli costruito da
Modica sulla falsariga del mio dizionarietto.
Un pittore che dipinge pittoricamente. Una tela trasparente e
luminosa che cattura alcuni luoghi e alcuni oggetti della memoria o
della cultura. Una operazione di pura pittura che si appoggia a uno
spazio particolare (la Sicilia) e a un tempo particolare (la
memoria). Una pittura che ha qualche parente (de Chirico e Savinio)
e qualche avo (Piero della Francesca, Seurat). Un uomo paziente, che
sa ridare al tempo il suo giusto significato (orientale, islamico) e
allo spazio il suo giusto luogo (quell’isola come inconscio
privato e collettivo).
Ho conosciuto Modica attraverso Bruno Caruso. Era nel 1985: quel
pittore di spazi prospettici deformati, di accentuazione coloristica
e formale mi sembrava ancora alla ricerca d’una sua sigla. Ho
accettato di scrivere per la sua pittura nell’estate scorsa. E
nello spazio di pochi mesi ho visto chiarirsi la sua pittura fino
alla perfezione attuale. Un ricercatore, quindi, di idee e di
accostamenti giusti, divenuto pittore di pittura.
Quelle forme e quegli oggetti esibiti sulla tela, quei luoghi e
quegli spazi si sono rifusi nel lavoro pittorico. E mi dànno oggi
lo spunto per un dizionarietto pittorico. Nove lemmi, tanto per non
chiudere il discorso, ma per lasciare i problemi quello che sono:
problemi. Come tanti altri nel passato e pochi nel presente, Modica
continua a domandarsi il perché delle cose finché queste ci
saranno; e continua a fare pittura proprio perché continua a
domandarsi il perché delle cose...
ARTIFICIALE Arte fatta ad arte, e quindi artificio. Un microcosmo
coniugato al passato. Il quadro di oggi si rispecchia nella tela di
Savinio e de Chirico, ma anche nel muro di Piero o nella tavola del
Giambellino. Tutto è vero, ma tutto diventa finto, coniugato al
passato o proiettato sul futuro. L'obiettivo dell’arte rimane, con
tutti i suoi codici misteriosi, l’arte stessa.
In una serie di quadri, una donna è una statua o ricalca l’orizzonte
di un’isola lontana. In un’altra serie, una cava sicula si
rispecchia in un baratro, o si identifica con un bagno misterioso.
Accanto al paesaggio (antico), c'è sempre un oggetto (di oggi) che
raggruma l'immenso in un attimo di forma.
GEOMETRIA Ha avuto un periodo iper-realista, Modica; e ne ha avuto
un altro astratto-geometrico. Anche a non saperlo, risulterebbe
chiaro davanti a un gruppo di quadri 1991. Chiaro e distinto,
scompartito e ripartito. Il cielo e il mare e la terra; ma anche le
quinte e gli spaccati e il fondale. Precisione e geometria (araba,
forse). L'edificio, che più volte appare nei quadri recenti,
somiglia a quell'antico tempio palermitano in cui arrivano a
coniugarsi il cubo con la sfera. Anche la geometria viene ritrovata
nel tempo della memoria.
LUCE Luce diffusa, luce proiettata, luce fredda e calda, luce-colore
e colore-luce. La luce affocata del deserto, e quella opaca della
tempesta. Tramonto e alba, crepuscolo e mezza luce. Proiezione e
luce allo specchio... Tutte le possibilità della sorgente luminosa,
troviamo esplorate in un quadro di Modica. Luce fiamminga e luce
olandese, luce di Antonello e luminosità di Piero della Francesca;
luce tendente allo scuro di Stomer e luce tendente al chiaro di
Vermeer. La luce della luce della luce ...
MEMORIA Avere una terra per memoria: idea lontana di Mazara del
Vallo. Il frutto e il fiore: zagare e lumie, fichi d’india.
Tornare a un luogo dove ritrovano un nome e cognome la dialettica
eterna della vita (Luigi Pirandello) e la pittura plastica e
chiaroscurata (Antonello da Messina, Caravaggio) la scultura
virtuosistica (Serpotta)... Lo spirito arabo si accavalla a quello
romano-imperiale. 1 dolci sono troppo dolci, i profumi troppo
profumati, le passioni troppo appassionate, la pittura
esageratamente pittorica. In quell’idea affocata (di Africa
desiderata) perfino il Colosseo che è a tre passi dallo studio di
Modica perde il connotato di romanità per diventare una ossessione
mediterranea...
MOBILI (NELLA VALLE) Il mobile è uno dei primi appoggi mentali
nella vicenda dell'infanzia: è un personaggio e un teatrino allo
stesso tempo. Chissà che anche nell’inconscio di Modica non ci
sia un terremoto come in quello del Metafisico? L’idea che un
frammento normale trasportato fuori del suo contesto arrivi a
diventare soggetto e non più oggetto. Il comò o il tavolino di
Modica si compongono negli specchi (rappresentati o mentali) come
modesta presenza vitale a confronto con la eternità della natura. E
con la sua cattiveria.
Il mobile accanto alle lastre dismesse del pavimento a ceramiche di
Caltagirone è povero, umano troppo umano. Ma è pur sempre a
confronto col cielo più azzurro e con la terra più ocra, col mare
più indaco e con gli intonaci affocati dal sole o dorati... Il
mobile rappresenta, a dire la verità, tutto l’ottocento che si
nasconde dietro a quel duemila che il pittore vorrebbe affrontare
sulla sua tela. E un personaggio che ha trovato il suo autore:
pirandellianamente.
NATURA MORTA Ovvero “vita silente” come volle chiamarla più di
mezzo secolo fa Giorgio de Chirico (come in inglese o in tedesco).
Le cose non sono morte ma quanto mai vitali: sono un rappel alla
memoria. Un segnale della deperibilità (vanitas vanitatum), ma
anche un brandello di eterno...
E il pittore si mette davanti a un frutto o una cosa, ambientandola
in un paesaggio, come nel primo mattino del mondo, ponendosi in
quell’enigmatico atteggiamento che si chiama creazione. Dipingere
un frutto nel suo corpo sensuale, designare l’ora attraverso l’ombra,
collocarlo nell’effimero quasi eterno del paesaggio: ecco lo scavo
a vista che si intravede in un quadro di Modica.
Oggetti che si somigliano, collocati in uno spazio che è quasi
sempre lo stesso. Per dire che forse il viaggio non è mai accaduto,
che è solo un surplace sulla memoria. Ha detto Mario Mafai mezzo
secolo fa: “Scoprire la realtà, accettare la realtà, impegnarsi
a non modificare la realtà. E nei confini della realtà trovare
ancora da illudersi, da sognare”.
SICILITUDINE Il bello di avere un paese è che, almeno, puoi
fuggirne via, aveva più o meno scritto Cesare Pavese. Dopo le orge
di internazionalismi, si è capito che le radici sono un fattore
positivo nella vita di un artista. Un paese è la scena dei primi
ricordi, è il palcoscenico del Rimosso; quasi il telone bianco. sul
quale si proietta la tragedia dell’infanzia.
Un paese come la Sicilia è doppiamente importante. Isola significa
“isolarsi”, e allora, “Sicilia”,può anche diventare il
doppio della ricerca, la metafora della riflessione e del pensiero.
È stato Leonardo Sciascia a parlare di “sicilitudine” nel bel
libro dedicato agli scrittori e cose della Sicilia intitolato La
corda pazza. E anche un pittore attivo nel 1991, può rifarsi a quel
vero continente percorso da tutti i popoli della terra, “sequestrato”
per alcuni, europeo per altri.
Emergono nei quadri di questa mostra l’orizzonte incerto di cielo
e mare, l’azzurro e il sabbioso, la spartizione della salina e il
vaso di coccio di Caltagirone, il blocco terreo della cava di tufo.
(“Vuote le mani, ma pieni gli occhi del ricordo di lei”, scrisse
l’esule Ibn Hamdis, citato da Sciascia). Ma attenzione, non sono
soltanto frammenti d’una propria vita vissuta, sono la parafrasi
di quello che sempre è stata la pittura.
Una volta hanno chiesto a Giorgio de Chirico se i suoi cavalli o i
suoi archeologi fossero un discorso classico, e de Chirico rispose
che no, che erano frammenti della sua Grecia e quindi semplicemente
della sua vita. Tutta qui la “sicilitudine” di Modica: quei
luoghi e quegli oggetti accuratamente esibiti sulla tela sono nient’altro
che l’esca della sua memoria, le spie del piccolo mondo conosciuto
al quale si aggrappa, sono il passato del suo presente.

La luce il giorno dopo -1999
cm. 160x120, olio su tavola
SPECCHIO Guardo La stanza dell’inquietudine
dipinto nel 1989. Su una parete, che è un mezzo fondale, è
poggiato un tavolo con uno specchio. In quello specchio si raddoppia
il nostro spazio: rispecchia un altro pavimento, uno stipite e il
mare all’orizzonte. Sulla destra, si prolunga la veranda verso un
mare: che è uno specchio. L’azzurro diffuso si placa come in uno
specchio, oscuramente. Il pittore ricava abilmente un quadro nel
quadro: un’altra rappresentazione che raddoppia il doppio.
E il quadro è tutto lì. In quella slittante presenza di una
assenza. Nell’enigma del non detto (ma rappresentato due volte).
In quei frammenti di mondo che, ritrovandosi, si perdono per sempre.
TECNICA Mi accosto a un quadro, Colosseo II, notando la liquidità
del fondo e la trasparenza dell’insieme. Modica mi chiarisce: “Volevo
accentuare il senso del pulviscolo atmosferico, quasi l’idea della
polvere sul lastricato, e quindi l’olio (essendo denso e corposo)
non si prestava. Allora ho cercato una materia diluita con l’acqua
trasparente che, raggrumandosi in una maniera irregolare (anche a
caso) potesse duplicare l’evento. Poi ho congelato questa materia
con un medium a base di cera, resina e trementina. Poi ho portato il
lavoro a compimento con successive velature”.
Non sembra di tornare indietro di settant’anni, e di trovarsi
nella bottega del Metafisico? Labor-oratorium.
ANNI NOVANTA
dieci anni di solitudine
La pittura di Modica si è conquistata in questo decennio un suo
circoscritto ma preciso luogo nella cultura pittorica italiana: un
pittore, come si dice con orribile termine del quale non conosco l’etimo,
“di nicchia”. Un decennio spietato, che ha visto la distruzione
meditata del più grande ente artistico italiano (la Biennale di
Venezia) e la sterilizzazione dell’altro ente (la Quadriennale di
Roma). Ormai lo Straniero governa i nostri enti e musei: anche nel
Rinascimento, quando c’erano occasioni di contesa tra stati vicini
si invocava, tanto per non sbagliare, un intervento estero...
Un decennio di post, trans, neo, ultra; un decennio di exploit e
performances, dove giustamente (Lui ha vinto) gli artisti più à la
page sono quelli che si occupano di media televisivi. Eppure ancora
una volta (come “l’amor mio”) la pittura non muore: si
nasconde in un convento o si concentra un lager, si ritira in una
cripta o si cela in un bunker, ma prima o poi è destinata a
riesplodere. È dolcissima, la pittura, ma non bisogna dimenticare
che è anche un bubbone implacabile e vendicativo, insopprimibile.
I critici continuano ad accompagnare con intelligenza l’opera di
Modica che si precisa in senso sempre più “astratto” (profeta,
Marcello Venturoli), sulla base concreta della memoria. La
lontananza delle saline di Marsala e degli orizzonti di Mazara del
Vallo, l’assenza dei paesaggi mare-cielo, diventa più incombente
e implacabile per chi ha scelto, per la sua centrale creativa, la
distanza.
Mi piace iniziare la rassegna del decennio con una felice
congiunzione: all’inizio degli anni Novanta Modica incontra
Antonio Tabucchi. Uno dei più grandi favoleggiatori del nostro
tempo scrive per Modica un racconto (vogliamo chiamarlo così?)
pubblicato in una deliziosa plaquette da Franco Sciardelli (Milano
1993). La sua pagina racconta Le vacanze di Bernardo Soares, con l’eco
del mare, la coscienza del vuoto, il sapore della lontananza.
Nel 1991, ricordo una pagina di Dario Micacchi (nel catalogo della
mostra al Museo Pepoli di Trapani), onesta come era Dario, un
innamorato della pittura che per doveri d’ufficio doveva anche
occuparsi di cose sgradite. Conferma che Modica appartiene alla
razza di quei pittori che non guardano il paesaggio che hanno
davanti, ma continuano a ruminare quello che hanno dentro. È il suo
enigma.
Si tiene nel dicembre 1995 un seminario curato da “Cosa Freudiana”,
il gruppo psicanalitico lacaniano. Intelligentemente, Giuseppe
Modica pittore, viene chiamato a tenere una relazione accanto a
psicanalisti e specialisti di vari settori dell’antropologia. E
dice cose nette come un cristallo.
Che cosa è per me la pittura? La pittura è il linguaggio della
riflessione che dà forma-corpo alla memoria e all’immaginazione.
Non mi diverte dipingere effettuando una presa diretta sulle cose.
Lavoro bensì sulle tracce e sulle impronte del sensibile che hanno
impressionato la mia coscienza e la mia memoria. La mia è una sorta
di memoria mediata dalla riflessione ed è proprio attraverso tale
meditazione che le varie immagini-tracce del mio inventario si
cristallizzano e strutturano in corpi, ognuno con relativi ed
opportuni pesi specifici e le relative “distanze psichiche”.
Abbiamo un corpo delle cose, un corpo della figura umana: ma anche l’aria
e la polvere hanno un loro corpo.
Come con l’avanguardia storica anche il tempo ha acquisito il suo.
Questa riflessione sui dati della memoria ha bisogno di tempi lunghi
prima di svilupparsi e trasformarsi in qualcosa di permanente e
convincente che mi induca ad avventurarmi nell’impresa pittorica.
Un anno dopo Marco di Capua insiste sul tema dello specchio, nella
presentazione di una mostra nella Galleria Appiani (Milano
maggio-giugno 1996). Alfredo Paglione ha cominciato a interessarsi
del suo lavoro già dopo la mostra di Aosta (1991). L’esordio del
critico è fulminante: c’è ancora posto per la contemplazione in
questa epoca che si divide equamente tra televisore e computer, in
un tempo nella quale le trame del Brutto sembrano (ma sembrano
soltanto) aver vinto.
Solitamente gli artisti, da un’iniziale ricerca di
difficoltà, di complessità, finiscono con l’orientarsi verso non
so quale naturalezza, una sorta di semplicità che placidamente li
risolva annullando fatiche, rovelli, sforzi. Modica sta
capovolgendo, per ciò che lo riguarda, questo atteggiamento. Non lo
contenta più quell'assurda, fantastica razionalizzazione di spazi
luminosi che prima legiferava sui quadri. Tanto che, per esempio, la
vocazione intellettuale, concettuale della sua pittura pare perfino
torcersi verso il proprio contrario, convertendo al rigore, all’ordine
tutto ciò che prima gli sfuggiva. Giuseppe è così arretrato nelle
stanze: l’aperto ora lo vede come di straforo. Desidera l’ombra
degli interni. Accetta il provvisorio, l’intrusione di elementi
spurii, macchie, aloni, segni indecifrati. Ora il tema della
corruzione, di quest’opaca gloria del tempo che sopraffà lo
splendore delle materie, non è più solo presentita come una
minaccia o un destino solo potenziale, ma è fisicamente espresso,
otticamente evidente, preponderante.
E poi ci sono questi specchi che moltiplicano angoli, scorci,
traiettorie (per Modica la pittura pare essere diventata uno
strumento di puntamento, di mira) ma anche questo senso di
abbandono, di vuoto, di disfacimento lussuoso. Non era in un gioco
di specchi che il Principe di Salina, durante il ballo in casa
Ponteleone, intravedeva la fine di un mondo e la propria?
Subito dopo, un intellettuale eccentrico (lo amo molto) come Giorgio
Soavi, scrive una meditata paginetta, su “Il Giornale” (28
maggio 1996; aveva già scritto su questa pittura nel 1989). Oggi
rileggo quella paginetta liquida e mediterranea che somiglia a uno
di quei personaggi acquorei che si manifestano nei quadri di Savinio
e si identificano con il “Signor Mare”. Chi ha amato la pittura
dei Dioscuri sembra il più adatto anche per comprendere la pittura
di questo siculo ingenuo e allo stesso tempo testardo. Sono
costretto a ripresentare quella paginetta senza tagli, tanto è
perfetta.
L’unico mare che mi è entrato in casa, proprio fisicamente
entrato in casa, è quello dipinto da Giuseppe Modica, siciliano di
Mazara del Vallo. Dove sono stato, un po’ di corsa, quando ero in
Sicilia per scrivere e fare fotografie per un libro su Renato
Guttuso. C’erano tante barche da pesca, tantissime cassette per il
pesce appoggiate ai muri delle case intorno al porto: e dei
pescatori ai quali, sono certo, l’acqua del mare non sarebbe
certamente entrata in casa perché avevano ben altro da fare che
guardare quadri.
Questi dipinti da Modica negli ultimi anni che sono quelli di adesso
mi sembrano ancora più dentro casa di quelli che avevo amato una
decina di anni fa. Perché in quelli il mare era visto da lontano,
da uno che sta affacciato alla finestra, o si cuoce al sole quando
sta in terrazza e laggiù c’è il mare. Scrissi che, nella
lontananza delle architetture che si ergevano come contrafforti, per
sorgere dal mare come muraglioni di una difesa dal nemico, avevo
visto una fortezza Bastiani, quella del Deserto dei Tartari di
Buzzati. Sul mare.
Adesso Modica si è tirato dentro casa per far arrivare le
rifrazioni che gli specchi possono dare di quella doppia vita che
sta fuori, laggiù dove si vede sempre l’acqua azzurra del mare e
l’azzurro dei pavimenti, delle mattonelle, e dei riflessi che la
luce del giorno dà, infilandosi come una lama, nel costato di chi
guarda. Che bei corpi vedo, oltre alla forma delle stanze che gli
fanno da supporto: corpi femminili ben disegnati, e ben dipinti.
Cosa non più facile visto che la pittura, l’arte della pittura,
sta trascurando, come si fosse pentita di aver tanto guardato, come
è fatto un corpo di donna, e non ha più la cognizione di quello
che si lascia guardare per lasciarci di stucco. Io, lo confesso,
sono ancora attratto da come è fatto il corpo di una donna anche
nei quadri; da come sta disteso, sempre nei quadri, il mare, quando
la sua acqua è ferma immobile come se nessuno stesse remando
laggiù in fondo: ma se una finestra, o uno specchio, mi riflettono
la vita di una stanza, mi sento ancora meglio. Bei quadri, belle
somme di architetture, bei ricordi che stanno nella testa di
Giuseppe Modica il quale, per nostra fortuna, quando ha dei ricordi
netti, li dipinge per farci stare in casa. Davanti all’acqua.
Quella che, silenziosamente, mette i piedi nelle nostre case.

Salina a Mozia con riflesso - 1998
olio su tela, cm.80x100
Il 1997 segna una tappa importante per il nostro
pittore. Un libro grande e molto curato, edito da Marsilio a cura di
Marco Goldin, presenta i suoi quadri più belli accompagnati da
alcuni amici come Guido Giuffrè e Claudio Strinati, in occasione di
una mostra antologica presso la Casa dei Carraresi a Treviso. Il
pittore di miraggi e del desiderio mi sembra che abbia trovato una
sistemazione quasi definitiva. Scrive Guido Giuffrè:
Lo specchio che appare nella stanza del 1989, e da allora
innumerevoli volte, non altera la realtà ma ne prolunga, oltre l’aspetto,
un modo d’essere segreto, quasi una seconda natura: più che
rispecchiare il mondo, esso gli trasferisce le sue coinvolgenti
malie. Si diceva che l’immagine riflessa non altera quella reale:
ma un’alterazione, sottile e determinante, è intanto l’assenza
del pittore dall’immagine speculare, che pure è quasi sempre
disposta frontalmente. Più che dato fisico immotivato e
inspiegabile quell’assenza è sostanza poetica. Là dove dovrebbe
apparire l’autore, campeggia, aleggia appunto la sua assenza, e il
mistero ne ridonda a tutto lo spazio; di più, l'assenza - non
soltanto del pittore - diventa caratteristica primaria, segnatamente
nella pittura dell’ultimo decennio, la sua più alta. Persino
quando nel diafano riflesso sembra primeggiare un nudo di donna, non
più pietrificato ma pudicamente sensuale, anche allora l’assenza
coagula nello spazio che lo circonda: il deserto lunare di una
volta, freddo e inaccostabile, ora al contrario è invitante,
assolato, ma pervaso di invincibile solitudine, incolmabile,
quietamente, dolcemente disperante.
Dall’alto del suo osservatorio antico, uno storico dell’arte,
Claudio Strinati, vede cose che altri non hanno notato. Soprattutto,
una particolare situazione che il pittore moderno si è scelto: la
costrizione a un limitato luogo di creazione e a una tematica sempre
più ristretta. L’artista barocco si misurava con il cosmo, il
pittore moderno si restringe al microcosmo, dove pure tutto torna
ogni giorno a accadere. In una sorta di prigione, sa riscoprire la
luce della verità.
Modica sta dentro la sua stanza e da lì osserva. Nel suo lavoro c’è
una logica analoga a quella della Finestra sul cortile di Hitchcock:
per quanto ci si possa sporgere, sforzandosi di guardare oltre il
limite consentito dalla finestra della nostra camera, non sarà
possibile allargare il campo visivo nemmeno di un millimetro. Cosi
è, e cosi resta.
Certo si potrebbe cambiare luogo di osservazione ma non in un’idea
estetica. L’arte può ben essere una costrizione e, anzi, spesso e
volentieri lo è.
Del resto non è strano. Se si crede alle possibilità dell’arte,
si deve credere anche alla necessità dell'arte stessa e l’idea
della necessità confina quasi con quella di costrizione, senza
nessun contrasto con il principio, certo irrinunciabile, della
libertà delle idee, perché queste costrizioni sono creazioni,
appunto necessarie, dell’artista e non c’è migliore libertà di
quella che ci siamo imposta.
Non è certo monotona la serie serratissima dei dipinti che Modica
è venuto costruendo negli anni, ma è evidentissimo come, tutti
insieme, questi dipinti rendano l’idea di un diario visivo, dove i
temi si accumulano, si confrontano, si integrano.
Segnalo anche un dialoghetto di tono leopardiano che il mio vecchio
amico Janus ha premesso a una mostra torinese (Manini Arte, novembre
1998). Dietro lo scherzo letterario, si cela una rilettura molto
approfondita di un mondo letterario e pittorico allo stesso tempo,
una pittura ormai solida come un cristallo ovvero coagulata come
quei trapanesi coralli che aggregano complesse biologie.
Visitatore - Quali sono i risultati di questa operazione?
Critico - La trasfigurazione alchemica della materia, prima di
tutto. Il quadro ha una funzione magica; è un gioco di specchi, di
luci, di emozioni, di rifrazioni. L’immagine è racchiusa dentro
una specie di bacheca di cristallo che la protegge da ogni
contaminazione, Lei vede stanze, aperture, porte, finestre,
frammenti di architetture, spazi che si aprono e si chiudono,
sipari, pavimenti colorati, corridoi: c’é in ogni quadro una
piccola parte dei mondo invisibile.
Visitatore - Il suo pittore non vorrà per caso spaventarmi?
Critico - Vuole invece rassicurarLa. Ogni suo quadro è un’isola,
ma a differenza delle isole reali, che normalmente stanno ferme in
mezzo al mare, le isole di Modica viaggiano nello spazio. Sono isole
volanti che si spostano da un punto all’altro dei nostro universo;
sono, certo, isole mediterranee, ma possono anche essere nordiche.
Sa, quella luce impalpabile, di cui Giuseppe Modica è un maestro,
è una luce universale, può essere tropicale o crepuscolare,
incandescente o glaciale, è una luce fatta anche di pensieri e di
ricordi. Modica è un pittore che scava nella memoria. Anche se
dipinge solo una piastrella su un pavimento o una parete o una
pianta, in ogni sua forma Modica va sempre un po’ indietro nel
tempo, rievoca sensazioni ed avvenimenti che si sono verificati
secoli o millenni prima,.
Visitatore - Mi pare di capire che potrebbe essere un pittore un po’
esotico.
Critico - Questa faccenda dell’Oriente non è molto distante dai
quadri di Modica. Vi è questa componente visionaria, e qui siamo
arrivati nel cuore del problema: Modica è sicuramente un pittore
dalla forza onirica, un pittore che starebbe bene sul lettino di
Freud ed allora apparirebbe un po’ meno serafico di quanto non sia
solitamente interpretato. Noi siamo d’altronde intrisi di Oriente.
Tutta la nostra letteratura è piena di suggestioni orientali:
basterebbe partire da Marco Polo, toccare la novellistica italiana
dei Duecento e dei Trecento e secoli successivi, arrivare al Boiardo
ed all’Ariosto, farci incantare dalle favole di Carlo Gozzi e
perfino in parte dal Goldoni, arrivare al De Amicis e trascurare per
ora D’Annunzio che è sicuramente lo scrittore più orientalista
che noi possediamo.
Per tornare all’inizio di questo capitolo, preciserei che Modica
ormai ha il privilegio di aver individuato diversi compagni di
strada che hanno compreso la sua pittura per quello che è:
concentrazione sulla memoria, e quindi (così parlò il Metafisico)
sulla “solitudine dei segni”.
1999, PRIMAVERA
Elogio della bellezza
Il testo che segue è stato scritto per il catalogo della mostra De
Metaphisica, che si è tenuta tra il 29 aprile e il 30 giugno 1999
nella Galleria Appiani di Milano, prima di una serie di mostre
dedicate alla Bellezza. L’opera di Modica figurava accanto a
quelle di Guarienti e Ferroni, Paolini e Mariani, Bonichi e Luino,
Iudice e Cardi.
Quando un amico mercante (‘illuminato’ mercante) mi ha esposto
il suo progetto di dedicare un anno di mostre alla Bellezza, ho
accettato con entusiasmo pensando che era giunto il momento di
esporre una mia idea trentennale: che la bellezza è metafisica o
non sarà. Il passo dimenticato di un eccentrico illuminista ha
rafforzato le mie idee sulla perfezione e sulla vitalità della
bellezza: sulla sua divinità.
“La bellezza è la perfezione della materia secondo il nostro
concetto: mentre il solo Dio tiene l’attributo della perfezione
per proprietà, così la bellezza è qualità divina. A misura che
una cosa contien più bellezza ella sarà più spiritosa: la
bellezza è l’anima della materia come l’anima dell’uomo è la
causa del suo essere; così è ancora per così dire la bellezza l’anima
e cagion dell’essere delle forme, e tutto quello che è senza
bellezza è morto per noi. La bellezza chiama ognuno a sé, perché
è della natura della nostra anima; quello che si volta verso lei la
trova, e la vede, perché ella è il vero lume di tutte le materie,
e il simbolo di Dio stesso”.
Così parlò Giacomo Casanova.
Il secolo XX si è aperto con l’intuizione psicologica e
relativista di un pittore. Giorgio de Chirico forse inconsciamente,
ripropone le fresche teorie di Freud e Einstein. Vedere la realtà
ma andare al di là della realtà; studiare il corpo fisico del
mondo, ma individuarne la metafisica. Non avrà torto André Breton,
inventore del Surréalisme, a sceglierlo come padre.
Giorgio de Chirico ha avuto immediatamente imitatori e seguaci.
Cambiando stile, quella sua prima intuizione muta volto ma resta
sostanzialmente intatta: la critica lo biasima ma molti pittori lo
capiscono. E oggi? Credo di individuare nell’opera di pittori più
o meno giovani il germe di quella rivelazione: ancora inoculato e
attivo. Il secolo XXI si apre (opinione di M. F. d’A.) con Giorgio
de Chirico e l’idea metafisica. Il fantasma della Bellezza torna a
percorrere l’Europa.
E allora si è imposta la necessità di tramutare una idea radicata
(ma labile) in una mostra. Un gruppo di pittori convinti che “arte”
coincide con “artificio”, e che è indispensabile dipingere la
realtà, a patto che sia irreale. È stata pensata da molti anni la
mostra di oggi: un gruppo di pittori che si richiami alla metafisica
e si imponga di continuarne la inquietante filosofia. O meglio,
forse è vero esattamente il contrario: è proprio la conoscenza di
questi artisti ad avermi spinto a comprendere meglio il loro vero
padre, Giorgio de Chirico.
“Ogni buona idea è stata già pensata: bisogna soltanto cercare
di pensarla un’altra volta”: è forse una citazione da Borges?
No, sono parole di Goethe, un ermetico neoclassico che sapeva
scoprire il romanticismo. Dipingere le cose per disseccarle alla
ribalta e spremerne qualcosa che ne rappresenta forse l’anima.
Vedere il veduto, pensare il pensato, immaginare l’immaginato:
proprio nel senso del divino Borges. Trasformare l’immagine in
mondo vero e il mondo vero in immagine, con l’antico trucco di chi
sa bene che la radice di ‘arte’ è ‘artificio’, e che il
compito sublime del pittore moderno (cioè futuro) è quello di
comunicare la sua personale-intima idea come un dogma. Metamorfosare
il Veduto in Visionario.
Quasi tutti i pittori presenti nella mostra di oggi dipingono
soggetti naturali, ma solo in apparenza. Spesso si nasconde il mito,
dietro queste figure in un interno spesso c’è un significato
nascosto nella, apparentemente innocua, presenza della natura.
Questo atteggiamento mentale viene ancora dal metafisico (aveva
scritto in Hebdomeros: “Ebdòmero non poteva essere del parere di
quegli scettici che trovavano tutto ciò una favola e pretendevano
che i centauri non fossero mai esistiti, non più dei fauni, delle
sirene e dei tritoni”). In pratica, il mito non è una idea
letteraria ma una operante realtà.
È ridicolo inventare l’America per chi sa semplicemente
scoprirla. E così è inutile rifare le esperienze già fatte, ma è
essenziale proiettare sullo schermo dell’opera la complessità del
proprio Profondo ma anche la profondità del tempo dell’arte. E
così questi pittori ci parlano soltanto e assolutamente dello scavo
del proprio io, ma lo fanno per interposto linguaggio. Così come,
saggiamente, sanno che è sciocco rimuovere antichi complessi e
problemi. L’enigma e la malinconia, la “sezione aurea”, la “grossezza
dell’aria” la “divina prospettiva”, la metafisica...
Viaggi nel mondo cosmopolita delle mostre, viaggi nel tempo della
storia dell’arte. Tutti questi pittori sanno che l’arte è già
esistita (ce ne è stata anche troppa!) ma l’essenziale è poi la
rivelazione, sul foglio o sulla tela, del proprio io e del proprio
inconscio, del proprio super-io. Della propria esperienza totale che
sceglie la pittura come effimero specchio.
Un giovanotto siciliano: silenzioso e modesto, ma in realtà
sicurissimo del suo lavoro. Me lo ha segnalato Bruno Caruso, un’altro
metafisico, durante i nostri discorsi svarianti tra i marmi antichi
e la Vanitas, tra il disegno graffiante e i Dioscuri. Era, credo, il
1985. I quadri di Modica erano allora meno risolti del suo pensiero,
ma subito dopo alcuni critici (ricordo Sgarbi, Soavi, Di Capua)
cominciavano a decretargli un certo successo, mentre qualche
letterato lo seguiva con passione (ricordo due grandi: Sciascia e
Tabucchi).
Mi attrasse la tavolozza di Modica, la sua idea di catturare la
luce, trovavo ancora poco motivata la sua iconografia (prospettive
sulla vertigine, scambi interno-esterno, geologie dantesche). Poi,
di colpo, compresi il suo lavoro, o forse il suo lavoro si precisò
intorno a tematiche più semplici, o forse la sua pittura si ridusse
all’essenza. Ricordo i tanti appuntamenti mancati, la mia
distrazione, le mie continue inadempienze. Ma quando arrivò
(secondo me) il momento, il testo su Modica prese corpo in pochi
giorni d’estate. Era stato l’amico Janus (complice di incontri
con Man Ray, un altro metafisico) a chiedermi un lavoro per il museo
di Aosta. La mostra si intitolò “Le stanze inquiete” e si tenne
nell’inverno 1991. Anche in quella occasione scrivevo un
dizionarietto per Modica, cercando di caratterizzare (senza
sforzarlo) il suo lavoro. Frasi e temi che oggi rileggo e
sottoscrivo.
Oggi Modica ha dipinto per questa mostra un dittico raffigurante
Mazara e Agrigento: una immagine antica e una moderna con lo stesso
taglio di veduta (visionaria). Ha dipinto l’eternità e il
momento, la civiltà e la barbarie. Ha dipinto un doppio fotogramma
di luce e di pensiero.
Una lettera di Modica.
Mazara del Vallo, 15 agosto 1998. […] Provo a scriverti qualcosa
sulle due opere in mostra. Per la realizzazione di questi due quadri
ho catturato certe precise immagini: una della città di Mazara e l’altra
dell’acropoli di Agrigento.
La prima è una visione in orizzontale dell’aggiomerato urbano
cresciuto dagli anni ‘60 in poi, dove spesso i palazzi nuovi si
sostituiscono alle vecchie dimore cancellandone le tracce. Ne viene
fuori una visione fantasmica, ambiguamente metropolitana, che si
protende sul mare come una immane chiatta.
La seconda è una visione dell’acropoli di Agrigento vista dalla
strada che da Palma di Montechiaro va verso occidente, nel tardo
pomeriggio. Un’immagine prelevata (col teleobbiettivo) qualche
anno addietro in uno dei miei frequenti giri estivi.
Ho usato il termine catturato proprio perché queste immagini sono
state letteralmente prelevate con un teleobiettivo. Andare al cuore
delle cose, prelevarle e portarsele via, per poi guardarle con
attenzione e rimeditarle (anche) a distanza di tempo. Anzi credo che
il tempo sia necessario per farle decantare, per depurarle dall’accidentalità
naturalistica, per poi poterle strutturare in forma pura. Colore -
luce - struttura.
E nell’interno dell’atelier avviene questo processo-avventura
della ricostruzione e della riorganizzazione del dato di memoria.
Una ricostruzione sperimentata e verificata attraverso diverse prove
e varianti che tendono a una messa a punto, a una sospensione che
dopo lungo lavoro si rivelerà inequivocabilmente definita e
permanente. È come se cercassi qualcosa che abbia una certezza
definitiva capace di durare nel tempo e di rivelarne una verità
interna e segreta. Qualcosa (una visione) che non si esaurisce nello
sguardo, che non si smonti, sbricioli all’azione di esso; ma che
abbia la forza e la tensione interna che continua a vivere malgrado
l’implacabile azione devastante e destrutturante dello sguardo.
Ciò è pittura, qualità poetica di un linguaggio. Questa vita e
verità interna dell’opera è la sua bellezza, la sua
imponderabile enigmaticità metafisica. Questa tensione magnetica
che sta nel dipinto è misteriosamente segreta e indecifrabile. Non
c’è una ricetta o una regola fissa; ogni opera è un organismo a
sé stante con i suoi codici e i suoi meccanismi (segreti) che
variano di volta in volta. De Chirico diceva: bisogna trovare l’occhio
nelle cose, il demone...
Poi vorrei dirti qualcosa sulla memoria. Non si tratta di un
recupero nostalgico del passato, e se c’è una nota apparentemente
nostalgica che essa non tragga in inganno. Più che di nostalgia
penso che si tratti di dolente malinconia e inquietudine nei
confronti di un presente che ci rivela le impronte, le tracce
consuete di un passato che essendo irrecuperabile esiste solo come
imprescindibile fantasma della memoria. Come traccia originaria di
un percorso nel tempo (che ci appartiene). E poi è sulla tela,
sulla superfice del presente che questa memoria si reinventa per
interrogarsi e proiettarsi nel futuro.
Per quanto riguarda la bellezza, ritengo che un’opera sia bella
quando presenti una corrispondenza tra valore formale e valore
morale. Quando l’invenzione è pienamente incarnata con l’esistenza,
la rivela. E l’opera, in questi casi, si presenta a noi come una
sorta di ‘miracolo visivo’, una apparizione insostituibile e
necessaria. Penso che la bellezza sia riscontrabile nel binomio
metafisico invenzione - verità. […]
PRIMAVERA 2002
La pittura continua…
E sono di nuovo in via dei SS.Quattro. Devo far leggere il testo al
vecchio amico Beppe (chissà se apprezzerà la mia incursione nel
“privato”, in questo testo sulla pittura?). È sempre primavera:
soltanto che oggi sembra estate, mentre un mese fa era inverno. Lui
legge, e io mi guardo intorno.
Vedo su un tavolo le fotografie scattate dal pittore nei paesi suoi
l’estate scorsa, accanto ad alcune foto di un trapanese dell’Ottocento:
somigliano ai quadri appoggiati alle pareti; bisognerà pubblicarle.
Non so chi ha detto che il mondo è quello che vediamo ma che è
anche necessario imparare a vederlo. E come si fa a imparare?
Proprio allontanandosi da quel mondo, sforzandosi di mettere tra i
luoghi dell’infanzia e il presente un tempo e uno spazio infiniti.
Rivedo quel mar Tirreno che si riflette nei quadri di Modica; eterno
come il mar Egeo nei quadri dei Dioscuri. Ricordo che i luoghi di
Modica sono proprio come le “città invisibili” di Calvino, un
insieme di mondi che (mi disse così quando lo aiutai a illustrare
con quadri dechirichiani un testo per la rivista di Franco Maria
Ricci) quelle città esistono soltanto quando pensiamo dietro le
nostre palpebre abbassate. Penso che i luoghi di Modica coincidono
con la biblioteca di Babele: un mondo dove ogni copia è l’immagine
autentica (e viceversa).
Modica riflette, e riflette ancora, e dipinge quella sua replicata
riflessione. Leggo in una sua pagina poggiata sul tavolo, che un
giorno ha scritto in una rivista per studiosi dell’anima: “Lo
specchio è un diaframma che rileva e rivela la memoria. Lo specchio
cristallizza sulla superficie del presente le immagini che vengono
dal lontano passato”. È proprio vero: i pittori hanno detto anche
con le parole quello che si ostinano a dimostrare con i quadri…
E continuo ad aggirarmi nell’atelier. Scopro che le saline
somigliano (enigmaticamente) a Piramidi egizie, che il suo mosaico
di luci somiglia al mistero di Piazza Armerina, rifletto che le
incisioni non sono altro che la trama di una rete che vuole
catturare la luce. Bello, aggirarsi nell’atelier di un pittore:
proprio in questi giorni sto preparando il piano di una mostra che
metterà in scena il pittore nel suo studio: lo spazio della sua
vita, del sogno e della memoria, la scena dei complessi e il
teatrino della volontà creativa .
Vedo su una poltroncina un libro di Leonardo Sciascia, e penso a
quando veniva a trovare negli anni Cinquanta un poeta romano (Mario
dell’Arco, mio padre) con una ventiquattrore che conteneva una
bottiglia di Amaro Averna e due volumi di Mickey Spillane (“Questo
è per la signora; questi per il viaggio di andata e il viaggio di
ritorno”). Ricordo una foto molto tarda del suo studio: c’era un
quadro di Modica dietro la sua scrivania…
Il pittore ha letto quasi tutto il testo, e lo ha anche chiosato,
insieme a Carla. Non mi pare che gli dispiaccia…
Torno a guardare quel grande quadro dal quale sono partito, che reca
nel titolo un programma ambizioso quanto scettico: “inseguire la
pittura”. E ricordo una frase del grande Borges che ho letto da
poco: “Mi pongo in una situazione passiva e aspetto. Aspetto e la
mia unica preoccupazione è di mettere tutto in bellezza… Ho la
sensazione di ricevere un dono non so bene se dalla mia stessa
memoria o qualcosa altrui. E cerco di non intervenire troppo”. E
torno al grande quadro. Si inseguono le luci (vere e finte, calde e
fredde, verosimili e false), in questo quadro che sembra una
finestra, ed è invece una descrizione del tempo e anche una
parabola sul fare pittura.
Ma certo, la pittura devi inseguirla sempre, anche se finisce sempre
per somigliare alla bella Dafne: quando credi di averla finalmente
raggiunta, si trasforma sotto le tue mani in qualche altra cosa. E
allora l’inseguimento deve continuare…
Articoli collegati:
Giuseppe Modica a Mazara
del Vallo
Chi è Giuseppe Modica
La luce è la luce è la
luce
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da
fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui
Archivio
Attualita' |