
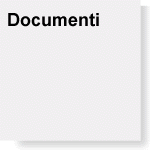
| La sfida dell’integrazione europea -
L’Italia alla prova Introduzione di Alfredo Reichlin al Seminario del 19 febbraio ‘99
Documenti collegati: Roma, Sala del Refettorio della
Biblioteca della Camera dei Deputati Con questo seminario noi vorremmo offrire la possibilità di riflettere in modo abbastanza sciolto, anche azzardando ipotesi non verificate, sugli scenari che l’avvento dell’Euro ha aperto: per l’Italia, ma, naturalmente, non solo per l’Italia. Basta vedere le prime prove di stabilità offerte dall’Euro e come è cambiata in poche settimane la percezione americana.Di colpo si è passati da una relativa indifferenza per le vicende della Vecchia Europa alla consapevolezza che le strutture del potere mondiale già non sono più quelle. Ma di ciò altri parleranno. Io mi concentrerò sui problemi che si pongono all’Italia: il "che sarà di noi", cercando di allargare lo sguardo un po' più in là. Scarto moltissime cose che si possono e si debbono dire a proposito delle nostre debolezze e delle nuove opportunità che si offrono. Sollevo qualche quesito. Il primo è questo. Se di evento storico si tratta, cioè di un passaggio che, di fatto, pone fine al modo di essere dell’Italia repubblicana (del suo assetto non solo economico ma statale: il che non è poco); se di questo si tratta, cioè di un fatto che ci spinge, lo vogliamo o no, dentro una nuova storia, noi di questo dobbiamo discutere, e con l’assillo di chi sa che su questo una classe dirigente si gioca tutto. Il che poi non è così ovvio. Basta guardare al dibattito politico attuale. Si fondano nuovi partiti, scendono in campo nuovi leader, veri o presunti. I quali di tutto parlano tranne che di quel piccolo dettaglio per cui il paese è di fronte alla prova più difficile della sua storia. E che questa partita si decide ora. E che la condizione per superarla è che le forze dirigenti, innanzitutto politiche, misurino su ciò i loro disegni e le loro ambizioni. Ricordo a me stesso (come si usa dire) che non stiamo parlando solo di banche ma di cose che investono l’insieme del Paese, le sue strutture materiali ma anche l’identità, la coscienza di sè, la coesione sociale. E, quindi, stiamo parlando del come guidare gli italiani in una impresa del tutto nuova, totalmente politica, nel senso più alto della parola: quella di integrare l’organismo italiano (e non a caso dico organismo, poichè chiamato in causa è l’insieme del sistema, insomma le virtù e i vizi degli italiani) in qualcosa,l’Europa, che è anch’esso un organismo storico nuovo, una grande potenza politica in formazione. Per cui a seconda di come l’Europa si farà, di come peserà come nuovo soggetto mondiale, di come si organizzerà al suo interno, secondo quali gerarchie, con quali aperture e inclusioni verso le sue frontiere mobili ( l’Est, il Mediterraneo, il resto del mondo) cambiano tutti i termini delle nostre questioni: dalla sorte del Mezzogiorno, al modo di come si raggruppano le famiglie politiche, al ruolo nuovo degli Stati nazionali. Altro, quindi, che fine della grande politica o sua riduzione ad assemblaggio di carovane elettorali. Io non so chi alla fine conterà di più nella prossima conta elettorale. Credo però di capire che nella Europa in costruzione le nazioni con istituzioni e partiti deboli conteranno sempre meno. Conteranno le nazioni e i partiti che hanno radici, che avranno rapporti forti con le culture politiche europee che saranno in grado di gestire le nuove competenze non più solo nazionali del potere pubblico, e che porranno alla base del loro agire la difesa dell’interesse nazionale. Questo forse non si è detto abbastanza: che delegare una sovranità non è impresa semplice. Tanto più puoi delegare quanto più disponi di una forte identità e autostima. Quanto più sei capace di ridefinire il profilo anche culturale della nazione e di rielaborare (certo, in termini nuovi) quella cosa che si ha ancora paura di nominare e che è l’interesse nazionale. Altrimenti non deleghi nulla, ti metti solo nelle mani degli altri. Questo -sia detto senza retorica- è il grande tema che sta sullo sfondo della nostra discussione. Ne ha accennato, di recente, anche Bobbio quando, tornando a riflettere sulle debolezze dello Stato post-risorgimentale esprime un timore e una speranza. Il timore che -secondo un vecchio costume delle classi dirigenti- il vincolo estero venga usato per farsi dirigere dagli altri. La speranza che sia la dura competizione europea a risvegliare negli italiani l’orgoglio di essere un grande popolo e che ciò ci spinga a rafforzare il patto di cittadinanza e l’identità della nazione Di qui l’assillo che la nostra Fondazione sente di rimettere al centro del discorso pubblico i programmi. La cui validità si dovrebbe -credo- misurare sulla capacità di dare una nuova forma e nuovi fattori aggreganti alla società italiana, una nuova ossatura alla nostra economia. Quindi io cercherò di ragionare, non tanto sui singoli problemi, peraltro cruciali, ma su ciò che chiamerei "il più complessivo modo di vivere di una popolazione come forza produttiva". Partendo dal fatto che il fattore cruciale del successo in una economia post-industriale, sempre più integrata in una dimensione sovranazionale, è costituito da cose che si chiamano capacità di pensare soluzioni originali a problemi nuovi, disponibilità al cambiamento, e quindi, affinchè questa disponibilità ci sia, coesione sociale, condivisione di valori e di obiettivi. Come sta l’Italia da questo punto di vista?Questo è l’interrogativo. Ricordo solo per memoria che se l’Italia ha ancora carte da giocare il merito è dei governi e dei partiti che in questi anni hanno portato il paese fuori dal marasma e lo hanno ricollocato nel cuore dell’Europa, creando così le condizioni del rilancio. Ma queste carte si tratta adesso di giocarle. Come? Il presidente del consiglio ci ha ricordato, in una intervista recente, che tipo di cambiamento è necessario, un cambiamento molto più profondo di quelli fatti finora. Intanto -cito le sue parole- perchè finisce un intero modello di sviluppo fondato sul deficit, la spesa pubblica assistenziale, gli alti tassi dei Bot e la rendita finanziaria. Con in più lavoro nero e ricorrenti svalutazioni della lira come condizione per restare sui mercati. Il che ha alimentato un certo modo di essere non solo dell’economia ma della società, un blocco sociale che prosperava ai danni dei ceti più produttivi e avanzati. A me sembra utile partire da qui: da qualcosa cioè che riguarda l’assetto complessivo del Paese perchè se è vero che si è rotto un vecchio ordine, la organizzazione di un nuovo ordine diventa il compito prioritario. Pena -come vediamo- uno stato di incertezza, una mancanza di fiducia nel futuro e quindi una crescita italiana che resta parecchio al di sotto della media europea. Le ragioni di ciò sono tante e tutte ci spingono ad accellerare quelle riforme, sia liberalizzatrici sia neo-regolatrici, che sappiamo e che in parte si stanno facendo. Ma il punto che io vorrei discutere è anche un altro: è quello che solleva D’Alema quando dice che se vogliamo creare le condizioni non solo tecniche ma politiche e sociali capaci di dare una nuova ossatura al sistema italiano, il tema diventa una nuova alleanza tra i produttori. Per evitare equivoci sarebbe meglio parlare di una alleanza che non si riduce all’interesse economico-corporativo ma riguarda e ridefinisce un progetto, non in astratto ma in rapporto a questo passaggio storico. Quindi una alleanza tra le forze più creative del lavoro, dell’impresa e dell’intelligenza interessate a battersi contro il grumo di conservatorismi vecchi e nuovi che attraversa tutta la società italiana e che rischia di lasciarci ai margini dei processi innovativi che stanno già determinando il futuro delle nuove generazioni europee. La ragione e la base di una nuova alleanza io la vedo così, non solo perchè al posto della vecchia società industriale c’è una società dei servizi e, quindi, i grandi patti neo-corporativi tra sindacati e Confindustria non sono riproponibili. Ma anche perchè meno che mai i soggetti si definiscono solo in base al reddito, più che mai contano la coscienza di sè, i valori, la consapevolezza che i propri interessi immediati non sono difendibili se non stanno in rapporto con gli interessi generali del paese. Al fondo, quindi, il vero interrogativo che domina la scena politica italiana è molto serio, ed è quello che dice Bobbio. E’ se le classi dirigenti (in senso lato) sono disposte a battersi, e fino a che punto, perchè il paese si collochi nel nocciolo duro dell’Europa con tutto ciò che ne consegue come riforme anche dolorose, fine di vecchi privilegi, rafforzamento dell’ossatura politica e statale, difesa del capitale sociale e umano. Oppure se per la somma di tante cose, sceglieranno ancora una volta di farsi dirigere dagli stranieri. Sbaglierò, ma io credo che dietro la crisi del centro-sinistra ci sono anche spinte di questo tipo. Ma penso anche che se siamo arrivati a questo nessuno è innocente. Lascio ad altri dire tutto il male che si può dire dei partiti. Ma se guardo agli anni recenti, a questa lunga transizione che non si compie e se mi domando qual’è la ragione ultima di questa assurda frammentazione politica, a me sembra che tra tante spiegazioni bisognerebbe tener conto anche del fatto che le diverse correnti del riformismo italiano non sono riuscite a misurarsi con quel dato materiale oggettivo, inseparabile dalla crisi e dal collasso del regime politico, che è la mutazione sociale di questi anni, dopotutto la più grande e la più profonda dopo decenni, paragonabile solo al passaggio, alla fine degli anni ‘50, dall’Italia agricola a quella industriale. Era finito l’assetto sociale e il mondo del lavoro modellato dal vecchio industrialismo. Era cominciata una nuova società, quella dei servizi e del post-industriale. Non era poco. E non era cosa da lasciare ai sindacalisti e ai sociologi. Eppure è questo che è accaduto. E forse sta anche quì il dramma della politica italiana. In parte condizionata e avvilita dalla decadenza politico-morale prima e dal crollo poi del vecchio sistema. In parte appesantita dai cascami di una vecchia cultura operaista e ideologizzante che anch’essa parlava d’altro, di un mondo che non esisteva più. In parte afflitta dal vecchio vizio politicista che disprezza i programmi e i contenuti. La verità è che i neo riformisti sono rimasti minoranza ed è un miracolo che nonostante ciò siano riusciti a portare il paese in Europa. Il lato tragico di questa storia, con la quale oggi facciamo ancora i conti, è che la società non riesce a darsi una identità e una forma, mentre la politica, non avendo guidato processi di trasformazione così profondi, ha perso consenso, perfino legittimità. Io credo che sia anche per questo insieme di ragioni, non soltanto economiche, che la realtà italiana appare così magmatica e di così difficile lettura. Il paese si sta deindustrializzando? Mi sembra azzardato dirlo anche perchè non chiamerei più servizi quelli che sono pezzi di decentramento industriale oppure la crescita di una nuova industria della conoscenza. Credo, piuttosto, che sta succedendo un’altra cosa. Il Nord con la trasformazione del Triveneto e delle province piemontesi, ha ormai compiuto la sua industrializzazione con una diffusione di imprese che non ha l’eguale in Europa. Contemporaneamente, però, è scomparso il Triangolo industriale. E’ scomparsa cioè quella ossatura che vedeva una presenza di grandi imprese industriali (e anche di qualche banca) che fino a 20-30 anni fa erano più o meno forti come le concorrenti europee. Basti pensare a Olivetti, Montecatini, Breda, Ansaldo, Marelli, Comit, ecc. Con in più l’IRI e l’ENI. Con in più il Mezzogiorno usato come serbatoio di mano d’opera a basso costo e di risparmio, oltre che di mercato di consumo chiuso. Con in più una amministrazione debole e inefficiente ma un potere molto concentrato nelle mani di quello Stato-partito e di quelle grandi consorterie che sappiamo. Questa, anche se criticabilissima, era pur sempre una ossatura. Noi cosa mettiamo al suo posto? Oppure dobbiamo accettare la posizione della cultura dominante secondo cui questo problema non esiste, nel senso che a risolverlo ci penseranno il mercato,le privatizzazioni e le piccole imprese? In altri termini: c’è o non c’è un problema di modello di sviluppo? Ho visto che anche Ciampi ha sollevato la questione partendo dal fatto che se è inaccettabile il modello americano è ormai superato anche quello tedesco di "economia sociale di mercato". Una risposta non è semplice anche perchè in questo vuoto il pericolo paventato da Monti di essere colonizzati diventa serio ma non possiamo certo evitarlo tornando a proteggere e a pubblicizzare il sistema. Questo è chiaro. Ci sono però domande alle quali non si può più sfuggire. Perchè il risultato delle privatizzazioni è stato in troppi casi quello di resuscitare le vecchie consorterie e il vecchio volto del capitalismo senza capitali? Solo per errori o perchè ha ragione De Cecco quando sostiene che ciò che precede e sovrasta questi errori è la crisi organica della grande imprenditoria italiana, cioè del vertice del nostro sistema economico e finanziario costituito ancora in larga parte da una oligarchia chiusa che negli anni ‘70 ha affrontato le proprie incapacità di gestire la transizione verso i mercati globali e l’avvento della rivoluzione tecnologica prima ricorrendo al decentramento produttivo e poi gettandosi nel turbine dei grandi affari finanziari e cambiari, invece che puntare sui settori trainanti del mercato mondiale: con il risultato che, svaniti gli effetti del decentramento e delle alchimie finanziarie, e inariditosi il fiume dei pubblici sussidi, non riesce a fronteggiare la sfida europea e rischia di subire una internazionalizzazione passiva. Ci salveranno le vecchie zie? si chiede tra scetticismo e ironia Giuseppe De Rita alludendo all’esercito delle piccole imprese italiane. Può darsi ma dobbiamo pur chiederci perchè questo popolo di straordinari imprenditori e di coraggiosi mercanti resta fermo, investe poco, non osa. Una risposta che guardi al di là della congiuntura potrebbe essere che una economia, pur di tutto rispetto (la sesta o la settima del mondo) ma che è costituita essenzialmente da milioni di piccole imprese, si sente come indifesa a fronte di qualcosa che non è solo un mercato più ampio, ma un mercato che si sta dando un’altra forma anche politica, cioè altre regole (il cambio fisso, la moneta unica) e altri poteri sia pubblici che privati, essendo in esso dominanti imprese grandi come quelle francesi e tedesche e grandi banche, nonchè Stati forti e orgogliosi che non stanno a guardare ma sollecitano quegli accordi e quelle concentrazioni che vediamo. Se vogliamo, quindi, mettere al centro -come molti suggeriscono- quella peculiare risorsa italiana che sono i distretti industriali dove si addensano imprese piccole ma molto innovative, io -lasciando per un momento da parte le tante cose da fare e che si stanno già facendo nel campo degli incentivi- mi chiederei se la crescita dei distretti non comporti anche qualcosa di più e di diverso. Non scopro nulla se dico che -dopotutto- ciò che è avvenuto in Veneto e in altre regioni italiane è una sorta di rivoluzione sociale, la quale ha liberato forze produttive. Quindi non si è trattato di qualcosa che riguardasse solo un settore economico ma di molto più grosso che però avveniva nel vuoto politico senza una guida nè una base culturale (altrimenti non si spiegano i fenomeni come Umberto Bossi nè la catastrofe della sinistra in tanta parte del Nord Italia). Eppure si continua a ragionare come se si trattasse solo di imprese, magari più piccole di altre, e non di una sorta di "stato nascente" Cioè di qualcosa che muta il modo di pensare e di vivere di intere zone e che quindi cerca una identità nuova. E’ esattamente questo che ha "spiazzato" la sinistra. Ma il rischio è che mentre la sinistra viene spinta -anche per colpa sua- ai margini del cambiamento questi ceti restano schiacciati in una dimensione meschina, corporativa, rancorosa e perfino ribellistica. E ciò essenzialmente per la ragione che non trovano chi fornisce loro quel fattore necessario anche ai fini della crescita economica che è la rappresentanza politica e il riconoscimento sociale. Silos Labini lo dice nel modo più netto: "il problema da parte di questi ceti non sono tanto gli incentivi quanto quello di assumere una funzione nuova, molto più politica, quella di agenti attivi di un disegno di sviluppo civile, oltre che economico". Ci misuriamo, quindi, con problemi molto diversi da quelli che furono alla base dei patti tra produttori tipici delle "regioni rosse". Vengo così al dato più preoccupante della situazione italiana e sul quale non mi pare che ci siano idee chiare. Parlo del fatto che ormai da lungo tempo l’Italia ha smesso di crescere. Questo non è un dato congiunturale ma qualcosa che ci chiama a ripensare le strutture profonde del paese. Siamo passati da ritmi di sviluppo del 7 per cento all’anno nel decennio 1950-60 al 5 per cento degli anni 70, al 3 per cento degli anni 80 e all’1,5 per cento nell’ultimo periodo. Abbiamo oggi meno occupati di quanti se ne contavano nel 1980, e la quota del reddito da lavoro sul totale del PIL è scesa di quasi 10 punti e la differenza se la sono mangiata i redditi da capitale più ancora che quelli da impresa. Anche gli indici della povertà sono in crescita e il divario tra Nord e Sud è tornato quello del dopoguerra. Ma, al di là di questi dati e tenuto anche conto di segnali più recenti di inversione di tendenza, la verità è che la voglia di crescere l’hanno persa un po' tutti. E’ dal 1992 che il numero dei morti supera quello dei nati. Il capitale umano invecchia e si riduce. Esattamente come il capitale fisico che la spesa pubblica e gli investimenti privati non riescono a ricostruire, almeno se guardiamo al tasso di accumulazione, cioè al rapporto tra investimenti fissi e risorse disponibili che è passato tra il ‘92 e il ‘97 dal 16 al 13 per cento. Da quanti anni non si progetta un’opera pubblica paragonabile alla rete autostradale o al sistema di acquedotti e fognature della prima Cassa del Mezzogiorno? Queste sono cose che riguardano le fibre del paese e che ci dicono più di tanti discorsi perchè è tempo di tornare a una idea forte della politica come progetto, come guida. Non basta il mercato per ridare il senso del futuro a un paese che si è messo sulla difensiva al punto che il 70 per cento dei giovani tra i 18 e i 30 anni vive ancora a casa con i genitori. Il che dice tutto. Torno così al tema di quale futuro immaginiamo per l’Italia. Non pretendo di dare le risposte. Temo però che non andremo lontano se non ci poniamo il problema di una nuova ossatura capace di sorreggere quel grande sistema molecolare che è diventata la società italiana, e di portarla in quel luogo di poteri forti che è l’Europa. Ecco perchè sento molto il bisogno di colmare la distanza tra il discorso politico, troppo ridotto a politologia, e il fatto macroscopico che è nata un’altra Italia rispetto a quella del passato e che è questa Italia che bisogna guidare: una Italia di giovani che non trovano più posti stabili, ma iniziano lo stesso a lavorare in qualche modo, ingrossando le fila del lavoro autonomo, para-subordinato, o addirittura si mettono in proprio come artigiani e piccoli imprenditori. Di nuovi poveri ma anche di operai più qualificati. Di lavoratori autonomi dove cresce la componente dei nuovi mestieri. Di 3 milioni e mezzo di imprese che occupano quasi 14 milioni di persone. Un mondo che ha minori vincoli, ma anche pochissime tutele, che vive in modo intenso la necessità di affermare una identità professionale e che, quindi, ha un drammatico bisogno di formazione e informazione, per riprodurre appunto la sua professionalità. Un mondo che si distacca dalla politica e dai partiti non perchè non ha bisogno dello Stato ma, al contrario, perchè questo non risponde alle sue domande. Un mondo che tuttavia esprime anche grandi spinte solidaristiche (4 milioni di persone fanno volontariato) e una nuova coscienza civile: come ci dice anche quel fatto ignorato dai giornali che nelle recenti elezioni sindacali l’80 per cento dei dipendenti pubblici hanno votato, hanno ridotto a frangia i sindacati corporativi e hanno portato la CGIL al primo posto. Ecco il punto dove volevo arrivare; come dare a questa enorme mutazione sociale una nuova forma. Dico forma, cioè forma politica e istituzioni. E, quindi, un progetto. Forma non solo voce perchè non mancano certo i populisti e i demagoghi che cavalcano le proteste, gli egoismi e le rabbie di una società, appunto, lacerata e "molecolare". Possiamo noi discutere di come l’Italia può reggere alla sfida dell’integrazione europea senza porci questo problema? Proviamo a immaginare che cosa sarebbe l’Italia se la politica -la grande politica, cioè i grandi partiti popolari non le cordate elettorali- non avesse saputo guidare la trasformazione di un paese agricolo, di analfabeti, uscito a pezzi dalla guerra, in una delle maggiori potenze industriali. Ci riuscì perchè fornì alle forze produttive una direzione di sviluppo, le istituzioni necessarie e una base di consenso. Tutto è mutato da allora. Non illudiamoci, quindi, che una alleanza sociale, potenzialmente maggioritaria, possa basarsi, come nel passato, su un patto neo-corporativo tra grandi soggetti capaci di regolare consumi, prezzi, redditi. Ma proprio da ciò deriva la necessità di rivolgersi a questa società con un nuovo progetto. Il che significa che non è vero affatto che il ruolo della politica si riduce, anzi diventa più grande. Anche perchè più grande diventa la necessità di un potere di regolazione di questo mercato storicamente determinato, molto più ricco di liquidità ma anche molto più esposto a rischi di instabilità e di irrazionale allocazione delle risorse . E’ chiaro che sarebbe un grande errore allentare la lotta per la stabilità finanziaria e il risanamento del corpaccione pubblico: quella che abbiamo chiamato una rivoluzione liberale volta ad abbattere le gabbie corporative e a liberalizzare e rendere più spessi i mercati sia dei prodotti che dei capitali. Ed è evidente che non reggiano con politiche sociali troppo assistenziali. Ma il problema che sollevo è se questo sia sufficiente. Se, in altri termini, il salto da fare anche come governo non sia quello di mettere in campo una mediazione più alta tra politiche economiche e politiche sociali, tra mercato e istituzioni, tra qualità dello sviluppo e qualità del capitale umano. Altrimenti diventa forte il rischio che l’integrazione monetaria comporti per l’Italia lacerazioni profonde, sia sociali che territoriali. Che succede quando i salari verranno pagati con la stessa moneta ad Amburgo e a Bari? Succede che, venendo allo scoperto tutti i differenziali di produttività e di costo (del lavoro e di servizi), diventerà molto forte la spinta a cercare l’aggiustamento sul lavoro e sui diritti e a declassare le regioni più deboli. Con la conseguenza che -se questa spinta passerà- resterà irrisolto il problema di fondo che condiziona il nostro avvenire che dopotutto è quello di entrare nella fascia alta della competitività per riuscire a competere sulla qualità e non sul prezzo, e non quindi sul lavoro nero, sulla illegalità e sull’arte di arrangiarsi. Sapendo che in questo caso diventerebbe molto difficile mantenere unito il paese, difendere i diritti di cittadinanza, rilegittimare le istituzioni democratiche. Io credo che solo rendendo chiari questi dilemmi il dibattito politico italiano può essere rimesso con i piedi per terra. Solo così si capisce che cos’è oggi la destra e di che cosa si nutre, e si capisce, quindi, perchè è difficile dirsi "innovatori" se non ci si schiera su discrimini reali come questi; e si capisce anche perchè un rilancio dello schieramento che vinse il 21 aprile del 1996 e portò l’Italia nella moneta unica presuppone un nuovo programma - un programma non solo per arrivare ma per restare in questa Europa. Io non so se mi fa velo la partigianeria politica ma francamente non comprendo come il rilancio del centro-sinistra può farsi sulla crisi di una sinistra che ha le sue radici nella storia e nelle lotte del mondo del lavoro. Davvero non sta qui, in queste radici, il "vecchio" che ostacolerebbe il "nuovo". Chi lo pensa non ha capito che esattamente il lavoro italiano, la sua qualità, la sua nuova possibile potenza sociale, il suo ruolo potenzialmente più grandi in una economia basata sulla conoscenza e non sulla manovalanza -e dico, quindi, lavoro nel senso più ampio, compreso quello creativo, la scienza, la cultura, compreso il lavoro di chi organizza e intraprende- è esattamente questo al centro dello scontro. Certo, i vecchi schemi non servono. Senza una forte iniezione di flessibilità restiamo fuori da processi così rapidi e profondi di trasformazione. Ma flessibilità di tutti i fattori, compresa la pubblica amministrazione, compresa la contendibilità delle imprese, compreso l’uso del capitale. Per ciò che riguarda il lavoro è chiaro che il contratto a tempo pieno e per tutta la vita non sarà più la regola. Ma tanto più allora diventa essenziale introdurre nuovi diritti: quello di avere voce nelle scelte che cambiano l’organizzazione del lavoro e di ricevere una formazione permanente. Per cui -ecco il punto- una nuova alleanza dovrebbe in sostanza basarsi su una scommessa da proporre anche alle imprese: riformare il Welfare nel senso di farne una strategia di investimento sulle persone, di formazione, e quindi di inserimento nella società anche dei più deboli; e al tempo stesso riformare il mercato del lavoro nel senso di renderlo più flessibile, ma facendo della difesa del capitale umano un’arma per spingere le produzioni su sentieri più avanzati. A me pare che stia in ciò l’importanza del patto siglato tra il governo italiano e le parti sociali. E’ un passo molto importante che va in questa direzione. Ed è in questa direzione -rafforzare il capitale umano, il sapere, l’intelligenza collettiva- che io cercherei una risposta all’interrogativo circa quale ossatura dare all’Italia per non subire una internazionalizzazione passiva. Una somma algebrica delle nostre forze e delle nostre debolezze è molto difficile fare. La partita è aperta e non va sottovalutato il cammino di questi anni. Importanti riforme sono state avviate e si sono create le condizioni per rimettere il Paese in movimento. Ma grandi rischi sono davanti a noi. Si ha sempre paura di esagerare; ma che succede se non si inverte la tendenza per cui tra pochi anni il numero dei pensionati supera quello degli occupati? Il dato è semplicemente impressionante: tra venti anni ci saranno 6 milioni di italiani in meno ma come risultato di 5 milioni di ultrasessantenni in più e 11 milioni di giovani in meno. La Banca d’Italia ha misurato le conseguenze di ciò sulla forza e il dinamismo della nostra economia. Sono catastrofiche. Ma già oggi -ci ricordava il governatore Fazio- l’Italia presenta un deficit grave di scolarizzazione in relazione alla sua collocazione internazionale: solo il 28 per cento degli italiani di età compresa tra il 25 e i 64 anni ha un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di università, mentre tale quota è del 50 per cento in Francia, dell’82 per cento in Germania e del 65 per cento in Gran Bretagna. E allora? Allora il cuore di un nuovo programma non può che essere quello di rimodellare le istituzioni sociali e le istituzioni politiche per dare al paese quelle sicurezze, quella voglia di rimettersi in camino. quella disponibilità al cambiamento, che da anni sembra aver perso. L’Europa ci aiuta? Qui sta la vera novità con tutti i suoi interrogativi. Io, in effetti, penso di si. Ed essenzialmente per una ragione: perchè l’integrazione dell’Italia in una realtà più ampia e più aperta, la quale si colloca (e quindi, ci colloca) ai vertici del mondo, rappresenta uno stimolo potente anche intellettuale per pensare la politica in modo nuovo, per misurarla di più sui problemi del futuro, per fare quelle cose che altrimenti sarebbe impossibile fare, e cioè dare soluzioni nuove ai problemi storici e incancreniti di questo paese. Voglio dire, in altri termini, che se è vero che alcune partite le abbiamo forse già perse, è vero anche che con l’Europa, altre si riaprono. Quella del Mezzogiorno, per esempio, che cessa di essere soltanto la questione meridionale, cioè un problema che il vecchio Stato nazionale non è mai riuscito a risolvere anche perchè era parte integrante della sua formazione storica e del suo blocco di potere. Che succede nel momento in cui il Mezzogiorno diventa la più grande regione d’Europa e una nuova risorsa possibile, nel senso di una risorsa strategica e geo-politica (oltre che economica) essendo il ponte naturale verso i popoli del Mediterraneo?Non per caso negli ultimi due anni i porti del Mediterraneo hanno registrato un vero e proprio boom di traffico e per la prima volta dopo trent’anni hanno iniziato a erodere la quota di mercato europeo dei grandi scali del Nord. Per esempio le città: il sistema urbano e dei trasporti come parte integrante della costruzione europea. Il fatto che le nostre grandi imprese multinazionali si contino con le dita di una mano pesa ma, a ben vedere, più si sviluppa una economia immateriale più contano anche le città e conta, quindi, quel tessuto urbano che solo l’Italia ha avuto senza interruzioni per 2000 anni. Voglio dire che le città contano quanto e più delle imprese per la crescita nel lungo periodo essendo il luogo dell’identità storica ma anche quello dove si addensano la ricerca scientifica, le Università, i servizi , le competenze umane più sofisticate, i luoghi dove si creano le nuove opportunità. Guardiamo a come si stanno sviluppando alcune medio-grandi città europee come nodi di reti di trasporto, di informazione, di finanza, di telecomunicazione. Si pensi a come si sono messe in rete Parigi-Londra-Amsterdam-Bruxelles-Bonn. E si misuri così il nostro ritardo. Ma è il ritardo di un paese che in questo campo ha pur sempre grandi chances. Si pensi solo al ruolo nuovo, non più soltanto nazionale che possono svolgere città come quelle grandi e civilissime capitali mediterranee che sono Napoli e Palermo. Per non parlare di Milano capitale della Padania ma anche snodo di una grande direttrice di collegamento dove la rete Nord Sud si intreccia con quella che dai Balcani va alla penisola Iberica. Sono solo esempi. Concluderei quindi come ho cominciato: guardando al problema dell’integrazione europea come a un tipo di sfida che non riguarda solo questo o quel settore ma "il più complessivo modo di vivere di una popolazione come forza produttiva". Si tratta, dunque, degli italiani e del futuro che per essi immaginiamo. Ed è per questo che aprendo la nostra discussione mi è sembrato giusto sottolineare il ruolo cruciale della politica, della grande politica, quella capace di dare al Paese fiducia in se stesso e di mobilitare le risorse che fanno la forza e l’identità di una nazione .
|



| Home | Rassegna italiana | Rassegna estera | Editoriale | Attualita' | Dossier | Reset Online | Libri | Cinema | Costume | Posta del cuore | Immagini | Nuovi media | Archivi | A domicilio | Scriveteci | Chi siamo |
