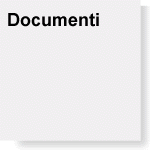| Serve un’Europa sociale? E si può fare?
Appunti di Michele Magno
Documenti collegati:
Introduzione/Dentro il laboratorio di Palazzo Chigi
La sfida dell’integrazione europea -
L’Italia alla prova (Alfredo Reichlin)
Serve un’Europa sociale? E si può fare? (Michele
Magno)
Roma, 15 febbraio 1999
1. Il governo D’Alema ha giocato molte delle sue carte sul
rilancio di un patto sociale orientato, dopo una fase di accordi serviti a spartire rigore
e sacrifici, a promuovere una programmazione negoziata dello sviluppo . Al di là dei suoi
specifici contenuti, è importante sottolineare l’orizzonte strategico in cui si
iscrive quello che si può definire l’avvio di un nuovo ciclo della concertazione in
Italia.
Per come è stato articolato (centralità della formazione, sostegno agli investimenti,
riconferma della politica dei redditi, riconoscimento esplicito del ruolo
dell’impresa minore, coinvolgimento delle istituzioni locali), il Patto del dicembre
‘98 si configura come un’operazione sorretta dal deliberato intento di
sollecitare la modernizzazione del paese, in sintonia con le scelte di fondo (di politica
economica e dell’occupazione) indicate nel vertice europeo di Vienna (11-12 dicembre
‘98).
Questo disegno è stato motivato anche dalla necessità stringente, per il governo, di
generare fiducia mostrandosi capace di reagire alla stagnazione e di offrire una
prospettiva di crescita al paese. Questo disegno, inoltre, è stato guidato dalla
necessità altrettanto bruciante, per una coalizione eterogenea e attraversata da attriti
non trascurabili, di definirsi come un soggetto non transitorio della politica italiana,
trasformando un’alleanza tattica in un blocco strategico, impegnato in un riformismo
energico e in una accorta gestione delle tensioni sociali (Berselli, 1998).
2. Ora, per corrispondere pienamente a questi obiettivi ambiziosi
occorrono almeno due condizioni. La prima è una forte riqualificazione della spesa
pubblica. Il governo ha scommesso molto sulla riqualificazione della spesa e su una
utilizzazione più efficiente delle risorse concesse ( per l’ultima volta) alle
regioni meridionali dall’Unione.
Ma per riqualificare la spesa e per bene usare i fondi europei bisogna riorganizzare,
prima di tutto, l’amministrazione statale. Per far fronte a questo imperativo è
certo indispensabile snellire procedure, tempi, meccanismi decisionali. Ma occorre, anche,
valorizzare la volontà di cambiamento di quel personale pubblico che è stanco di essere
mortificato dalla "perfezione dell’atto amministrativo" e
dall’invadenza dei politicanti. Non c’è anche quella volontà, a ben vedere,
alla base delle recenti elezioni delle nuove rappresentanze sindacali nel pubblico
impiego?
La stessa concertazione, del resto, se non è accompagnata da comportamenti virtuosi delle
amministrazioni, se avviene in contesti normativi riluttanti alla semplificazione, se
continua a scontrarsi con inefficienze e rigidità nell’attuazione dei provvedimenti,
rischia di trasformarsi in una mera iper- regolazione che galleggia sulla confusione delle
regole e delle scelte. In Italia, dunque, il funzionamento degli apparati amministrativi,
anche per le condizioni di arretratezza relativa in cui versano rispetto ai partner
europei, è una variabile strategica delle politiche di modernizzazione.
Non vorrei essere vittima di un pregiudizio, ma ho l’impressione che nella cultura
diffusa del riformismo italiano, ad onta del notevole impegno profuso dal governo sul
fronte del federalismo amministrativo, non sia ancora maturata adeguatamente la
consapevolezza di questo dato.
La seconda condizione necessaria per rendere credibili gli obiettivi del "Patto di
Natale" riguarda la riforma del sistema di protezione sociale (su cui tornerò più
avanti).
In questi giorni si è riaccesa una polemica vivace sugli "eccessi" della spesa
pensionistica. Non intendo qui entrare nel merito della questione. Ricordo soltanto, come
altri hanno già rilevato, che il contenimento della spesa avverrà, a regime, mediante
una contrazione drastica degli importi pensionistici medi (meno del 50% dell’ultima
retribuzione per i lavoratori dipendenti e circa il 30% per quelli autonomi). Ciò
dovrebbe indurre a qualche riflessione più meditata sul significato che avrebbe, per gli
equilibri politico-sociali del paese, l’appello a comprimere ulteriormente la
previdenza pubblica. Ma il punto non è questo. Il punto è se la modernizzazione del
paese è compatibile con il mantenimento di una "via bassa" della competitività
delle imprese che faccia leva soprattutto sulla riduzione dei costi, magari utilizzando, a
tal fine, i risparmi ricavabili dal taglio delle pestazioni sociali. E se ciò non
distolga l’attenzione della necessità di un’azione riformatrice di più lunga
leva, che investa la struttura interna complessiva della spesa sociale, nonchè le forme
dell’affidamento del sistema delle sicurezze dei cittadini, oggi delegato pressoché
unicamente a grandi strutture pubbliche.
3. Secondo l’economista di Harvard Paul Krugman, di fronte a shock
tecnologici che hanno portato a mutamenti dei prezzi relativi, gli USA hanno reagito
accettando maggiori diseguaglianze ma salvaguardando l’occupazione. L’Europa,
invece, ha difeso il suo modello sociale al costo di un aumento della disoccupazione. In
effetti, comparando la situazione dei paesi dell’Unione con quella americana, più di
un osservatore ha posto la questione nei termini di un’alternativa radicale: o si
accetta un approfondimento della disuguaglianza sotto il profilo dei redditi, delle
garanzie e della protezione sociale; o bisogna rassegnarsi a livelli crescenti di
disoccupazione.
Prima di argomentare una risposta più compiuta, è importante sottolineare un punto.
E’ noto che l’amministrazione Clinton, nonostante il pareggio del bilancio, non
riesce a fare la riforma sanitaria nel paese più ricco del pianeta, dove circa 40 milioni
di cittadini sono privi di assistenza . Ma è anche vero che l’elevata efficienza del
mercato interno statunitense e la sua capacità di generare occupazione aggiuntiva devono
molto all’esistenza di un quadro di diritti sociali relativamente omogeneo da Stato a
Stato. Se, inoltre, i livelli di spesa sociale negli USA sono più bassi che in Europa (
ma non di molto, se si considera la spesa pubblica e privata complessiva) gran parte di
questa spesa è di competenza federale: dalla Social Security (l’equivalente della
nostra previdenza) a Medicare (che copre l’assistenza sanitaria della popolazione
anziana).
Ebbene: chi esalta il modello americano (per la sua flessibilità) e critica il modello
europeo (per il suo sovraccarico di socialità) è disposto a tirarne tutte le conseguenze
in termini di "federalizzazione" del governo sociale comunitario? E, al
contrario, chi difende ad oltranza il modello europeo è disposto a seguire l’esempio
statunitense in termini di uniformità territoriale dei diritti sociali di base? (Ferrera,
1998).
4. Le cause della disoccupazione di cui si discute più ampiamente sono
di tre ordini. Il primo è rinvenuto nei processi di globalizzazione (v. molti analisti
americani), che per la sua intensità ha messo in crisi istituzioni e meccanismi di
controllo politico e sociale. Il secondo mette l’accento (v. Krugman) sulla
rivoluzione tecnologica, che tende a polarizzare i redditi da lavoro, in rapporto alle
dinamiche professionali, come non era più accaduto nell’era della produzione di
massa. Il terzo (v. OCSE) insiste sulle disfunzioni e rigidità dell’offerta di
lavoro.
Queste tre tesi mirano a una spiegazione della disoccupazione oggettiva, per così dire, e
onnicomprensiva. A ciascuna di esse si collega una terapia specifica. Ma, in realtà,
nessuna appare autosufficiente, pur contenendo ognuna elementi di verità.
Globalizzazione, rivoluzione tecnologica, trasformazioni del lavoro sono processi che si
intrecciano tra loro, dando luogo a una combinazione di cambiamenti al cui interno
soltanto acquista senso il problema della flessibilità, tanto dell’organizzazione
del lavoro e dei salari, quanto delle tutele dei lavoratori (Lettieri, 1998).
Si discute spesso di flessibilità come se l’economia e la disoccupazione fossero
ancora prevalentemente industriali, mentre sono i servizi a dominare nella struttura
dell’occupazione e nelle prospettive di crescita netta dei posti di lavoro. E,
allora, il dibattito sulla flessibilità diventa astratto e poco rilevante per le
decisioni politiche concrete quando evita di specificare per chi c’è bisogno di
flessibilità. Per i dipendenti a cui le aziende distribuiscono garanzie e privilegi data
la loro alta professionalità? Certamente no. La questione della flessibilità, dunque,
riguarda, solo i giovani, le donne e i lavoratori a bassa qualificazione? A questo punto,
la domanda diventa un’altra: con una più spinta deregolazione del mercato del lavoro
questi gruppi si troverebbero in una condizione migliore (meno disoccupati)? E se è
così, con quale tipo di deregolazione?
Qualsiasi discussione sulle politiche pubbliche deve sciogliere preliminarmente questo
nodo: è preferibile molta occupazione di basso livello o la disoccupazione di massa? Il
principale effetto sulla disoccupazione della tutela dei lavoratori, e in particolare
della tutela dai licenziamenti, consiste nel rendere più difficile la mobilità del
lavoro. Rigidità di questo tipo possono essere colte da diversi indicatori di turnover e
mobilità del lavoro. Ebbene: un esame comparato di questi indicatori ci dice, in primo
luogo, che i tassi di mobilità e di turnover non sono correlati con le rigidità del
mercato del lavoro (Italia e Francia, per citare un solo dato, hanno tassi di mobilità
simili a quelli americano; Germania, e, sorprendentemente, Regno Unito presentano una basa
mobilità). Questo esame comparato ci dice, in secondo luogo, che non necessariamente ci
si trova di fronte a un’alternativa secca tra maggiore occupazione e maggiore
eguaglianza. Le economie europee con le performance migliori, Danimarca e Olanda, non
hanno nulla da invidiare a quella statunitense per quanto concerne gli indici di
attività, pur mantenendo alti livelli di eguaglianza e di protezione sociale (Esping
Andersen, 1999).
5. Certo, il rapporto tra crescita e occupazione si pone in termini
profondamente diversi rispetto al passato. L’apertura dei mercati, la dislocazione
delle produzioni, lo slittamento dell’occupazione verso i settori dei servizi hanno
messo in crisi il diritto del lavoro elaborato nel corso di questo secolo e i modelli
contrattuali fondati sul paradigma fordista. Fare appello alla crescita e, quindi, a una
politica macroeconomica che ne sia la levatrice non può significare l’offuscamento
della sfida delle riforme del lavoro. Ma ciò è diverso dall’invocazione di una
flessibilità senza regole, che determina insieme ricchezza e frantumazione sociale. In
Europa esiste una componente storico- sociale della struttura produttiva da cui non
possono prescindere nemmeno gli economisti più puri. Nessuno, tuttavia, più
ragionevolmente dubitare della necessità di rielaborare i vecchi modelli di protezione
sociale. Necessità imposta dall’innovazione tecnologica, dagli stili di vita
moderni, dalle sconvolgenti modificazioni del mercato del lavoro. Questi fenomeni,
unitamente alla più alta longevità della popolazione, che rafforza - in particolare- la
richiesta di protezione sanitaria e previdenziale, hanno posto sotto stress fiscale i più
grandi sistemi di Welfare europei. Nella sua versione più estrema la risposta della
destra a questo problema è: basta abolire ogni sussidio alla disoccupazione (o quasi) e
ogni regolazione del mercato del lavoro (o quasi) per liberare risorse a vantaggio dei
più deboli.
La sfida che ha di fronte a sè il riformismo europeo, invece, è di ben altra natura.
E’ quella di "reinventare" un meccanismo di sicurezza sociale in cui
l’adattabilità del lavoro si accompagni a una rete di garanzie di base - più
universale, equa ed efficace - sui versanti del sostegno al reddito, delle tutele
previdenziali e sanitarie, dei servizi di collocamento e, prima di tutto, della formazione
professionale (Paci, 1998). Una sfida di queste proporzioni può essere vinta solo
superando la storica logica risarcitoria del movimento operaio, e cioè lo scambio tra
diritti del lavoro e politiche redistributive. Politiche i cui margini sono ormai sempre
più esigui, non tanto per le restrizioni budgetarie dettate dal Patto di stabilità,
quanto per la vertiginosa crisi di consenso che mina le fondamenta del vecchio compromesso
sociale. Se, dunque, non si ripropone con vigore, insieme alla prospettiva dello sviluppo
(nazionale ed europeo), l’obiettivo di una profonda modernizzazione del Welfare, si
subisce inevitabilmente la mutilazione dello Stato sociale. E si finisce col perdere, a
lungo andare, anche il consenso e la rappresentanza dei ceti colpiti dal
ridimensionamento.
Questa scelta strategica esige una riunificazione tra politica economica e politica del
lavoro, lungo un asse che non accantoni quello che è sempre stato uno degli elementi più
vitali della cultura riformista: il rapporto stretto tra eguaglianza, solidarietà e
sviluppo. Nella cultura della destra europea, in fondo, la richiesta di un sostanziale
smantellamento del Welfare si svolge lungo una linea ideologica precisa. Una linea che
separa l’eguaglianza, che viene rifiutata, la solidarietà, che viene accettata come
assistenza (più o meno premurosa) agli esclusi, e lo sviluppo, subordinato
all’esaltazione delle virtù operose del risparmio, fonte insostituibile del
benessere individuale (Colajanni, 1997). La riforma del Welfare deve essere affrontata a
questo livello, politico e culturale, e non semplicemente sotto il giogo delle
costrizioni, pure del tutto ineludibili, imposte dai bilanci pubblici. Se è concessa una
battuta, non si tratta di salvare solo le pensioni, ma di sapere a quale società
pensiamo.
6. Negli ultimi anni, per diminuire i costi delle politiche sociali e
aumentarne l’efficacia, i paesi europei hanno cercato di valorizzare il criterio
della selettività, subordinando all’accertamento di particolari condizioni di
bisogno e di reddito l’accesso alle prestazioni o la partecipazione al costo dei
servizi pubblici. Tutti i paesi europei, d’altro canto, hanno tentato di correggere
la natura "passivizzante" di alcuni istituti tradizionali del Welfare,
attribuendo un peso crescente all’istruzione e alla formazione, nonchè alle
politiche attive del lavoro. Ebbene: è possibile scorgere, nella congerie di questi
interventi, una linea di demarcazione tra destra e sinistra? Anzi: è necessario?
C’è chi lo nega, affermando che ci sono riforme da fare sulle quali non ha senso
distinguere tra posizioni di destra o di sinistra. Ma è proprio così? Nel caso italiano
il perseguimento della stabilità finanziaria, come la lotta per la liberalizzare
l’economia, disboscando monopoli, corporativismi, rendite e clientelismi di ogni
genere, sono solo scelte obbligate ma politicamente neutre? E, per quanto riguarda la
riforma del Welfare, dalla universale constatazione dei guasti provocati dallo statalismo
ne discende ineluttabilmente che l’unica alternativa praticabile è quella di uno
Stato sociale "residuale"?
Sarebbe auspicabile che il confronto su questi temi, a sinistra, si facesse sempre più
netto e limpido (Pennacchi, 1998).
In Italia, in ogni caso, è urgente completare un processo (appena avviato) di
riallocazione della spesa tra funzioni oggi ancora troppo squilibrate, a vantaggio della
vecchiaia e a detrimento dei giovani , della formazione, della tutela della
disoccupazione, dell’assistenza. E di portare a compimento, altresì, un processo di
riorganizzazione delle prestazioni sociali e del sistema di finanziamento. E’ infatti
innegabile che squilibri dal lato del finanziamento della spesa sociale (v.le categorie
del lavoro autonomo) si sono associati a squilibri dal lato dell’accesso alle
garanzie (come per gli assegni familiari e l’indennità di maternità).
Per questo, ragionare intorno a un progetto di "universalismo temperato", che
mantenga l’universalità di base, ma limiti l’accesso dei ceti più agiati a
determinate prestazioni, diventa un passaggio cruciale per dare concretezza e credibilità
a quella salvaguardia del modello sociale europeo che anche nel manifesto elettorale del
PSE viene indicato come un prioritario impegno programmatico.
Mi riferisco a un "universalismo temperato" che non è mediocre uniformità di
prestazioni da garantire a tutti, ma che è uno strumento attraverso il quale uno Stato
che si rispetti "crea coesione sociale". E, quindi, orienta non solo gli
investimenti in capitale umano e nelle infrastrutture, ma produce beni più generali per
la competitività di sistema, fatti anche di senso civico, di fiducia nelle istituzioni,
di attitudine a cooperare, di tessuti associativi dinamici (Pennacchi, 1998).
L’esigenza, per il nostro paese, di una maggiore convergenza verso la struttura della
spesa sociale europea sollecita uno spostamento delle risorse (innanzitutto previdenziali)
verso gli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere una maggiore mobilità
occupazionale e proteggere in modo sistematico dai rischi della povertà. Su questo punto,
mi sembrano ancora valide e attuali le indicazioni della "Commissione Onofri"
(v. la relazione finale del 28 febbraio 1997). La ristrutturazione degli ammortizzatori
sociali, infatti, deve tener conto della necessità di "evitare situazioni di azzardo
morale e di creare un sistema di incentivi che stimoli gli individui a uscire dalla
condizione di bisogno dell’intervento pubblico, in una adeguata combinazione di
diritti e di responsabilità individuali".
7. La moneta unica non è un fatto neutrale rispetto al funzionamento
dei sistemi nazionali di Welfare. Un’area economico-monetaria unificata funziona bene
se i suoi mercati sono flessibili. La flessibilità e, soprattutto, la mobilità del
lavoro vanno - come si è detto - incentivate e sostenute. Ma solo a livello nazionale ?
E’ immaginabile, per citare un solo esempio, una mobilità del lavoro
all’interno dell’Unione senza una trasferibilità dei diritti pensionistici?
Ora, una frattura tra governo sociale e governo economico non soltanto può inceppare
l’ingranaggio dell’Euro, ma innescare reazioni - sociali e politiche - di
impronta nazionalista e separatista ,suscettibili di destabilizzare l’edificio
europeo.
Sebbene oggi non sia realistica l’ipotesi di una armonizzazione forzata della
sicurezza sociale, si potrebbe fare tuttavia qualche passo in avanti in almeno tre
direzioni (che sono oggetto , del resto, dell’odierna discussione negli organismi
comunitari). La prima è l’uso più mirato verso obiettivi di coesione sociale degli
attuali Fondi e programmi d’intervento dell’UEM. La seconda è il rafforzamento
degli strumenti decisionali in alcuni campi importanti, quali il coordinamento dei regimi
di protezione sociale e della legislazione del lavoro ( nonchè l’armonizzazione
fiscale). La terza è la nascita di un circuito istituzionale in grado di controllare
seriamente le interdipendenze sistemiche tra mercato e moneta unica, tra politiche per
l’occupazione e politiche sociali (Ferrera, 1998).
Si tratta, insomma, di superare gradualmente alcuni dei più robusti ostacoli che
impediscono la costruzione di un governo sociale in Europa, a partire da quella che è
stata chiamata la "trappola della sussidiarietà". Naturalmente, ci sono ottime
ragioni per assegnare diversi ambiti di intervento alla sovranità dei singoli paesi. Ma,
come è emerso anche dal vertice informale di Portschach (24 - 25 ottobre 1998) dei capi
di governo europei , la sussidiarietà non è l’anticamera della
"rinazionalizzazione", non segna una rigida frontiera di competenze tra Unione e
Stati membri , bensì descrive l’articolazione stessa del potere pubblico europeo,
l’interna complessità del suo ordinamento (Manzella, 1998).
In definitiva, il quesito centrale è il seguente: in che misura è tollerabile (e
conveniente), nel regime della moneta unica , la persistenza di un’asimmetria tra
liberalizzazione dei mercati di dimensione europea e politica sociale di carattere
prevalentemente domestico?
8. E’ abbastanza comprensibile che Lafontaine abbia
sollevato la necessità di una concertazione degli incrementi salariali (e di un
abbassamento degli oneri contributivi) tra i paesi dell’UEM. La Germania è la
nazione europea che ha subito la più cospicua lievitazione dei costi unitari del lavoro
nell’ultimo decennio. Ed è quindi la nazione europea che, sotto parità monetarie
non più negoziabili, teme maggiormente la concorrenza salariale e il dumping sociale,
soprattutto dei paesi dell’Europa centrale e orientale candidati all’ingresso
nell’UEM.
Ora, diversi paesi europei negli anni scorsi hanno scoperto i benefici di una politica dei
redditi concordata tra autorità di politica economica e parti sociali (l’Italia ne
è stata l’antesignana con il Protocollo del ‘93). Occorre tuttavia valutare
attentamente le implicazioni di una trasposizione a livello dell’UEM di un
coordinamento della contrattazione salariale (al di là della sua praticabilità
immediata).
I vantaggi sono evidenti: la certezza di dinamiche retributive moderate e non divergenti
tra i vari paesi può facilitare una risposta positiva della politica monetaria delegata
alla BCE. Questi vantaggi vanno però commisurati con altre esigenze, perchè , a fronte
delle vistose differenze nella produttività del lavoro che ci sono tra i diversi paesi e
regioni dell’Unione, politiche salariali e contributive uniformi possono accentuare i
divari settoriali e territoriali.
In questa fase, pertanto, forse sarebbe più saggio scegliere un consolidamento del
dialogo sociale a livello europeo, che non forzi i tempi di una (oggi) improbabile
centralizzazione della contrattazione (data la radicale difformità delle tradizioni
sindacali e dei modelli negoziali). Ma che, nel contempo, sia rivolto a rendere più
omogenee le procedure e le regole di possibili accordi-quadro tra le parti , almeno sui
grandi temi dell’orario, della formazione, della flessibilità del lavoro. Basti
ricordare che l’Accordo sulla Politica Sociale, incorporato nel Trattato di
Amsterdam, se per un verso rende più democratico il processo legislativo comunitario, per
l’altro è ben lontano dal prefigurare un sistema di relazioni industriali europeo
stabile e autonomo.
Per questo non mi sembra stravagante l’idea di puntare a una legislazione europea di
sostegno alla contrattazione collettiva , che favorisca la definizione della
rappresentatività e dei possibili percorsi che diano efficacia generale agli accordi tra
le parti sociali.
Nessuna fuga verso la centralizzazione, quindi. Ma un cammino di sperimentazione delle
soluzioni migliori (a livello territoriale, settoriale, d’impresa) per la gestione
delle politiche sociali e del lavoro di interesse sovranazionale. In assenza di questa
funzione attiva del dialogo sociale europeo, i problemi del Welfare e della
disoccupazione, abbandonati alla capacità di adattamento e di reazione dei singoli paesi,
determinerebbero focolai di concorrenza all’interno dello stesso mondo del lavoro
che, per quanto involontaria, potrebbe assestare un duro colpo al nucleo di valori
fondamentali (eguaglianza e solidarietà) su cui la sinistra dichiara di voler dislocare
l’Europa del terzo millennio.
9. Spero che questo approccio prudente al tema della politica dei
redditi europea non venga scambiato come un atteggiamento rinunciatario. Sono infatti
convinto che dobbiamo avere, in un arco ragionevole di tempo, non solo un sindacato
europeo, ma anche dei contratti europei. Non ci sono più frontiere. Bisogna, allora, pur
avere qualche regolatore sovranazionale delle dinamiche retributive e di alcuni elementi
normativi essenziali di tutela del lavoro. La solidarietà è garantita soltanto dal
riconoscimento contrattuale e legislativo di soglie minime. E questo vale per
l’Europa e per l’Italia. Ma noi qui siamo di fronte a un grande problema. In un
regime di cambi fissi e di bassa inflazione, in cui il recupero del potere d’acquisto
tenderà a divenire marginale, la contrattazione salariale si sposterà inevitabilmente
verso l’impresa e il territorio, laddove si produce la ricchezza. Mentre la
contrattazione nazionale sarà obbligata a concentrarsi sempre più sulla funzione di
selezionare la griglia dei diritti basilari del lavoro.
Qui si apre un altro problema di enorme rilievo: quello di come dare voce, nella
contrattazione, ai giovani in cerca di prima occupazione, ai lavoratori precari, ai
disoccupati. In un sistema, infatti, in cui la contrattazione aziendale è gestita dagli
organismi eletti dagli occupati , quelli che ne sono fuori rischiano di essere estromessi
da ogni decisione che li riguarda. Ma, allora, si dovrebbe giustificare l’estensione
ad essi dell’efficacia inderogabile di intese dalla cui negoziazione sono esclusi.
Non si tratta solo di un problema di democrazia sindacale. Si tratta di un grande problema
politico, che tocca la capacità di tutta la sinistra di esprimere i bisogni di tutela
delle nuove forme frantumate del lavoro. E, o quei bisogni riusciamo a intercettarli, o
siamo destinati a rappresentare (e con sempre maggiori difficoltà) solo i pensionati e
quei lavoratori che stazionano nelle cittadelle del fordismo. Siamo destinati, quindi, a
perdere progressivamente capacità di rappresentanza (politica e sociale) verso
l’alto, verso quelle fasce di alta professionalità che si autotutelano sul mercato
del lavoro; e verso il basso, verso il mondo del lavoro "grigio" e sommerso ,
malamente tutelato e non tutelato.
a modernizzazione del Welfare deve saper rispondere positivamente anche a questi dilemmi.
Essa deve essere perciò l’architrave di un progetto di ricomposizione del lavoro .
Non di una ricomposizione sociale del lavoro , che è un antico mito ideologico della
sinistra. Ma di una ricomposizione possibile solo in un processo che si svolgerà sempre
più sul terreno dell’organizzazione dei diritti e delle responsabilità , e cioè in
una dimensione politica che riconosca e valorizzi la soggettività delle persone che
lavorano o che cercano non un posto qualsiasi, ma un’attività gratificante. I
diritti (e le responsabilità) sono spesso visti come un fastidioso orpello che può
ostacolare la modernizzazione. Sono invece un fattore decisivo del cambiamento. Non solo
perchè assicurano il consenso di chi deve farsi pure carico dei costi delle
trasformazioni sociali e produttive, ma perchè possono imprimere un impulso allo
sviluppo. Anche perchè possono costituire un vincolo positivo per le imprese, alla stessa
stregua di quello che abbiamo liberamente scelto con l’Euro accettando le regole del
cambio fisso e abolendo ogni spazio per la svalutazione competitiva della lira. Quegli
stessi diritti (e le relative assunzioni di responsabilità) sbarrano la strada, dunque,
ad una involuzione regressiva dell’economia, della società e della coscienza civile.
Su questo discrimine si giocano, in questo passaggio, di secolo, le sorti di quel modello
sociale di cui l’Europa moderna è stata la culla, attingendo a varie fonti: dalla
critica keynesiana dell’equilibrio spontaneo dei mercati al pensiero di Beveridge,
dall’interventismo socialdemocratico al confronto con il New Deal americano.
Riferimenti bibliografici
E. Berselli, Il Sole 24 ore, 12 dicembre 1998.
M. Paci , Più equità e meno spesa: il governo di centro-sinistra alla
prova del Welfare , in Stato e mercato, n.1,1998.
N.Colajanni, La globalizzazione, sfida per i socialisti, in Le ragioni
del socialismo, n.29, 1998.
M. Ferrera, Le trappole del Welfare, Il Mulino, Bologna, 1998.
A. Manzella, Il vertice europeo di Portschach: un appuntamento
anticipato, in Il Mulino , n.379, 1998.
A. Lettieri , Il sindacato e la politica nell’Europa
dell’Euro, in Quale Stato, n.3, 1998.
G. Espring Andersen, Politiche del lavoro e disoccupazione in Europa,
in Europa Europe, n.1-2, 1999 ( in corso di pubblicazione).
L. Pennacchi, La riforma del Welfare, in Europa Europe, n.4-5, 1998.
Documenti collegati:
Introduzione/Dentro il laboratorio di Palazzo Chigi
La sfida dell’integrazione europea -
L’Italia alla prova (Alfredo Reichlin)
Serve un’Europa sociale? E si può fare? (Michele
Magno)
|