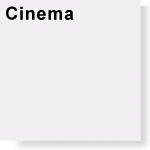|
La scissione in
ciascuno di noi
Umberto Curi
Articoli collegati:
La scissione in ciascuno di noi
Che succede se il cinema imbroglia
Mind è un termine inglese che non ha un esatto corrispettivo in
lingua italiana, e che è dunque difficilmente traducibile. Non è “mente”,
infatti, almeno non nel senso in cui questo termine è adoperato nel
campo della psicologia, vale a dire nell’accezione “tecnica” con
la quale si parla, ad esempio, di “malati di mente”, per
distinguerli dai malati “nel corpo”. E non coincide neppure
esattamente con ciò che in italiano si chiama “spirito”, in
quanto è distinto dalla “materia”, né con la “coscienza”,
che si contrappone all’inconscio, né infine con l’“intelligenza”.
Piuttosto, Mind riassume in sé tutte le determinazioni ora
ricordate, insieme ad altre sfumature (“opinione”, “intenzione”,
“memoria”), e indica dunque ciò che è insieme la “psiche”,
lo “spirito”, la “coscienza” e l’“intelligenza”. Di
conseguenza, sarebbe sbagliato, e comunque fortemente riduttivo,
tradurre il titolo del film - “A Beautiful Mind” - come “Una
bella mente”, cancellando di fatto la polisemia del termine che
compare nel titolo originale. Al di là di ogni considerazione
strettamente linguistica, infatti, una simile traduzione tende ad
accreditare la convinzione che il film intenda semplicemente celebrare
le straordinarie doti intellettuali del personaggio a cui si riferisce
la vicenda narrata, indicandolo appunto come una “bella testa”.
Non è così. Come si cercherà ora di argomentare, davvero “bello”,
anzi “pieno di bellezza” è la mind di John Nash, ma non
soltanto, e nemmeno soprattutto, perché essa metta in grado il
protagonista di elaborare teoremi matematici particolarmente
complicati e innovativi, ma perché essa contiene un mondo che è
molto più ricco e più vasto di quello della matematica. Il che
significa che a Nash è possibile attribuire l’espressione “a
beautiful mind” (dove, tra l’altro, l’associazione dell’aggettivo
beautiful al sostantivo mind è già di per sé assai
problematica), non nonostante, ma proprio in ragione
della sua schizofrenia. Difatti, è appunto questa “patologia”,
connessa in una relazione non antinomica con le sue straordinarie
capacità intellettive, a rendere davvero “piena di bellezza”
quella “mente”.
Fin dal titolo, insomma, fin dalla premeditata ambivalenza dell’espressione
in esso impiegata, si comprende quale sia uno degli assi portanti di
questa interessante opera cinematografica, vale a dire la messa in
discussione dei confini che separano la normalità dalla follia,
soprattutto quando questa normalità appartenga a un “genio”.
Evitando opportunamente ogni eccessivo indugio ideologico, Howard “argomenta”
la tesi (di per sé non nuova, neppure in campo strettamente
cinematografico) della contiguità - e, al limite, della
intercambiabilità - tra norma ed eccezione, mostrando fino a che
punto questi due presunti “stati” mentali possano essere
indisgiungibili l’uno dall’altro, con quanta “naturalezza” il
“genio” possa convertirsi in “sregolatezza”, la “normalità”
possa manifestarsi come “pazzia”.

Di qui un’importante opzione da
parte dell’Autore, quella di porre lo spettatore, almeno in tutta la
prima parte del film, nella stessa condizione del protagonista,
impedendogli di distinguere fra il mondo “reale” e quello creato
dalle allucinazioni indotte dalla malattia. Come Nash, anche chi
assiste alla proiezione è convinto che davvero esista una “eminenza
grigia”, di nome William Parcher, che davvero si tratti di
fronteggiare una minaccia nucleare sovietica sul territorio americano,
che davvero occorra contribuire allo smantellamento di una rete
spionistica potenzialmente letale per la sopravvivenza degli Stati
Uniti.
Fino alla fine, né Nash né lo spettatore potranno essere sicuri che
quelle immagini siano allucinazioni, e non presenze reali, e che
presto o tardi qualcuno sveli che l’autentico impostore non è
Parcher, ma lo psichiatra, traditore al soldo della cospirazione
sovietica. Anziché ricorrere a qualche stratagemma espressivo, allo
scopo di rimarcare la differenza fra reale e immaginario, come accade
per lo più in altre produzioni cinematografiche, Howard sceglie la
strada di un continuum, nel quale i due “mondi” si
succedano e si mescolino, senza che si dia alcuna possibilità di
scindere nettamente l’uno dall’altro.
D’altra parte, la revoca di ogni presupposta gerarchia fra i due “ordini”
di realtà, il fatto che, lungo tutto lo svolgimento del film, risulti
pressochè impossibile stabilire che cosa corrisponda al “vero” e
che cosa, invece, sia frutto di allucinazione, conduce anche a
formulare una osservazione certamente marginale, ma non priva di
interesse. La coincidenza fra l’uscita del film nelle sale
cinematografiche, e la denuncia dell’esistenza sul suolo
statunitense di una rete terroristica collegata ad Al Qaeda, da parte
delle autorità americane, potrebbe perfino accreditare un’ipotesi
maliziosa. E cioè che, non importa quanto intenzionalmente, questa
opera cinematografica suggerisca l’idea che l’allarme diffuso
intorno ad una cospirazione antioccidentale debba essere considerato
una “allucinazione”, l’effetto di una dissociazione patologica,
e non l’indizio di un pericolo reale.
Anche se i “tempi” di lavorazione del film, rispetto all’attentato
dell’11 settembre, non consentono di avallare questa ipotesi, si
può se non altro recuperarne la validità in un significato più
generale, disimpegnato dal richiamo all’attacco contro le Twin
Towers, e riferito piuttosto alla ricorrente fobia americana di poter
restare vittime di oscuri complotti. Sia pure indirettamente, insomma,
e non come tema centrale, il film propone uno spunto di non
trascurabile rilievo, vale a dire che certamente il maccartismo -
cronologicamente contestuale alle prime manifestazioni della malattia
di Nash - ma anche più in generale il timore di essere colpiti “dall’interno”,
periodicamente risorgente nell’immaginario collettivo degli
americani, siano espressione di una schizofrenia di atteggiamenti e
comportamenti, in un paese letteralmente scisso fra l’ideologia
apparentemente benevola e accogliente del melting pot, e una
prassi concreta spesso segnata dall’inospitalità e dall’intolleranza.
Al di là di questo inciso, la scelta compiuta da Howard di non
consentire allo spettatore di distinguere fra gli “stati” mentali
del protagonista, lasciandogli anzi il dubbio fino alla fine circa la
verità o l’illusorietà degli eventi che accadono, va ben oltre la
vicenda specifica del matematico statunitense. Al contrario, la forza
del film, la ragione principale per la quale esso può essere
considerato un'opera cinematografica interessante, e per molti aspetti
ben riuscita, non ha proprio nulla a che vedere con la maggiore o
minore attendibilità con la quale è ricostruita la biografia di John
Nash. A questo proposito, le discussioni fiorite a proposito della
solo parziale “fedeltà” di quanto è descritto nel film, rispetto
agli avvenimenti reali, lasciano letteralmente il tempo che trovano, e
appaiono infine del tutto prive di significato, come sintomo della
sostanziale incomprensione del “progetto”, intorno al quale è
costruita quest’opera cinematografica.
Come già è emerso, sia pure indiziariamente, attraverso le
considerazioni compiute in margine al titolo, non è certamente il
personaggio Nash, né le vicissitudini specifiche della sua esistenza,
ad attirare l’attenzione dell’Autore. Ciò che, attraverso e
oltre Nash, si trattava di indagare è il confine mobile e
reversibile che separa - ma per ciò stesso anche connette
- reale e immaginario, e dunque l’obiettiva impossibilità di
distinguere nettamente, e una volta per tutte, il dominio della
normalità rispetto a quello della follia, mostrando quanto l’una
“assomigli” all’altra, quanto “semplice” sia il transito
dall’una all’altra. Il film “lavora”, appunto, su questo
intreccio di questioni, rinverdendo una riflessione costantemente
riaffiorante in tutta la tradizione filosofica, culturale e figurativa
dell’Occidente, riguardante i confini della realtà, e più ancora
lo statuto di tutto ciò che dalla quotidianità del reale in qualche
modo “fuoriesce”, o perché ex-ceda o perché prae-ceda
tale quotidianità.
Secondo il senso comune, non vi è che un unico mondo “reale”, i
cui parametri di autenticità e valore sono al tempo stesso
indiscutibili e insuperabili. Tutto ciò che a tale mondo non sia
riconducibile, è necessariamente illusione o inganno. Di più: è a-nomalia,
malattia o follia. All’interno di un mondo così concepito, solo la
trasparente razionalità del calcolo e della misura hanno pieno
diritto di cittadinanza, mentre ogni altra forma di espressione è
degradata a de-lirio, a puro prodotto di una fantasia
allucinata e malsana.
D’altra parte, la polemica contro i seguaci del senso comune, e la
conseguente riabilitazione di ciò che non sembra appartenere al mondo
reale, è antica quanto la filosofia. Da Eraclito a Nietzsche e Freud,
attraverso Platone e Plotino, Bruno e Schopenhauer (solo per citare
alcuni nomi), alla solo apparente “ovvietà” del mondo “vero”
si è contrapposta la verità di una realtà altra e diversa,
non coincidente con la presunta “evidenza” di quella nella quale
viviamo immersi, ma insieme anche più autentica, rispetto a quella
convalidata dall’opinione dei “più”.
Contro la doxa dei “molti”, i quali agiscono e parlano come
dormienti, e non si avvedono neppure di ciò in cui si imbattono, sono
indirizzati molti dei frammenti a noi pervenuti dell’Oscuro di
Efeso. Allo stesso modo, uno dei temi ricorrenti nel Nietzsche del Crepuscolo
degli idoli , e più in generale di tutta la sua opera, è l’irrisione
nei confronti del cosiddetto “wahre Welt”, un “mondo vero”
la cui storia coincide con la Geschichte eines Irrthums, con la
“storia di un errore”, la storia del modo in cui “il mondo vero
è diventato finalmente favola”.
Indipendentemente dalle modalità talora anche molto diverse, con le
quali questa tematica è stata declinata, non vi è dubbio che negli
autori sopra citati, e in numerosi altri passaggi cruciali nella
tradizione speculativa dell’Occidente, si è riproposta
insistentemente la questione del rapporto fra due “ordini” di
realtà diversi e spesso contrapposti, e che inoltre molto spesso -
come accade anche nell’opera di Howard - si sia affacciata più o
meno esplicitamente l’ipotesi di un “rovesciamento”, in rapporto
a quanto sembrerebbe inconfutabilmente testimoniato dal senso comune.
Ricondotto al contesto del film, questo filone problematico assume la
forma di una radicale problematizzazione di quali debbano essere
considerati i “limiti”, oltre i quali il “genio” de-genera
in “follia”, di quali siano i confini entro i quali può
esprimersi una “beautiful mind”, senza precipitare nella
anormalità. Cancellando ogni segno di possibile riconoscimento fra i
diversi “stati” mentali di Nash, e dunque rinunciando a connotarli
secondo una possibile “gerarchia” di valori, o anche semplicemente
a descriverli come l’uno del tutto eterogeneo rispetto all’altro,
Howard procede oltre ogni presupposta distinzione fra essi, alludendo
alla possibilità che sempre, e non soltanto nel caso determinato del
matematico statunitense, la “normalità” può risultare
indistinguibile dalla follia, sempre la “mente” contiene non
soltanto la capacità del calcolo razionale, ma anche quella di
produrre immagini, sempre, dunque, realtà e allucinazione si
confondono e si integrano in un continuo, sul quale è impossibile
intervenire scindendo nettamente un aspetto dall’altro.
Di più. Conferendo alla vicenda di John Nash il carattere di un vero
e proprio paradeigma, l’Autore intende sottolineare che la scissione
non è affatto l’indizio di una patologia isolata e circoscritta,
che possa essere attribuita ad un singolo individuo, come tale diverso
dalla generalità degli uomini, ma che al contrario essa è
connaturata a ciascuno di noi, ci appartiene costitutivamente, segna
il destino di chi - come Edipo, potentissima icona della condizione
umana - sconta su di sé la moira dell’impossibilità di
essere soltanto uno. In Nash ritroviamo, insomma, pienamente espressa,
condotta alle sue manifestazioni più estreme, una duplicità
che è essenziale a ciascuno di noi, anche se rimossa, o peggio ancora
nascosta, per evitare la disapprovazione o l’emarginazione sociale.

La coercitiva reductio ad unum,
realizzata mediante la somministrazione del coma insulinico o dell’elettroschock,
non è necessariamente il tramite, attraverso il quale si riconquista
uno status di presunta normalità, ma può essere anche vista
come una mutilazione, come la soppressione violenta di un intero mondo
che appartiene alla nostra interiorità, e che può essere
giustificata solo con l’incapacità di tollerare la duplicità, e di
accogliere pienamente la diversità, da parte della società nel suo
insieme.
Questo ragionamento - che in altri casi si stenterebbe a giudicare
persuasivo - diventa pressochè inoppugnabile allorchè ci si misuri
con una vicenda, quale è quella di John Nash, nella quale la
questione si pone senza alcun margine di possibile equivoco. La “mente”
che partorisce allucinazioni e pretesi “inganni”, che dà vita a
personaggi inesistenti, che spinge il protagonista a scrutare i
possibili codici segreti nascosti in inoffensivi articoli di giornali
e riviste, è la stessa mente che produce teoremi innovativi,
destinati a dilatare i confini delle conoscenze in campo scientifico.
Nessuno potrà dubitare del fatto che questa patologia sia
letteralmente l’altra faccia di una normalità talmente
solida, da potere essere additata come caso emblematico del potere
dell’intelletto. Né si può immaginare forma più compiuta e
trasparente di razionalità, di quella della matematica.
Nonostante tutto ciò - o, meglio, proprio in ragione di tutto questo
- Howard ci dice che proprio quella ragione è pregna dell’illusione,
proprio quel genio sconfina in ciò che, per pigrizia, o
ignoranza, o viltà, preferiamo chiamare follia. E ci ammonisce
anche a cogliere, in quella palese duplicità, nel manifestarsi più
appariscente di quella scissione, le tracce di qualcosa che ci
riguarda tutti, del quale nessuno può ritenersi immune.
Ma quello appena descritto, pur essendo certamente il più importante
e il più “risolto”, anche in senso strettamente cinematografico,
non è l’unico tema filosofico ravvisabile nel film. Accanto ad
esso, è possibile individuare almeno un secondo filone problematico,
sebbene meno originale, oltre che trattato in una forma meno
convincente, rispetto al primo. La parabola esistenziale di John Nash,
la sua personale esperienza, compendiata nel discorso pronunciato in
occasione del conferimento del premio Nobel, è testimonianza di un
assunto ben noto nella filosofia moderna e contemporanea, almeno a
partire dal Seicento. Prima di Nash, infatti - e in termini
incomparabilmente più rigorosi - un altro grande matematico, le cui
ricerche pionieristiche avevano dischiuso prospettive ancora più
innovative, di quelle aperte dallo studioso americano, aveva sostenuto
la superiorità delle “ragioni del cuore”, nei confronti delle “ragioni
dell’intelletto”.
Per quanto potente possa essere l’esprit de geometrie, aveva
scritto Blaise Pascal nel pieno del XVII secolo, esso deve soccombere
di fronte a un esprit de finesse che è capace di procedere
più in profondità nell’indagine che riguarda la vita umana. La
matematica pura, e più ancora la sua applicazione nel campo della
meccanica e della tecnologia, potrà indubbiamente consentire
risultati sbalorditivi, e un progresso apparentemente illimitato delle
conoscenze. Ma nessun incremento quantitativo della razionalità
geometrica potrà illuminare ciò che si sottrae ai “lumi” della
ragione, e che soltanto per altra via, valorizzando e mobilitando
altre risorse e strumenti differenti, potremo cercare di penetrare,
senza avere comunque la pretesa di una risposta definitiva a problemi
che non possono che restare indefinitamente aperti.
Il discorso finale di Nash, ma prima ancora la “morale” che egli
stesso riconosce di aver appreso dall’amore della sua donna,
riprende questa tematica, lasciando emergere talora un’intenzione
vagamente predicatoria e moralistica, di per sé non necessaria e anzi
perfino contraddittoria, rispetto alla sobrietà con la quale il film
lavora sugli altri temi in precedenza descritti. Sia pure con questi
limiti, i quali confermano l’inviolabilità di alcune regole non
scritte, imposte alle produzioni cinematografiche di marca
hollywoodiana, A Beautiful Mind è un esempio complessivamente
riuscito della possibilità di trasformare un racconto biografico, che
avrebbe potuto essere piatto e convenzionale, meramente celebrativo di
un grande personaggio, in una ricerca intorno a ciò che attiene più
specificamente alla condizione umana, al potere della mente, e agli
abissi del cuore, alla sua esaltante grandezza e insieme alla sua
irreparabile miseria . E a ciò che di essa continuerà a
rappresentare un mistero inesplicabile.
Articoli collegati:
La scissione in ciascuno di noi
Che succede se il cinema imbroglia
Vi
e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di
vista cliccando qui
Archivio Cinema
|