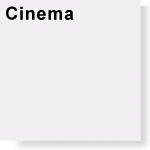|
A proposito
di Moulin Rouge
Umberto Curi
Articoli collegati:
A proposito di Moulin Rouge
Moulin
Rouge, o la love story che ci meritiamo
Abitualmente considerata - del tutto a torto - alla stregua di un mero
espediente tecnico, la mise en abyme, ove sia utilizzata non
soltanto come inerte prova di virtuosismo compositivo fine a se
stesso, ma come strumento espressivo capace di moltiplicare la
potenzialità del racconto, può assurgere a indizio di una struttura
narrativa ottimamente costituita. L’origine di questa espressione,
tratta dal linguaggio araldico- da una disciplina delle immagini,
dunque - risale come è noto al Journal di Andrè Gide, là
dove si allude alla relazione speculare intercorrente fra la “cornice”
e il “contenuto”.
Ciò che nella simbologia araldica appare come rapporto di
coimplicazione, tale per cui il significato della “figura” che
appare nel campo è inscindibile dalla valenza semantica di ciò che
ne costituisce lo “sfondo”, nell’ambito della letteratura si
presenta come corrispondenza fra due, o più, trame narrative, fra
loro connesse mediante una relazione di corrispondenza. Alle numerose
esemplificazioni desunte dall’ambito della letteratura (dal racconto
di Demodoco nel libro XII dell’Odissea, fino alla 612ma delle
Mille e una notte, o all’Amleto di Shakespeare,
attraverso una molteplicità di casi letterari illustri o meno noti),
è possibile far corrispondere una vera e propria proliferazione di
opere cinematografiche, nelle quali la myse en abime è
impiegata con esiti più o meno pregnanti.
Solo per menzionare alcuni esempi recenti, la costruzione del racconto
cinematografico attraverso la mutua implicazione fra due distinti “livelli”
narrativi, è particolarmente evidente ne La donna del tenente
francese e in Shakespeare in love, nei quali anzi il “compimento”
della vicenda “principale” avviene attraverso ciò che accade
nella vicenda “secondaria”, sicchè le due “storie” appaiono
indissolubili l’una dall’altra, e resterebbero incomprensibili (o
resterebbero prive di conclusione) ove mancasse il legame che le salda
strettamente.
Ma ancora più impegnativo è l’uso di questo fondamentale paradigma
narrativo in Film rosso, nella famosa trilogia di K. Kiezlowsky,
e prima ancora in Mr. Klein di J. Losey. In tutti i casi
citati, e in gran parte di altre opere cinematografiche passate o
recenti, il ricorso alla tecnica della costruzione speculare, scandita
nelle due fasi dello sdoppiamento della storia, e della istituzione di
una inscindibile corrispondenza fra i due piani narrativi così
costruiti, obbedisce ad una pluralità di funzioni espressive.
Da un lato, infatti, esaltando massimamente la peculiarità del “mezzo”
cinematografico, prima fra tutte il disimpegno dalla dimensione
puramente crono-logica del tempo, è possibile sviluppare la
contemporaneità di eventi diversi in termini rigorosamente relativistici,
vale a dire come simultaneità relativa al sistema di
riferimento, rappresentato dallo spettatore. Dall’altro lato, la
moltiplicazione dei livelli del racconto concorre molto spesso a
rendere più problematica, non univoca, assai più “aperta” ad
esiti e interpretazioni diverse, la stessa struttura della storia,
della quale si può talora intuire la virtuale moltiplicazione
indefinita, garantita dalla corrispondenza speculare instaurata fra le
vicende descritte.
Requisito essenziale e irrinunciabile per la funzionalità della mise
en abyme è la piena autonomia di ciascun piano narrativo, e al
tempo stesso l’esistenza di una connessione non meramente estrinseca
fra i diversi piani. Ciò significa che, quanto al primo punto, è
necessario che, almeno di principio, ogni vicenda risulti
comprensibile iuxta propria principia, vale a dire senza
riferimento ad altro se non a se stessa; mentre, per converso, è
altrettanto indispensabile che la specularità della relazione fra i
livelli non appaia frutto di una mera giustapposizione operata ex
post, ma si presenti piuttosto come conseguenza della “logica”
immanente nel racconto.
Raffinatissimo esempio di un uso estremamente sofisticato della mise
en abyme, caso paradigmatico di applicazione al cinema della
concezione einsteiniana del tempo, Moulin Rouge esibisce la
simultanea compresenza di ben quattro distinti piani di narrazione,
ciascun provvisto di un proprio “tempo”, ciascuno organizzato
secondo una plausibile successione di eventi, e insieme correlato
specularmente agli altri tre.
Procedendo, per così dire, dall’“esterno” all’“interno”,
il primo “strato” è quello costituito dall’apertura (iniziale)
e dalla chiusura (finale) del sipario, a pieno schermo, con l’unica
figura appena distinguibile del direttore di orchestra. A voler
sottolineare che ciò che si colloca “dentro” questa cornice è spettacolo,
non storia, è rappresentazione, non realtà. E
che, di conseguenza, anziché pretendere di trovarvi descritta la verità
oggettiva, occorre piuttosto accontentarsi della verosimiglianza.,
vale a dire proprio dell’unico obiettivo al quale, già secondo la Poetica
di Aristotele, può essere finalizzata la poesia.

Protagonista del secondo livello
narrativo è il “giovane scrittore”, ritornato a Parigi, per
adempiere alla promessa fatta alla donna amata. Lo si vede pallido e
sofferente, ornato da una folta barba bruna, mentre intraprende - e,
alla fine del film, conclude - la scrittura dell’infelice storia d’amore
che lo ha legato alla bella Satine. Di qui il fatto che ciò a cui
stiamo per assistere, e cioè lo svolgimento della vicenda che vede
come protagonisti la ballerina e lo scrittore, è il contenuto di
un racconto, la pura e semplice raffigurazione di ciò che
è scritto nelle pagine di un romanzo, la traduzione in immagini di
parole scritte.
Penetrando fulmineamente nel cuore di Parigi, risalendo Montmartre,
fino all’interno del Moulin Rouge, fino al primissimo piano
del volto demoniaco di Ziedler, la macchina da presa non fa che
obbedire a ciò che la scrittura impone, si limita a translitterare,
a trasferire in icone, il contenuto del racconto - di un
racconto il cui autore è implicato in prima persona nello svolgimento
della vicenda.
Si comprende così per quale ragione di fondo il terzo livello
narrativo, quello che descrive le peripezie dei due giovani amanti,
fremente di suoni e colori, esagitato e appassionato, sensuale e
lugubre, violento e commosso, comico e tragico, comunque sempre
emotivamente smisurato, visto che è la memoria del
protagonista, ancora fortemente coinvolto nella storia, e non l’occhio
freddo di un “terzo”, la fonte da cui scaturisce la narrazione. E
si comprende, dunque, per quale motivo tutto nel film ecceda ogni
possibile “misura”, tutto appaia caricato ed estremistico;
per quale motivo le immagini si susseguano così freneticamente, le
musiche si impongano fino a frastornare lo spettatore, il gioco
cromatico e luminoso raggiunga effetti psichedelici.
Perché ancora viva e palpitante è, nel ricordo del giovane, quella
drammatica storia d’amore. Perché non ancora spenta è la passione,
non ancora sopito è il dolore, non ancora lenita è la sofferenza.
Ciò che impropriamente potrebbe sembrare mera concessione all’illusionismo
delle immagini, al perseguimento compiaciuto di puri e semplici “effetti”
acustici o visivi, è viceversa espressione coerente della forza con
cui, nella memoria di colui che l’abbia vissuta, permangono le
tracce di un’esperienza amorosa breve ma intensissima.
Specularmente corrispondente a questa vicenda è, infine, il contenuto
che si incontra nel quarto “strato” del film: qui lo scrittore e
la ballerina sono diventati rispettivamente lo “squattrinato
suonatore di sitar” e la “cortigiana”, mentre lo spietato Duca
ha assunto le sembianze di un maharajah non meno crudele. Il vertice
di questo complicatissimo intreccio, tenuto in equilibrio in maniera
davvero magistrale dal regista, si raggiunge nelle sequenze dedicate
alla prima rappresentazione dello show (“Spectacular spectacular”,
“nient’altro che spettacolo”, si potrebbe tradurre restando
aderenti al “senso” di questa insolita locuzione).
Qui la mise en abyme è pienamente valorizzata in tutta la sua
potenzialità espressiva, in un gioco di corrispondenze realizzato con
meticolosa precisione, fino alla grande suggestione di un epilogo nel
quale entrambe le “storie” - quella ambientata a Parigi, e quella
rappresentata in India - giungono simultaneamente a conclusione, da un
lato seguendo ciascuna uno svolgimento “autonomo”, e dall’altro
attraverso l’intersecarsi dei due piani narrativi, saldati insieme
mediante la “canzone degli amanti”, che segna la finale
riconciliazione fra lo scrittore-suonatore e la ballerina-cortigiana.
Si può notare infine, a conferma di una capacità di “chiudere”
in maniera del tutto convincente, che il finale della duplice
storia, è anch’esso duplice: Christian ritrova Satine
e al tempo stesso la perde.
Conformemente alle regole alle quali sono improntati i grandi
archetipi della tragedia attica, e di quella shakespeareana, nel
momento stesso in cui la vicenda sembra giungere al suo esito lieto,
si assiste ad una catastrofe - dalla felicità alla sventura.
Proprio quando sembra preannunciarsi uno scioglimento positivo dell’intreccio,
un evento traumatico (qui la consunzione per tisi della bella Satine)
rovescia in senso infausto il compimento della storia.
D’altra parte, per procedere più a fondo nell’analisi del film,
il riferimento appena compiuto a modelli “alti” (quali quello
della tragedia classica e della sua moderna reviviscenza nella
drammaturgia del Bardo ), apparentemente incongruo per un film che
potrebbe essere considerato rilevante solo sul piano della gastronomia
cinematografica, è legittimato da una molteplicità di motivazioni
diverse. Anzitutto, non vi è dubbio che, per esplicita ammissione
dello stesso Autore, Moulin Rouge completa la “trilogia”
(omaggio indiretto ai paradigmi classici), iniziata con Ballroom e
proseguita con William Shakespeare’s Romeo+Juliet, vale a
dire con opere apertamente ispirate agli schemi del componimento
tragico.
Perfino l’originalissima utilizzazione delle musiche, nettamente al
di fuori della matrice hollywoodiana del musical, dove gli
intermezzi cantati o ballati quasi sempre nulla aggiungono alla
storia, e si limitano semplicemente a ripeterne alcuni passaggi,
mostra che Luhrmann intende ricollegarsi direttamente ad una
tradizione drammaturgica, quale è quella attica, nella quale la
melopea gioca un ruolo decisivo nella costruzione complessiva dell’intreccio
teatrale. In Moulin Rouge, infatti, canzoni e coreografie
obbediscono alle stesse regole alle quali erano ispirati gli
interventi del coro greco, e dunque non emergono come semplici
iterazioni di spezzoni dell’azione drammatica, in funzione puramente
decorativa o degustativa, ma come parti integranti di essa, quali
suture fra momenti diversi della storia, descrizioni di antefatti, o
di eventi fuori-scena, manifestazioni di sentimenti o di riflessioni
dei personaggi coinvolti nella vicenda. A tutto ciò si aggiunga,
infine, che la relazione speculare istituita fra il terzo e il quarto
“strato” della narrazione, fra la vicenda amorosa ambientata a
Parigi, e quella collocata in India, si presenta scopertamente come un
tributo alla tragedia shakespeareana, e segnatamente a quel finissimo
uso della mise en abyme rintracciabile nell’Amleto.
Occorre sottolineare, d’altra parte, che lo stretto rapporto con
i modelli classici (realizzato con grande leggerezza, senza alcuna
pedanteria erudita, o velleità esibizionistiche, anche se in termini
estremamente rigorosi) non è limitato né a qualche sporadica “citazione”
estrinseca, e neppure soltanto ad una più intima, e più
significativa, consonanza sul piano della struttura narrativa. Ancora
più rilevante, letteralmente decisiva per una adeguata comprensione
di quest’opera così complessa e ambiziosa, così prodigiosamente spettacolare,
e insieme così impegnativa dal punto di vista della ricerca
linguistica e intellettuale, è il tema che è posto alla base dell’opera,
e le modalità specifiche con le quali esso è affrontato e
sviluppato.
“Above all things, the story is about love” - “si tratta
sopra ogni altra cosa di una storia d’amore”, scrive Christian a
conclusione della vicenda. Quasi a scuotere lo spettatore che sia
rimasto travolto da quella sorta di tornado sensoriale scatenato in
precedenza, Luhrmann ricorda - in maniera forse anche troppo esplicita
- che ciò di cui “parla” il film, e dunque anche il piano
comparativo sul quale esso si colloca, i “modelli” con i quali
esso intende interloquire, gli stessi criteri di valutazione che
occorre impiegare nel giudicarlo, sono quelli che riguardano una story
about love.
Quanto sia ricca e variegata la tradizione alla quale, con questa
scelta, l’autore australiano ha inteso riferirsi, e conseguentemente
quanto ardua sia la sfida che egli ha inteso lanciare, cimentandosi su
questo terreno, dovrebbe risultare immediatamente evidente. Di stories
about love, e quasi sempre di storie con le quali sembra
impossibile, più che difficile, poter oggi competere con un qualche
probabilità di successo, è piena la cultura occidentale. Dal
patrimonio mitologico arcaico e dalla lirica greca e latina,
attraverso il romanzo medioevale e la tragédie classique, fino
alla letteratura romantica e alle sue riprese novecentesche, l’amore
è stato al centro di una molteplicità di storie, assurte spesso a
paradigmi insuperabili di perfezione artistica. Saffo e Ovidio,
Chrétien de Troyes e Petrarca, Flaubert, Goethe e Tolstoj, sono solo
alcuni dei moltissimi nomi illustri che si potrebbero citare per
ricordare quanto in ogni senso “alta” debba essere considerata la
tradizione culturale, alla quale Luhrmann si è rapportato con un’opera
programmaticamente about love.
Ma si dovrebbe anche aggiungere che un ininterrotto e non meno
impegnativo filone di ricerca è possibile rintracciare anche dal
punto di vista filosofico, lungo una linea che da Platone e Agostino,
attraverso Spinoza e Rousseau, giunge fino a Hegel, Kierkegaard e
Scheler ( intorno a ciò si veda il mio La cognizione dell’amore.
Eros e filosofia, Feltrinelli, Milano 1997).
Ebbene, nonostante l’evidente temerarietà di un confronto con
modelli di tale levatura, e i rischi con esso connessi, non solo il
regista australiano si è posto consapevolmente su questo piano, ma ha
anche scelto di riprendere, con i propri strumenti espressivi,
specificamente il nucleo centrale delle tante “storie d’amore”
fiorite nella cultura occidentale attraverso i secoli - vale a dire la
tematica dell’amore impossibile, condannato allo scacco,
intrinsecamente esposto all’esito tragico, segnato dal fatale
intreccio con la morte. In maniera del tutto trasparente, la vicenda
di Christian e Satine ricalca da vicino - e con una forza suggestiva
non inferiore - le peripezie di altre celebri “coppie”, Eco e
Narciso, Eros e Psyche, Lancillotto e Ginevra, Tristano e Isotta, in
modi diversi tutte inchiodate ad un destino infelice. Come accade per
costoro, anche per il penniless poet e la bella ballerina del Moulin
Rouge, l’amore inestinguibile che li lega funziona insieme anche
come fonte di conflitti e tormenti, e infine come origine di una
irredimibile infelicità.
Ma l’ambizione di Luhrmann (peraltro sostanzialmente giustificata,
visti i risultati conseguiti con un’opera cinematografica davvero
memorabile) non si limita a instaurare un rapporto con le storie
genericamente riconducibili allo schema dell’amore impossibile,
perché si richiama direttamente a quella che è forse, fra le molte,
la più enigmatica e pregnante, la più suggestiva e inquietante, vale
a dire il mito di Orfeo e Euridice. Per lo più volgarmente
banalizzata in molte ricostruzioni moderne, edulcorate con la
giustapposizione ab extrinseco di un finale lieto ( si pensi,
ad esempio, al melodramma di Monteverdi), la storia originariamente
raccontata da Ovidio e Virgilio conserva tuttora una potenza
evocativa, e una carica problematica, ancora più intense di ciò che
è possibile rintracciare in altri mythoi apparentemente
analoghi. Dell’impianto originario, Luhrmann conserva il tratto in
assoluto più caratterizzante, vale a dire la coincidenza fra i due
opposti esiti possibili della vicenda, fra la provvisoria riconciliazione
dei due amanti, conseguita grazie al canto di lui, e la loro
definitiva separazione, determinata dalla morte di lei.
Tutto ciò esalta la natura costitutivamente doppia dell’amore: il
suo non potere essere soltanto unione, senza essere al tempo stesso
divisione, appropriazione senza perdita, appagamento senza
insoddisfazione, felicità senza dolore, vita senza morte. Mai
Christian, poeta come Orfeo, potrà ricondurre alla luce
Euridice-Satine, senza perderla nelle tenebre degli Inferi; mai egli
potrà salvare la sua sposa, senza insieme condannarla. Sul sentiero arduus,
obscurus, caligine densus opaca, Orfeo è davvero il simbolo dell’amore,
lacerato fra la ricchezza di un’insperabile
restituzione e la penuria di una perdita incombente.

Nessun eroismo potrà infrangere
il legame che connette l’una all’altra, nessuna ars,
neppure quella del canto, potrà consentire una riconciliazione
che non sia insieme separazione. Dagli oscuri recessi del
Tartaro nessuno può sperare di uscire, portando con sé la vita. Ciò
che è concesso, non è il chiarore abbagliante di una luce senza
ombre - come quella di cui Satine è letteralmente circonfusa alla sua
prima apparizione in scena, allorchè compare appunto come uno sparkling
diamond - ma quell’incerto chiaroscuro (dominante in tutte la
parte finale del film), nel quale ciascuno deve cercare la propria
strada, assistito soltanto dalla speranza.
Non vi è poesia, non vi è canto, non vi è arte che possa strappare
definitivamente eros dalla sua connessione con thanatos.
Nulla meglio dell’amore può esibire il fondamento stesso della
condizione umana: il suo non potere essere altro che speranza - e
dunque il suo disperare di una compiuta salvezza (per una
interpretazione in chiave filosofica del mito di Orfeo, vedi La
cognizione dell’amore, pp.91-161).
Rispetto a questa complessa trama concettuale, soggiacente al mito
antico, la cui pregnanza filosofica è immediatamente evidente, Moulin
Rouge opera su un duplice registro. Da un lato Luhrmann si attiene
con grande scrupolo alla filigrana originaria (ovidiano-virgiliana)
del mito, evitando contaminazioni con versioni successive e non
cedendo ad alcun compromesso con i canoni hollywoodiani dell’happy
end. Dall’altro lato, l’autore australiano intreccia la storia
di Orfeo e Euridice con quella di Romeo e Giulietta, alla quale egli
aveva dedicato l’originale rivisitazione del suo film precedente. Ne
risulta un’opera nella quale il tema dell’amore infelice è
ricondotto al suo fondamento speculativo più profondo, costituito
dall’inscindibile connessione che collega eros a thanatos.
L’assolutezza del possesso, a cui aspira l’amore, non può che
convertirsi nell’assolutezza della perdita, di cui dice la morte.
Quanto più intensa, autentica, totalizzante, è la passione che lega
i due amanti, tanto più inesorabile sarà il loro destino. La
malattia di Satine si manifesta in perfetta simultaneità con l’accendersi
dell’amore per Christian, con l’espandersi di quell’amore si
espande, con il finale compimento di esso si compie. La tisi che
nascostamente consuma dall’interno il “diamante splendente” non
è altra cosa dall’amore che ella sente crescere dentro di sé.
Entrambi protesi a possederla totalmente, amore e morte si alimentano
vicendevolmente, fino a fondersi l’uno nell’altra. Quando, alla
fine della storia, ella si accascia nelle braccia dell’amato, non è
possibile dire chi abbia “vinto” - se, come soltanto appare,
è la gelida ala della morte, ovvero il caldo rifugio dell’amore.
Quello che è certo, è che Satine non ha più difese. Il suo
cedimento è incondizionato. Guardandola completamente abbandonata
nell’abbraccio del suo amante, con Virgilio che si riferisce ad
Orfeo si potrebbe ripetere: “vicit Amor!”.
Ma per quanto possa suscitare commozione, la triste vicenda dell’amore
fra Christian e Satine non appartiene al nostro mondo. Essa è
inserita in quel singolare microcosmo, sgargiante di colori e
ribollente di suoni, chiamato “Moulin Rouge”. E’ una storia che
fa parte di uno spettacolo - anzi di quello show per antonomasia che
si può chiamare “spectacular Spectacular”. Come avverte Luhrmann,
mostrando il sipario rosso che cala sulla scena dopo l’ultima
inquadratura, l’amore impossibile fra il “poeta squattrinato” e
il “diamante splendente”, la totale autenticità di quella
passione, il suo perfetto estremismo, la sua irriducibilità ad
ogni compromesso, la sua essenziale identità con la morte, sono oggi
concepibili solo all’interno di una realtà che è lontana e
diversa, rispetto alla mediocrità senza eroismo nella quale siamo
immersi. Appartengono ad un mondo nel quale neppure la morte può
prevalere perché, nonostante tutto, “ lo spettacolo deve andare
avanti”.
Articoli collegati:
A proposito di Moulin Rouge
Moulin
Rouge, o la love story che ci meritiamo
Vi
e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di
vista cliccando qui
Archivio Cinema
|