
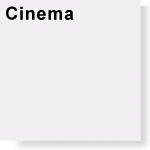
| Considerazioni veneziane/ Il cinema internazionale è vivo - nelle periferie Adriano Aprà
La Mostra si è aperta con l'attesissimo Eyes Wide Shut (cioè "Occhi barrati" o "sprangati") di Stanley Kubrick. La morte improvvisa del regista, il segreto che ha circondato autore e film, il prestigio crescente della sua opera (a cui Venezia aveva contribuito con una retrospettiva itinerante due anni fa) hanno contribuito a montare una campagna mediatica di proporzioni intollerabili, che ha trovato il suo terminale in questa anteprima europea. Come ogni forma di pubblicità, anche questa era fondata sulla menzogna, che né la visione del film (vanificando tutto il chiacchiericcio a sfondo sessuale) né certi dati di fatto precisati dai pochi che hanno avuto un contatto diretto con Kubrick (p. es. la rivista "Positif" e il suo direttore Michel Ciment) sono riusciti a contrastare. L'evento ha condizionato l'opera, il sentito dire ha prevalso sulla verità, come ormai avviene per tanti messaggi mediatici. Le pretese audacie sessuali del film hanno addirittura influenzato la visione di altre opere da parte di quotidianisti alla ricerca di "ombrelli" sotto i quali raccogliere i titoli presenti a Venezia. Come nel film di Kubrick, così in altri film visti alla Mostra (Guardami, Bugie, Une liaison pornographique) non è il sesso di per sé a essere al centro dell'interesse ma il rapporto di coppia o il corpo. Kubrick è uno dei rari sperimentalisti overground rimasti, capaci di coniugare il cinema ad alto costo con la libertà espressiva propria in genere di opere meno condizionate economicamente. L'invenzione è tuttavia in questo suo film meno evidente che in altri. Il tema è tradizionale: una coppia altoborghese apparentemente unita mette involontariamente alla prova il proprio matrimonio attraverso confronti paralleli con le proprie pulsioni, per ritrovarsi alla fine (forse) più unita di prima; una celebrazione del matrimonio, si potrebbe dire, o meglio della necessità di sottoporlo a periodica verifica. E' un tema comune a film così diversi come Aurora (1927) di Murnau, L'orribile verità (1937), commedia di Leo McCarey con Cary Grant e Irene Dunne, Viaggio in Italia (1954) di Rossellini, con la Bergman e George Sanders o Dall'oggi al domani (1997) di Huillet-Straub, da un'opera di Schoenberg del 1929-30, che forse, anche per una possibile influenza diretta, è il parente più prossimo di Doppio sogno (1927), il racconto lungo di Schnitzler dal quale il film di Kubrick è liberamente tratto. Nell'affrontare un tema intimista, il cui unico precedente è Lolita (1962), Kubrick ricorre al suo inconfondibile stile espressionistico, esalta e esaspera ogni dettaglio per rendere emblematico - Lui, Lei, la Coppia, l'Altro - ciò che apparterrebbe di per sé alla dimensione del quotidiano. La tensione all'astrattezza o all'universalità latente in uno stile espressionistico si scontra poi, in questo caso, con due attori come Tom Cruise e Nicole Kidman che restano sospesi fra la loro icona mediatica e il tentativo di annullarla in una dimensione più spontanea: né autentici eroi né modelli dell'uomo e della donna qualunque. Ciò che inoltre mi ha lasciato perplesso a una prima visione (ma i film di Kubrick meritano sempre di essere rivisti) è la volontà di dare una spiegazione logica e univoca al mistero così meticolosamente costruito. Paolo Cherchi Usai (su "Segno Cinema" n. 99, settembre-ottobre 1999) solleva il dubbio che la lunga scena fra Cruise e Pollack verso la fine - in cui sono concentrate molte di queste spiegazioni - sarebbe stata tagliata da Kubrick se ne avesse avuto il tempo. Da parte mia sarei portato a credere che siano state aggiunte successivamente due brevi voci fuori campo che ribadiscono dettagli dell'intreccio che avrebbero potuto creare difficoltà di comprensione allo spettatore medio abituato all'ascolto distratto della televisione. Alla categoria del "cinema intelligente ma da pubblico", quello che la critica si augura di vedere nei festival e poi nelle sale, appartengono tre film anglofoni d'autore: Topsy-Turvy di Mike Leigh, Holy Smoke di Jane Campion (entrambi in concorso) e Sweet and Lowdown di Woody Allen, nonché il cinese Yi ge dou bu neng shao (Non uno di meno) di Zhang Yimou, che ha vinto immeritatamente il Leone d'oro.
Topsy-Turvy è una piacevole rievocazione di alcuni momenti della vita della celebre coppia di autori di operetta inglesi di fine Ottocento Gilbert & Sullivan. Cambiando decisamente registro rispetto al naturalismo estremo dei suoi film precedenti, Leigh riposa, con indubbia abilità, sul terreno sicuro di un cinema post-viscontiano, rischiando l'accademismo. La Campion fa in un certo senso il percorso inverso in Holy Smoke: abbandona l'accademismo della rievocazione storica che l'ha resa celebre con Lezioni di piano e Ritratto di signora per tornare a indagare i labirinti della psiche come nel suo primo lungometraggio per il cinema, Sweetie (1989). Ma non riesce a liberarsi dalle convenzioni del cinema industriale nel tratteggiare lo scontro spirituale-erotico dei due protagonisti, le cui tensioni restano inespresse sullo schermo, dichiarate e non vissute, mentre è semmai il coro grottesco che li circonda a emergere con più convinzione. Perfetto mi è sembrato Sweet and Lowdown, in cui Allen utilizza un materiale finto-vero che fa pensare a Zelig (1983) e avvolge tutto con un'ironia piena di calore che rimanda a Broadway Danny Rose (1984), cioè a due dei suoi film più belli; quasi che il distacco dal suo consueto e spesso ripetititivo temario naturalistico-borghese - penso anche all'espressionistico Ombre e nebbie (1992) e al musical Tutti dicono I Love You (1996) - gli consentisse una maggiore fantasia e una più libera invenzione. Il Leone d'oro a Non uno di meno conferma l'equivoco su un regista abile e furbo come Zhang Yimou, capace di adattare il suo eclettico stile a seconda del tema trattato. Stavolta Yimou fa il verso a Kiarostami, naturalmente sottolineando ciò che nell'iraniano è solo suggerito, con risultati comunque fra i meno irritanti della sua carriera. Ai margini di Hollywood si collocano tre film statunitensi: Jesus' Son, opera seconda della neozelandese, ora americanizzata, Alison Maclean (in concorso); Getting to Know You, opera prima di Lisanne Skyler; e julien: donkey-boy (scritto proprio così, tutto minuscolo), opera seconda di Harmony Korine. Sono tre esempi diversi e stimolanti di cinema indipendente.
Jesus' Son rievoca gli anni '70 con una narrazione frantumata, sospesa, lacunosa. Le singole scene non sono sottoposte a un rapporto di causa-effetto con quanto precede e segue. E' una narrazione vagabonda, come il protagonista, dove ogni momento acquista una sua autonomia e una sua densità plastica ed emotiva. Il film è fatto di tante piccole "esperienze", che addizionandosi finiscono per costituire un destino. Abbandonandosi al flusso degli accadimenti con una sorta di innocenza incantata, il nostro vagabondo attraversa la caduta e il dolore fino alle soglie di una redenzione. Il titolo Getting to Know You, cioè "arrivando a conoscerti", allude al percorso che sia i due protagonisti fra di loro sia lo spettatore nei confronti di tutti i personaggi debbono fare lungo il film. Questo percorso è pieno di diversioni, divagazioni, distrazioni; vi si alternano liberamente presente e passato, realtà e fantasia; ci si culla al ritmo suadente del cantastorie. E non importa se si tratta di frammenti di storie, non importa se le storie sono vere o false. Il puro piacere del racconto prende i personaggi come prende noi spettatori. Familiarizziamo col banale quotidiano, ci appassioniamo, ci sorprendiamo. Per conoscersi basta abbandonarsi, dunque darsi.
julien: donkey-boy si conferma il talento fuori norma di Harmony Korine, di cui si era visto a Venezia due anni fa il sorprendente Gummo. Il film porta il "marchio di riconoscimento" del movimento danese Dogma 95, e si vede bene il legame formale e contenutistico con un'opera altrettanto fuori norma come Idioti di Lars von Trier. Ecco un cinema autenticamente dissidente, che non scende a patti con alcuna convenzione linguistica o tantomeno spettacolare, che fa terra bruciata mescolando selvaggiamente le tecniche (come tutte le regole, anche quelle di Dogma 95 sono formulate per essere contraddette). Korine fa esplodere il proprio materiale guidato da una sofferta sincerità che buca lo schermo. Il suo è un cinema estremo che vuole provocare lo spettatore fino ai limiti della sopportabilità e che non ammette compromessi. La Francia era anche troppo ampiamente rappresentata nelle varie sezioni della Mostra da film che davano spesso l'impressione di somigliarsi: storie di personaggi più che di ambienti, attori sempre impeccabili, micronarrazioni che non si lasciano spaventare dai vuoti ma che insieme rivelano una costruzione sapiente. Esemplare in questo senso Une liaison pornographique, opera seconda belgo-francese di Frédéric Fontayne (in concorso). Un uomo e una donna si incontrano tramite gli annunci economici per condividere un'esperienza sessuale particolare. Nulla sapremo di questa particolarità, né tantomeno vedremo i loro rapporti intimi. Solo incontri al tavolino di un bar, dialoghi sinceri protetti dall'anonimato e scevri da equivoci amorosi, ma che portrebbero preludere a un amore che in realtà non si realizza. La costruzione geometrica rivela a volte il meccanismo ma più spesso è riscaldata dagli attori, a tu per tu fra di loro e con lo spettatore.
Le vent de la nuit di Philippe Garrel (in concorso) è un film di svolta per questo grande cineasta irrequieto e intransigente. Grazie anche allo scope-colore e alla presenza (anti)divistica di Catherine Deneuve, Garrel raffredda il suo consueto materiale autobiografico, ne distanzia il calore altrove dominante, lo sottomette a una forma depurata e cristallizzata. Ammiro questo rigore ma nello stesso tempo rimpiango i film dove il cuore era più allo scoperto. Una eccezione al "modello" francese è La voleuse de Saint Lubin di Claire Devers, un esempio di realismo sociale, di impegno politico-ideologico, così colpevolmente fuori moda nel cinema odierno. L'odissea della protagonista, che non ha paura di muoversi contro tutti per affermare le proprie ragioni, così come la regista non ha paura di essere "scorretta" nel dichiarare le proprie tesi, mi ha fatto pensare a Europa '51 di Rossellini. Leggendo trasversalmente le varie proposte della Mostra, mi è chiaro che il vero cinema nuovo viene dai margini e dalle periferie, aldilà delle ripartizioni geografiche: dal "terzo mondo". Come per il cinema italiano, anche a livello internazionale la creatività più autentica si manifesta fuori dalle regole e le costrizioni del cinema come sistema e come industria. I conti veri il cinema di domani dovrà farli, per quanto riguarda la fiction, con opere come - fra quelle in concorso - Le vent nous emportera (Il vento ci porterà via), coproduzione franco-iraniana di Abbas Kiarostami, che avrebbe meritato il Leone d'oro e che è stata invece un po' umiliata col Gran premio della giuria; Guo nian hui jia (17 anni) del cinese Zhang Yuan, Premio speciale per la regia; Gojitmal (Bugie) del sudcoreano Jang Sun-woo; e fra quelle di altre sezioni, il già citato julien: donkey-boy; Abenland (Crepuscolo) del tedesco Fred Kelemen; Sao Jerônimo del brasiliano Julio Bressane; Luna papa del tagiko Bakhtar Khudojnazarov; Civilisées! della libanese Randa Chahal Sabbag; Mondo grúa dell'argentino Pablo Trapero (che ha vinto il premio riservato ai film della Settimana della critica), Oinaru genei (Vana illusione) del giapponese Kiyoshi Kurosawa (niente a che vedere con Akira, di cui è stata presentata la corretta e efficace "traduzione" dell'ultima sceneggiatura - un "racconto morale" - con Ame agaru, Dopo la pioggia, diretto dall'ex aiutoregista di Akira Kurosawa Takashi Koizumi).
Il vento ci porterà via di Abbas Kiarostami può sembrare ripetitivo rispetto ai suoi precedenti capolavori. Il regista iraniano ha conquistato un tocco, semplice ed essenziale, che rende poetica qualsiasi cosa riprenda. In questo film fa a meno delle metafore cinematografiche di Close-up, Sotto gli ulivi e del finale del Sapore della ciliegia, e anche dell'"evento" - il terremoto - alla base del viaggio di E la vita continua. Tutto qui è ancora più semplice ed essenziale, più puro e nudo, se possibile, e un ruolo fondamentale lo acquista il "non detto" e il "non visto"; in termini tecnici: il "fuori campo". Ciò che il protagonista - guida consueta dello spettatore - vorrebbe vedere e sapere del piccolo villaggio in cui staziona per lavoro resta, per lui e per noi, un mistero. In tale mistero si cela la verità del film.
17 anni di Zhang Yuan conferma il valore del cinema cinese indipendente, di cui Zhang è il capofila, un cinema realizzato ai margini o addirittura contro le direttive ufficiali (anche per questo il film è stato presentato sotto bandiera italiana). Con stile densamente realistico, attento ai dettagli ridotti all'essenziale, il film racconta di una ragazza accusata di aver ucciso la sorellastra per un banale incidente familiare, di cui lei è ritenuta colpevole dai genitori mentre sappiamo che è la sorellastra a esserlo. La ragazza torna con un permesso a rivedere per la prima volta i genitori dopo 17 anni di carcere. Aldilà della colpa e dell'innocenza, conta ormai la capacità reciproca di comprensione. Il dramma, centrato su personaggi i cui minimi gesti riflettono scelte etiche, riesce anche a tratteggiare magistralmente un ritratto della Pechino povera di oggi. Un film esemplare.
Bugie di Jang Sun-woo registra, senza ombre moralistiche o sentimentali, "aldilà del bene e del male", il rapporto sadomasochista fra una studentessa e uno scultore quarantenne. A Venezia colpivano le analogie da una parte con Guardami, per la franchezza con cui sono visti il corpo e il sesso, dall'altra con Une liaison pornographique, di cui questo film è in un certo senso l'inverso (lì non si vede nulla e conta il rapporto psicologico, qui si vede tutto e le psicologie sono cancellate). Come un film porno, il film si concentra quasi esclusivamente sui rapporti sessuali della coppia, con scarso spazio per ciò che li circonda. Ma al contrario di un film porno, lo sguardo non è mai voyeuristico, e dopo un po' la bizzarria delle situazioni cede il posto al puro e semplice catalogo, come in Sade. Il giudizio implicito non è tanto sui personaggi quanto sullo spettatore e, indirettamente, sulla società. Un film anarchico e impassibile, senza concessioni.
Abendland di Fred Kelemen è un grande film dostoevskiano. Girato con metodiche ed estenunati inquadrature lunghe, ambientato in una città di oggi che sembra sopravvissuta a una catastrofe, il film dipinge un universo desolato abbandonato dalla speranza, in cui ci si trascina senza meta, per forza d'inerzia. Solo il rigore della regia conferisce allo sguardo una forza che supera la disperazione. Nella tradizione visionaria di Glauber Rocha, Sao Jerônimo di Julio Bressane mette in scena alcuni episodi della vita del santo con uno stile che mescola disinvoltamente il poetico e il didascalico, il barocco e l'astratto. Fra la contemplazione nel deserto e il paziente lavoro di traduzione in latino della Bibbia, San Girolamo visto da Bressane si rivela un nostro contemporaneo, un saggio pazzo che vive sulla propria pelle le contraddizioni del suo tempo.
Luna papa di Bakhtar Khudojnazarov ha un inizio travolgente, carnevalesco, pieno di colori accesi, di narrazioni sovrapposte, di invenzioni a ogni inquadratura. Procedendo il film perde un po' della sua carica iniziale perché si concentra su alcuni elementi del racconto piuttosto che continuare a orchestrarli tutti insieme. Ma resta la straordinaria inventiva di questo regista, che sa trasmettere allo spettatore gioia e vitalità.
Civilisées! di Randa Chahal Sabbag rievoca la guerra civile a Beirut negli anni '70 con coraggiosi e inusuali toni farseschi e grotteschi, che rendono ancora più tragici e inquietanti i fatti narrati. Il racconto si frantuma in una miriade di personaggi che, come le tessere di un mosaico, ricompongono alla fine il ritratto vivace di una collettività in stato di precarietà permanente.
Mondo grúa di Pablo Trapero è un film fatto in economia e girato con uno stile neorealistico constatativo. Niente giudizi nello scandire il precario percorso di lavoro di un operaio non più giovane. Le scene si succedono come se fosse impossibile cambiare il corso degli eventi e inutile opporvisi. Solo alla fine lo spettatore, a forza di essere costretto a confrontarsi con una pura descrizione di fatti, si ribella e giudica. Mondo grúa è un film politico.
Vana illusione di Kiyoshi Kurosawa fa pensare al cinema di Ozu per il modo in cui la vicenda amorosa di due giovani è sottratta agli eventi narrativi e sottomessa a uno sguardo che la distanzia e la analizza, aldilà di una tensione sentimentale o drammatica. L'amore, appunto, come "vana illusione". Sul fronte della nonfiction, due omaggi al cinema italiano: Martin Scorsese si muove fra saggistica e autobiografia con Il dolce cinema, di cui è stata presentata una versione in progress e in video, circa la metà del progetto. Colpisce il pathos della rievocazione, che disinteressandosi di ogni correttezza storicistica sa cogliere con essenzialità e a volte con finezza la specificità del nostro cinema; l'olandese Peter Delpeut, specialista di "rimontaggi" di film muti, ritaglia sapientemente in Diva dolorosa brani di opere con Lyda Borelli, Francesca Bertini, Pina Menichelli e altre signore degli anni '10, facendo risaltare una poetica baudelairiana (la passione come patimento) che rende quel cinema più affascinante di quanto lo sarebbe a vedere i film per intero. Un altro esempio di "cinema di compilazione" è Godard à la télé di Michel Royer, esilarante e sfrenato montaggio video delle apparizioni di Godard in (e regolarmente contro la) televisione, dove si rivela critico implacabile del mezzo e insieme icona mediatica di prim'ordine. Sul fronte della nonfiction saggistica ricordiamo Se a memória existe di João Botelho, un lucido ed essenziale cortometraggio didattico in video sulla rivoluzione del 1974 che ha riportato la democrazia in Portogallo, e Tsion, auto-emancipatcie di Amos Gitai, riflessione attraverso documenti d'epoca e testimonianze odierne sulle radici e sul significato del sionismo in Israele. L'esempio più originale di una nonfiction svincolata dalla tradizione documentaristica e aperta al mescolamento dei generi mi è parso Wisconsin Death Trip dell'inglese James Marsh, che a partire da fotografie e cronache giornalistiche d'epoca mette in scena ipotesi di ricostruzione realistico-poetica delle vicende paradossali, tra crimini e follie, di una piccola comunità del Wisconsin alla fine dell'800.
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui Archivio Cinema
|



| Home | Rassegna italiana | Rassegna estera | Editoriale | Attualita' | Dossier | Reset Online | Libri | Cinema | Costume | Posta del cuore | Immagini | Nuovi media | Archivi | A domicilio | Scriveteci | Chi siamo |
