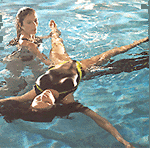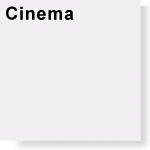
| Considerazioni veneziane/Il cinema italiano
è vivo Adriano Aprà
"Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica": così si intitola la manifestazione veneziana, giunta alla 56a edizione e ora diretta, con nomina quadriennale, da Alberto Barbera, ex direttore del Torino Film Festival, una delle roccaforti del giovane cinema internazionale. "Mostra" (in anni lontani addirittura "esposizione"), per distinguersi dai "festival" e avvicinarsi alle altre rassegne della Biennale di Venezia, per marcare cioè la differenza dalle kermesse mondano-pubblicitarie; "d'arte", per ribadire la differenza dalle pratiche altrove dominanti del cinema-industria. Ma queste etichette fanno parte delle buone intenzioni, sia perché da tempo la controparte - industria, televisione, stampa, pubblico - guarda e giudica la Mostra alla ricerca prioritaria di scoop, presenze divistiche, anteprime di film di imminente uscita e di presumibile successo, riducendola così a festival; sia perché il direttore, forse per un (comprensibile) eccesso di prudenza al suo debutto, ha selezionato i film equilibrando troppo i salutari azzardi con i consueti prodotti medi, quando non mediocri, e così facendo ha sacrificato l'arte; sicché la sua mostra non si differenzia poi tanto dalle precedenti. Venezia non è ancora il luogo del cinema che verrà, anticipazione e promozione di tendenze, tensioni, paure e desideri che travagliano questo mezzo d'espressione dagli anni '90, da quando cioè si deve confrontare con un rivolgimento tecnologico e distributivo e con una ibridazione dei generi e dei formati che ne minacciano o, secondo il mio punto di vista, ne stimolano e ne alimentano la sopravvivenza; da quando il cinema non è più solo cinema ma parte di un complesso processo multimediale, che non si esaurisce certo negli effetti speciali e di cui la tradizionale sala non è che uno dei terminali di visione.
Venezia è invece una vetrina, più o meno oggettiva, dell'esistente, radiografato con uno sguardo che, per troppa considerazione di una controparte arroccata sulla difensiva, rivela nostalgia del passato e timore del futuro, mettendo come di regola in prima linea (il concorso, i programmi delle sale più capienti) il classico lungometraggio (e un po' anche il cortometraggio) di finzione, e relegando nella sala piccola (la sala Volpi) e in qualche convegno collaterale i timidi sguardi a certe periferie sintomatiche di un altrove del cinema. Se per quanto riguarda il cinema internazionale ci si trova di fronte a un panorama inevitabilmente parziale ma comunque rappresentativo; per quanto riguarda quello italiano si può ricavare da Venezia un bilancio abbastanza esaustivo almeno per i lungometraggi di finzione, specie se li si somma a quelli della passata stagione.
I film italiani Non sono fra quelli (praticamente tutti) che hanno gridato al disastro nei confronti del nostro cinema. Questione di gusti, come sempre. Mi sono piaciuti tra i lungometraggi di finzione Appassionate di Tonino De Bernardi, Guardami di Davide Ferrario, Questo è il giardino di Giovanni Davide Maderna, Libero Burro di Sergio Castellitto; tra le nonfiction Enzo, domani a Palermo! di Daniele Ciprì e Franco Maresco, Conversazione italiana di Fiorella Infascelli (e Alberto Arbasino), Il denaro di Ermanno Olmi (e la sua scuola Ipotesi Cinema). Non è poco. Certo, il valore di queste opere era inquinato dalla presenza di Autunno di Nina di Majo, Come te nessuno mai di Gabriele Muccino, Non con un bang di Mariano Lamberti, The Protagonists di Luca Guadagnino, Tìpota, corto-medio di Fabrizio Bentivoglio (tutte opere prime), A domani di Gianni Zanasi (opera seconda), Un uomo perbene di Maurizio Zaccaro. Non riuscito ma apprezzabile per i rischi che sa correre, quindi non confondibile con i film precedenti, mi è infine sembrato Il dolce rumore della vita di Giuseppe Bertolucci.
Se leggesse la rassegna stampa, il lettore ne ricaverebbe l'impressione opposta. I migliori film (all'interno comunque di un discorso di delusione complessiva) sono apparsi ai più Autunno, Come te nessuno mai e Il dolce rumore della vita; per A domani c'è stata molta più indulgenza che per Appassionate (erano i due film in concorso); Guardami, come peraltro Un uomo perbene, sono stati ampiamente discussi ma per motivi esterni, la pornografia nel primo caso, la politica nel secondo; Questo è il giardino e Libero Burro, aldilà del loro essere produttivamente ed esteticamente agli antipodi, sono stati distrattamente considerati, e deve aver spiazzato il premio (ufficiale) opera prima vinto da Maderna. Come è possibile, ci si chiederà, una simile divergenza di giudizi? Perché, io credo, la maggioranza della critica italiana si sente investita, nell'occasione veneziana più che nella pratica quotidiana, dal dovere di indicare un modello per rigenerare l'agonia del nostro cinema, identificato in un mix di spettacolarità, comprensibilità, coerenza narrativa, recitazione corretta e, perché no, autorialità però non troppo esibita. La critica esige cioè un cinema normalizzato e perbenista, per nostalgia di come si faceva cinema da noi una volta (la commedia o il dramma, non Rossellini, Pasolini o Ferreri) o di come si è sempre continuato a fare a Hollywood: film da pubblico ma non volgari, soprattutto film non troppo intellettuali, non troppo marcati dallo stile dell'autore, non troppo emotivamente eccessivi, non "troppo" comunque. A Venezia, però, questi diktat della critica hanno potuto rispecchiarsi in esempi minori: non c'erano i Benigni, i Tornatore, i Salvatores, e neppure i Luchetti, i Risi (Marco), i Tognazzi (Ricky), i Virzì (a lui più che a Moretti, come pure si è detto, tende Autunno). Il film di Bertolucci, che non è certo perbenista, è stato invece apprezzato secondo me solo per contrasto; fosse apparso fuori da un contesto festivaliero, come il precedente e assai superiore Troppo sole, sarebbe stato ignorato o stroncato. E' più curioso che siano stati sottovalutati Ferrario e Castellitto i quali, come Moretti, come Martone, come a volte Alessandro Benvenuti (naturalmente tutti in maniera e con stili assai diversi), sembrerebbero rispondere a quelle esigenze di conformità della critica. Essi cercano di pensare e lavorare "nel sistema" coniugando comunicazione e soggettività; senza nascondere la difficoltà dell'impresa, anzi - è il caso soprattutto di Ferrario - ponendola al centro della propria ricerca; attirano lo spettatore (riflettendo sui generi, servendosi di attori di richiamo, "parlando chiaro") per poi rivolgersi a lui non come a un anonimo membro del pubblico o peggio dell'audience ma come a un individuo capace di pensare e di sentire per dirgli col cinema, fraternamente, qualcosa di sé e del mondo.
Intendiamoci, non è che Ferrario e Castellitto si servano della pornografia o del crime movie come specchietto per le allodole. Questi sono, nei loro film, universi mentali e insieme realtà quotidiane, fanno parte della nostra fantasia come delle nostre esperienze sociali. Lo sguardo particolare - il punto di vista soggettivo - con cui pornografia e criminalità urbana sono mostrate investe realtà forti che coinvolgono lo spettatore oggettivamente, anche al di fuori del cinema; donde il rischio che entrambi hanno il coraggio di correre. Ad altri autori, più "sperimentali", si potrebbe forse rimproverare di porsi troppo aprioristicamente ai margini, di sussurrare cose che meritano di essere dichiarate con energia; non a Ferrario o a Castellitto.
Guardami è a mia memoria il primo film, non solo italiano, a iscrivere non isolatamente ma strutturalmente scene hard senza cadere nel porno di genere. In questo senso segna anche una data nella lenta evoluzione del cinema, arte che ha sempre avuto il corpo umano al proprio centro, almeno nella fiction, verso il disvelamento di tale corpo; è il punto di arrivo di una appropriazione espressiva che ha i suoi antecedenti recenti in opere come L'impero dei sensi di Nagisa Oshima e Romance di Catherine Breillat, nonché fra gli italiani, più per il tipo di sguardo che per il vero e proprio hard, Il corpo dell'anima di Piscicelli. Se ciò dovrebbe assicurare al film un fuorviante succès de scandale, consente anche allo spettatore di "guardare" confrontandosi produttivamente con le proprie ipocrisie, i propri sensi di colpa, il proprio inconscio. Lo sguardo di Ferrario è, se non freddo, distanziato, o meglio alla giusta distanza, né voyeuristico né clinico, e tantomeno moralistico; ma morale sì. L'innesto di elementi di un altro genere canonico, il melodramma, rivela, col contrasto che ne deriva, la tensione che attraversa il film, alla quale lo spettatore può reagire o con un riso di rimozione (è capitato ai più) o con una emozionante adesione.
Libero Burro scompone le convenzioni del film di genere a forza di invenzione, spiazzando le attese del pubblico, lavorando, anche nella scelta degli attori, sulle dissonanze, sulla sorpresa, sulla parodia; e ricompone un universo variegato che supera il latente bozzettismo promuovendolo a catalogo, un po' folle, di caratteri. Anche Bertolucci lavora sui generi, in questo caso esaltando il sostrato psicoanalitico che alimenta le convenzioni del melodramma famigliare. Lo stile è acceso, come è spesso ma non sempre sua consuetudine. Se dico che il film non è riuscito è perché psicoanalisi e melodramma, visualizzazione espressionistica dell'inconscio e accettazione passiva di dialoghi e situazioni banali, restano su piani separati, come due strade che non convergono. E' vero che il melodramma autentico sa trasfigurare il cliché in archetipo, ma qui il mistero e l'ambiguità che emergono fruttuosamente a momenti (la scena con la vera madre, Rosalinda Celentano) vengono il più delle volte - per eccessiva volontà di chiarezza? - annullati o congelati da spiegazioni ridondanti. L'enigma è risolto e la poesia si dissolve. Resta un film travagliato, dissociato, sdoppiato (e ossessionato anche stilisticamente dal motivo del doppio e dello specchio), e però lontano dal "dolce" rumore della vita.
Questo è il giardino è un tipico film "sussurrato", altri diranno minimalista. Lo è anche tecnicamente: girato in video digitale e poi gonfiato in un 35mm slavato; povero, quindi. Ma, appunto, la povertà è diventata per molti autori esigenti non solo una costrizione economica ma anche una necessità etica, di fronte ai miti del professionismo e del denaro. Forse bressoniano nelle intenzioni ma olmiano (il primo Olmi) nei risultati, il film è tematicamente solo in apparenza "piccolo". "Nella Bibbia ci sono quattro giardini, tutti riferiti all'amore fra uomo e donna, ma con sfumature molto diverse: l'innocenza, la passione, la separazione e il ricongiungimento… Sono le tappe essenziali della storia narrata in questo film", dichiara Maderna. Il film, dice ancora, è "la rappresentazione di un mondo interiore". Lo è a mio avviso nel senso che la rigorosa "registrazione" di una realtà anche visivamente smorta, di personaggi senza sostanza in un contesto senza ideali, è illuminata da una ostinata tensione dello sguardo, da un senso della durata mai condizionato dai dettagli del racconto, come se un'anima governasse quei pallidi corpi incoscienti, suggerendo l'imminenza di una grazia che non riesce però ancora a manifestarsi. Si percepisce un'aspirazione religiosa in questo film, che lo apparenta ad altri film attratti da temi spirituali, come Piccoli orrori di De Bernardi, Voci nel tempo di Piavoli, Pianese Nunzio 14 anni a maggio di Capuano, La ballata dei lavavetri di Del Monte, Fuori dal mondo di Piccioni, per non parlare della sacralità pasoliniana di Ciprì & Maresco: una tendenza sommersa del nostro cinema recente.
Appassionate è il primo film di Tonino De Bernardi prodotto in condizioni normali; non per questo il suo sperimentalismo risulta "normalizzato". Si può solo dire che la fiducia della produttrice Donatella Palermo, che si accompagna a quella mai smentita dei collaboratori-amici, ha consentito a De Bernardi, sollecitandolo a un confronto anche economico con l'"esterno", di superare le impasse che a volte minacciano altri suoi film recenti. Posso sforzarmi di capire lo sconcerto che il suo modo originale di fare cinema ha prodotto nella maggior parte dei critici, costretti dall'inserzione del film in concorso a confrontarsi con un autore a loro pressoché ignoto, dato che non dico i suoi 8 e Super8mm degli anni '60, '70 e primi '80, ma nemmeno il 16mm televisivo Elettra (1987), il video lungo Viaggio a Sodoma (1988), il 35mm Piccoli orrori (1994) - le opere che più amo - hanno mai sollecitato in quei critici un minimo di curiosità, che invece pochi italiani e alcuni festival stranieri hanno nel tempo saputo dimostrare. Ciò non giustifica la prevenzione della stampa, manifestata ancor prima che la mostra cominciasse, e puntualmente confermata dalle recensioni, con vertici non tanto di ottusità quanto di volgarità, che purtroppo non mi sorprendono più. Barbera ha fatto una scelta coraggiosa (come del resto i suoi predecessori: Laudadio con Gaudino, Biraghi con Agosti o Chiarini con Bene); i quotidianisti che hanno stroncato il film hanno confermato di non ammettere intrusi nel loro seminato, quello di un surrogato pubblicitario dell'industria del cinema. Appassionate parte dal cliché per raggiungere l'archetipo, coglie nel quotidiano della strada le tracce del mito, attinge alla cultura popolare per riscoprirvi le fonti di una cultura alta, che va dalla tragedia greca al barocco meridionale. Quanto al cinema, il film rimanda anche senza volerlo a Rossellini, a Pasolini, a Ferreri, a Bene, a Huillet-Straub, trova fratelli in Gaudino, Corsicato e Ciprì & Maresco, e risponde da opposto versante al Resnais di Parole, parole, parole. Si percepisce il travaglio creativo tipico degli sperimentalisti, ma ciò che sorprende e entusiasma è la gioia, la vitalità, l'intensità emotiva che emerge da tale travaglio. Appassionate è un film che viene dopo l'avanguardia. La frantumazione delle storie non è frantumazione dello sguardo; essa compone un polittico armonico, "musicale" anche aldilà della musica, pure abbondante. Passando dai "piccoli orrori" alle grandi passioni del repertorio napoletano, De Bernardi fornisce anche una risposta in positivo a un cinema di incessanti domande, indica una via a quel cinema italiano minorizzato e marginalizzato di cui fa parte, dove l'esigenza morale di uno stile contro il rumore omologante del cinema medio si accompagna spesso allo svelamento (inevitabile?) di una "malattia" dello stile: disagio di un'arte sotto assedio, che reagisce investendo troppe energie per difendersi e resistere e troppo poche per contrastare e proporre. Rossellini criticava un cinema del "lamento" e un cinema dove il "come dire" prendeva il sopravvento sul "cosa dire". Forse Appassionate (ma anche Guardami) è il segnale di un possibile superamento della "faticosa esperienza della scrittura", di un'apertura a un cinema di risposte. Sul fronte della nonfiction - genere da noi eminentemente minorizzato - sono positivi gli esiti sia di una produzione indipendente come Enzo, domani a Palermo di Ciprì & Maresco, sia di una produzione RAI come Conversazione italiana di Fiorella Infascelli. Il primo è un esilarante video su Enzo Umberto Castagna, popolare capocomparse e organizzatore cinematografico palermitano, ripreso sia prima che durante la sua condanna agli arresti domiciliari per questioni di mafia. Non vi si ritrovano gli inconfondibili stilemi dei due autori, sostituiti da un'agile e tonificante parodia del film-inchiesta, che diventa autoparodia quando Maresco dal fuori campo intervista Castagna, "con la sua parlata alla Totò (…) uno sceneggiatore nato, il più originale e divertente dei cinefili, uno che racconta fatti e persone come pochi: insomma (…) per noi, uno Zavattini siciliano!" Il video della Infascelli fa parte della serie "Risvegli" che, come la precedente "Alfabeto italiano" (presentata a Venezia l'anno scorso e alla quale aveva contribuito col bel Italiani), propone a registi di cinema di assemblare a tema il materiale di repertorio della RAI. Della stessa serie si è potuto vedere anche Il denaro di Olmi & Co., ma in una copia lavoro della sola seconda parte, che comunque fa ben sperare. E' il genere che gli anglofoni chiamano compilation film, ovvero "film di montaggio", e che da noi abbonda in tv, di solito mortificato da una voce fuori campo radiofonica che annulla il valore delle immagini e dei suoni originali. La Infascelli (che credo prenda a modello lo splendido In cerca della poesia di Giuseppe Bertolucci, della serie "Alfabeto italiano") ci riporta con sensibilità all'epoca, gli anni '50 e '60, quando la comunità degli scrittori - si va da Calvino a Moravia, dalla Morante a Gadda, da Saba a Pasolini, da Ungaretti a Montale - era davvero una comunità di fratelli, che conversava, anche se ripresa dalla tv, come si fa tra amici, senza essere ossessionata dall'esibizione mediatica. Le aggiunte su romanzieri e poeti di oggi, girate ex novo a colori, cercano di ritrovare quel modo semplice e diretto di porgere la parola, di passeggiare, a cui purtroppo non siamo più abituati. Per concludere questo bilancio sul cinema italiano, si esce da Venezia ottimisti per gli autori e le opere, pessimisti per la critica e i media che dovrebbero sostenerli. Il problema è che la creatività si manifesta spesso nel "piccolo" cinema, emarginato a priori dall'ideologia pubblicitaria e filoindustriale della critica; e quando la creatività incontra lo spettatore, ecco la critica pronta a invocare i diritti del pubblico medio, a denunciare gli "eccessi", a esigere il ritorno all'ordine. Il cinema italiano è vivo. Lo confermano diversi film della passata stagione: Giro di lune tra terra e mare di Gaudino (fatto uscire un anno dopo il suo esordio a Venezia '97 amputato dal distributore di quasi mezz'ora), Così ridevano di Amelio, Del perduto amore di Placido, L'odore della notte di Caligari, La ballata dei lavavetri di Del Monte, Il corpo dell'anima di Piscicelli, Fuori dal mondo di Piccioni (l'unico non mortificato dal box office); e anche, fra quelli non ancora usciti nelle sale, la bizzarra commedia Rose e pistole di Carla Apuzzo, I lupi dentro, straordinario saggio documentario di tre ore sui pittori naïf della bassa padana, ma anche sul conflitto fra primitivo e moderno, del veterano cortometraggista Raffaele Andreassi, il compilation film creativo Su tutte le vette è pace di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, presentato alla Cinémathèque Française che ha reso omaggio alla loro opera, nonché uno dei capolavori degli "italianizzati" Danièle Huillet e Jean-Marie Straub, Sicilia (da Conversazione in Sicilia di Vittorini), che solo la nostra critica ignora (il film era a Cannes), e che a Venezia era indirettamente presente col "making of" in video La musica siete voi, amici! del tedesco Andreas Teuchert. In tutti questi film si percepisce produttivamente la ventata di novità delle nouvelle vague degli anni '60 e dei loro prolungamenti odierni. Ma la critica non vuole questo cinema, rema contro, vagheggia l'esperanto europeo-televisivo quando non i miti presenti dell'efficienza hollywoodiana o quelli passati della commedia all'italiana. In ogni caso: miseria.
Per il panorama del cinema internazionale a Venezia '99, appuntamento al prossimo numero di "Caffè Europa"!
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui Archivio Cinema
|



| Home | Rassegna italiana | Rassegna estera | Editoriale | Attualita' | Dossier | Reset Online | Libri | Cinema | Costume | Posta del cuore | Immagini | Nuovi media | Archivi | A domicilio | Scriveteci | Chi siamo |