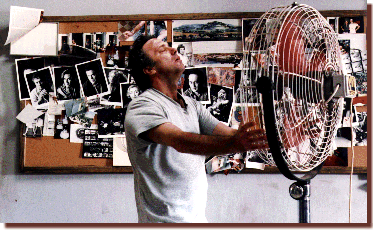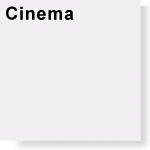
| Recensione/Giorno per giorno Paola Casella
Amos Gitai ha sicuramente molto da dire. Come potrebbe essere altrimenti, considerato che e' uno dei pochissimi registi israeliani conosciuti al di fuori di Gerusalemme e della comunita' ebraica internazionale? Peccato che in Giorno per giorno, girato nel 1998 e uscito solo ora nelle sale sull'onda del successo ottenuto da Kadosh (il film di Gitai candidato alla Palma d'oro all'ultimo Festival di Cannes) il regista si esprima in modo talmente confuso e sfocato da dare l'impressione di non saper bene cio' che intendeva comunicare. E' un peccato, perche' Giorno per giorno mostra gia', almeno visivamente, la mano di un regista in possesso di uno stile ben definito, perfettamente coincidente con la trama del film: ovvero deliziosamente sconnesso. Ogni immagine e' una vignetta a se con un suo charme intrinseco. Peccato, di nuovo, che un'intero lungometraggio fatto di vignette di charme, ma privo di sceneggiatura degna di questo nome, finisca per disorientare, lasciando per strada l'attenzione degli spettatori.
La storia -- se cosi' vogliamo chiamarla -- e' quella di Mosh (Moshe Ivgi), un quarantenne figlio di mamma' senza la benche' minima intenzione di crescere e di assumersi responsabilita' familiari o lavorative. Anche Mosh, come Giorno per giorno, ha un suo charme tipicamente mediorientale, fatto di fatalismo biblico e di languida indolenza. Ma Mosh non ha lo spessore filosofico di un Oblomov o la levita' metafisica di un Siddharta: e' solo uno che si lascia vivere, giorno per giorno appunto, cercando di non fare l'onda. Per certi versi Mosh e' una macchietta stereotipicamente ebraica, un Woody Allen ipocondriaco e maldestro con un viso malinconico alla Charles Aznavour. Il suo background potrebbe tuttavia renderlo più interessante: figlio di madre ebrea (la luminosa caratterista Hanna Meron) e padre arabo (Yussuf Abu-Warda, visto anche in Kadosh, l'incarnazione stessa della profondita' del migliore islamismo), e' incapace di prendere una posizione nella vita anche perche' e' cresciuto in un paese dove le posizioni tendono a essere conflittuali, e a degenerare nella sopraffazione dell'uomo sull'uomo. I momenti piu' alti del film riguardano infatti la natura radicalmente pacifica di Mosh (che ripete: "Ma perche' tanta violenza?) contrapposta a quella bellicosa dell'abitante medio di Haifa, la citta' in cui e' ambientata la vicenda, anche se nessuno la nomina mai, che e' anche la citta' natale di Gitai, e dove, secondo il film, una rapina in banca e' semplice routine, e la casualita' della violenza fa parte integrante della vita. Mosh e' tuttavia troppo "molle", troppo vittimista e troppo ridicolo (ahime' non alla Woody Allen, il cui umorismo, anche quando diretto su di se', non e' mai involontario) per risultare cinematograficamente interessante. E diventa impossibile, almeno per lo spettatore occidentale, capire come mai riesca a portarsi a letto tutte le donne che incontra, visto che e' totalmente privo di fascino erotico. Assai piu' stimolante, anche come personaggio, e' il miglior amico di Mosh, Jules (Juliano Mar), un altro archetipo ebraico, e cioe' quello del guerriero, un pezzo d'uomo che sembra uscito dal Vecchio Testamento, aggressivo, passionale, estremo in tutte le sue manifestazioni vitali. Cio' che rende Jules particolarmente interessante e' il fatto che, dietro la sua tracotanza, si nasconde una profonda solitudine e un'amara coscienza della situazione, sua e della sua patria: e' lui, piu' ancora di Mosh, a rammaricarsi del fatto di "vivere in un cazzo di paese"; e' lui, pur essendo di natura guerriera, a definire l'esercito isrealiano un'accozzaglia di "babbuini che giocano ai cowboy".
E' Jules, infine, che pur autodefinendosi "nato per vincere" finisce per innamorarsi di tutte le donne che porta a letto, senza mai ottenerne in cambio altro che sesso senza sentimento. Il sentimento e' inspiegabilmente riservato a Mosh, che non fa nulla per meritarselo, se non mostrarsi cronicamente passivo. "Senza di me e' perduto", dice di lui sua madre, e sia ha la sensazione che anche nelle altre donne Mosh ispiri una sorta di indulgenza materna. Intorno a Mosh e Jules ruota una galleria di personaggi vaghi e mal descritti: di alcuni di loro non capiremo ne' il nome ne' la professione, ne' men che meno il rapporto di associazione con gli altri. Le loro vicende parallele, raccontate simultaneamente, diventano sempre piu' impossibili da seguire, e una storia cosi' slegata e pasticciona e' una vera sfida alla pazienza degli spettatori. Si puo' pensare che molto sia andato perso nella traduzione, o che certo umorismo etnico non "passi" al di fuori di Israele: ma tutto il mondo e' da tempo abituato allo Jewish humour, e da sempre lo capisce e lo apprezza. La forza di Giorno per giorno sta nel farci entrare in un universo di confini labili, nel quale etnie e religioni diverse coesistono molto piu' armoniosamente di quanto ad occidente non sia dato di sospettare, componendo una specie di mosaico (o di patchwork) incongruente e contradditorio che funziona nella quotidianita' ma che ogni tanto genera scintille, sollevando rancori mai abbastanza sopiti, scatenando piccole risse improvvisate che sono la copia minima di un conflitto secolare. Per questo gli abitanti di Haifa si aggrappano ai rituali della tradizione -- il caffe' di Yussuf, ad esempio -- e ai rapporti umani "misteriosamente speciali", come quello fra Yussuf e sua moglie Hanna, che si instaurano fra gli individui anche -- o soprattutto -- in terreno di guerra (Yussuf e Hanna si sono conosciuti "alla frontiera libanese") per motivi inspiegabili ma proprio per questo dotati di una loro particolare sacralità. L'intento di Gitai, come quello di Mosh, e' dichiaratamente pacifista: ritrarre un mondo (o anche solo immaginarlo) in cui tutte le contraddizioni possano convivere, dove tutti trattino con tutti, tutti scopino con tutti, e tutti si perdonino le reciproche debolezze, secondo una filosofia di tolleranza, di carpe diem. E' interessante a questo proposito osservare come invece nel successivo Kadosh, ambientato all'interno della comunita' ebraica ortodossa, Gitai abbia puntato l'obbiettivo sulla capacita' di estrema intolleranza dello stesso popolo. Ma resta il fatto che, con questo omaggio alla provvisorieta' dei rapporti in un paese costantemente in bilico -- dove, come dice Yussuf, "prima o poi tutto sara' cancellato" -- Gitai ci fa venire il mal di mare, e ci ritroviamo a desiderare di scendere dall'ottovolante (come Mosh, che a un certo punto scende dalla sua auto e vomita a terra tutto il suo smarrimento esistenziale).
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui Archivio Cinema
|



| Home | Rassegna italiana | Rassegna estera | Editoriale | Attualita' | Dossier | Reset Online | Libri | Cinema | Costume | Posta del cuore | Immagini | Nuovi media | Archivi | A domicilio | Scriveteci | Chi siamo |