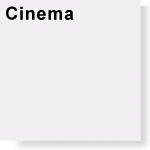|
Manca qualcosa nel
Vietnam di Gibson
Antonio Carioti
Una ferita profonda, dolorosa, quasi impossibile da rimarginare. La
guerra del Vietnam è stata l’unica vera sconfitta nella storia
americana del secolo scorso. E anche Hollywood ne ha portato il segno.
Se si eccettua il brutto film bellicista di John Wayne Berretti
verdi, che fu comunque un atto di coraggio nel clima di rigetto
verso l’intervento militare regnante all’epoca nel paese, durante
il conflitto il cinema Usa preferì astenersi dal trattare
direttamente un tema così scottante e controverso.
Solo dopo la caduta di Saigon il Vietnam diventò un argomento
corrente per pellicole del più vario genere. Inizialmente, di solito,
la guerra incombeva sulle vicende narrate, come in Tornando a casa
e Un mercoledì da leoni, ma non ci veniva mostrata dal vivo. A
volte invece veniva usata come sfondo o come metafora (tipici esempi Il
cacciatore e soprattutto Apocalypse Now). In altri casi
offriva lo spunto a sfoghi di revanscismo manicheo, come Rambo 2,
Fratelli nella notte, la serie Missing in Action
con Chuck Norris. Ma non sono mancati roventi atti d’accusa contro
il militarismo e gli orrori del conflitto, tra i quali spiccano le
opere di Oliver Stone e, a suo modo, Full Metal Jacket di
Stanley Kubrick.

We Were Soldiers di Randall
Wallace non regge certo il confronto con capolavori di ben altri
maestri che si sono cimentati sul tema, ma merita lo stesso un minimo
d’attenzione, perché costituisce per certi versi un tentativo di
cicatrizzare la ferita, di riportare il Vietnam alla dimensione di una
guerra qualsiasi, della quale si può parlare senza particolari filtri
ideologici.
Le ragioni politiche del conflitto sono infatti completamente
cancellate: non c’è ovviamente alcun cenno critico verso l’imperialismo
a stelle e strisce, ma anche la retorica dello scontro di civiltà tra
totalitarismo comunista e mondo libero risulta assente. I protagonisti
sono soltanto soldati di mestiere, che non si chiedono mai perché
combattono in quanto si tratta puramente e semplicemente del loro
dovere.
In questo modo anche il nemico può essere rappresentato in modo
rispettoso e cavalleresco. I nordvietnamiti, per quanto spietati, non
appaiono molto diversi dai loro antagonisti, anzi il finale del film
ne riconosce l’indomabile volontà di resistere, che li avrebbe
alfine condotti alla vittoria. Addirittura a un certo punto il loro
comandante sembra rivolgersi a Dio, così come fa il suo
religiosissimo avversario Hal Moore, interpretato da Mel Gibson: un
gesto davvero poco plausibile per un comunista asiatico.

Sarebbe dunque sbagliato liquidare
We Were Soldiers come un prodotto propagandistico, buono magari
per preparare psicologicamente le prossime iniziative del Pentagono. E’
semmai il frutto della scelta di raccontare la guerra esclusivamente
dal lato di chi la combatte, ma in modo tutto sommato equanime. Basta
pensare che i nordvietnamiti a un certo momento sono sul punto di
vincere e solo l’intervento dell’aviazione salva gli americani
dalla disfatta. Ma non si tratta del classico “Arrivano i nostri”
da western tradizionale, perché alcune bombe cadono sul bersaglio
sbagliato e assistiamo alla scena orripilante di un soldato Usa
carbonizzato dal fuoco “amico”.
Se Moore-Gibson è un eroe tutto d’un pezzo, coraggioso quanto umano
(e a volte un po’ trombone), i veri protagonisti negativi non sono i
“rossi” annidati nella giungla, ma semmai i politici di
Washington, che mandano i militari a morire e poi ne avvertono le
mogli con la freddezza burocratica di un telegramma recapitato da un
tassista. Ad uscirne esaltato oltremisura è invece lo spirito di
corpo dei combattenti e delle loro donne, anche attraverso il rapporto
del tutto particolare che instaurano con Dio persone il cui lavoro
consiste nell’uccidere e nell’essere uccisi.
Non è un caso che l’unico giornalista presentato in termini
favorevoli provenga da una famiglia di militari e scelga di vivere la
battaglia mentre intorno a lui fischiano i proiettili, al contrario
dei suoi colleghi che arrivano in massa solo a cose fatte, quando l’intuito
e l’energia del comandante americano hanno rovesciato le sorti della
lotta.
L’ottica unilaterale del film, una sorta di omaggio incondizionato
alla figura del combattente, ha d’altronde il grave torto di
espungere dal Vietnam un elemento essenziale. Manca infatti del tutto
il punto di vista dei civili locali, cioè coloro che più soffrirono
per quell’immane tragedia. I poveri contadini indocinesi in preda al
terrore, stretti nella morsa tra la durezza inflessibile dei comunisti
e la spaventosa potenza della macchina bellica Usa, Wallace non ce li
fa neppure vedere.

D’altronde il regista di We
Were Soldiers è in buona compagnia. Ora che gli Stati Uniti ne
sono fuori da lungo tempo, chi s’interessa più del Vietnam qual è
oggi, della povertà e del dispotismo che opprimono i suoi abitanti?
Anche le campagne in favore dei profughi, i cosiddetti boat people,
sono un ricordo lontano e la conciliazione tra Washington e Hanoi, che
il film in qualche modo adombra, sembra passare sopra le teste di un
popolo che sperimenta da 27 anni una pace in miseria e senza libertà.
Né naturalmente se ne preoccupa l’Europa, sempre pronta a cooperare
con dittature d’ogni colore.
Per fortuna sono rimasti i radicali di Marco Pannella a reclamare la
democrazia per il Vietnam, prendendo le difese delle minoranze etniche
e dei gruppi religiosi perseguitati. Le manifestazioni gandhiane
indette per sabato 21 settembre sono un modo lodevole dir riportare l’attenzione
su quanto Hollywood, troppo impegnata a celebrare i suoi valorosi,
preferisce dimenticare. (Per maggiori informazioni sull’iniziativa
radicale, www.radicalparty.org
).
Il link:
La
recensione di "Salon" (inglese)
L'ultima fatica di Mel Gibson non ne esce troppo bene, ma il critico
di "Salon" salva qualcosa, mettendolo a confronto con altri
"combat films" usciti recentemente
Vi
e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di
vista cliccando qui
Archivio Cinema
|