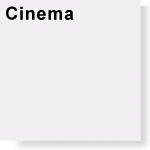|
Il festival del
cinema latino americano
Alessandro Rocco
Unico nel suo genere in Italia, anche quest’anno il Festival di
Trieste ha offerto agli appassionati la possibilità di apprezzare un
vasto campione della produzione cinematografica Latino Americana, il
cui livello qualitativo non è ormai più in discussione, sebbene
produttori e distributori italiani tardino ad accorgersene. Video
documentari e di finzione, cortometraggi e soprattutto lungometraggi
che meriterebbero, per il livello formale e per le tematiche
affrontate, di essere conosciuti da un più vasto pubblico, il quale,
a sua volta, meriterebbe senz’altro maggiori occasioni e
possibilità di scelta nella fruizione audiovisiva. Non ci si
stancherà di ripeterlo.
Oltre alla proposta di circa venti lungometraggi da quasi tutti i
paesi del continente, e un’ampia rassegna di cortometraggi
brasiliani, argentini e messicani, il XVI festival ha proposto una
vera e propria chicca cinematografica e musicale: un film di 35 minuti
che raccoglie dieci videoclip ante litteram degli anni ‘20,
in cui il grande Carlos Gardel, leggenda del Tango argentino, canta i
suoi più celebri successi, conservatisi e giunti fino a noi grazie
all’amore e alla cura di un collezionista italo-argentino.
Il cinema argentino è stato forse quello più rappresentato in quest’edizione,
e sicuramente il più premiato. Il premio al miglior film è andato
infatti alla pellicola del regista Javier Torre, Un amor de Borges
(Argentina, 2000), mentre Nueve Reinas di Fabián Belinsky
(Argentina, 2000) ha vinto il premio alla miglior sceneggiatura.
Basato sul libro biografico di Estela Canto, Borges a contraluz,
il “Miglior film” del festival racconta l’amore tra la
scrittrice e Jorge Luis Borges, negli anni del primo governo del
generale Perón, a cavallo tra gli anni ’40 e ’50. Con una
narrazione sobria ed elegante, ci presenta la parabola del rapporto
tra i due protagonisti, dal primo incontro all’abbandono finale,
facendo emergere poco a poco le problematiche e contraddizioni dell’uomo
Borges.

Il fascino della pellicola risiede
infatti proprio nella centralità del personaggio dello scrittore, sia
perché ne analizza le difficoltà interiori e relazionali, sia
perché in questo modo offre un’ampia rassegna del suo pensiero,
attraverso i dialoghi che riprendono ed espongono il suo modo di
sentire il mondo. I discorsi di Borges sulle traduzioni, sulla
famiglia, la concezione che aveva sulla sua opera, il processo
creativo di un celebre racconto, El Aleph, le sue riflessioni
sull’amore e sulla passione, sul dolore, il disinteresse per il
denaro, sono i temi che vengono toccati nei dialoghi, e la finzione
cinematografica, nella sua modalità di ricostruzione storica e
biografica, offre l’esperienza di vedere e ascoltare Borges nell’intimità
più profonda del suo sentire, nella vita quotidiana.
Da questo punto di vista è un appassionato omaggio allo scrittore
più universalmente celebre della letteratura argentina. Ma al
contempo, il film ne analizza debolezze e contraddizioni. Incapace di
vivere e sentire l’amore come esperienza fisica e sensuale, succube
della figura della madre come un eterno bambino, rinchiuso nel suo
mondo letterario e totalmente inadatto alla vita pratica, vittima di
una timidezza disarmante, l’uomo Borges pagava così il prezzo di
una sensibilità intellettuale e di una genialità che in definitiva
lo allontanava dal mondo.
Non a caso molte delle sue riflessioni vertevano proprio sul tema dell’incomunicabilità,
e non a caso, l’Aleph, quella “sfera di due o tre centimetri di
diametro in cui sono presenti tutti i luoghi del mondo”, era l’espressione
letteraria, la trasfigurazione fantastica del suo amore assoluto per
Estela, la donna che rinchiude in sé l’universo, e che per ciò
stesso, è anche praticamente e fisicamente inesperibile, se non nella
forma della pura contemplazione. Per questo Estela decide alla fine di
lasciarlo, perché come dice “una donna ha anche bisogno di sentire
amato il suo corpo”, ma non prima di avergli almeno dato la forza,
con la sua presenza, di affrontare l’arduo compito di parlare al
pubblico in una conferenza.
Il premio alla sceneggiatura per Nueve Reinas, ricorda il
percorso di produzione del film di Belinsky, nato proprio da un premio
alla miglior sceneggiatura in un concorso bandito dalla casa di
produzione Patagonik Film Group in Argentina, nel 1998.
La storia costruisce uno strabiliante intrigo giocato sul tema del
trucco e dell’inganno. Due incalliti truffatori si incontrano a
Buenos Aires, si fanno soci per un giorno, e avviano una girandola di
raggiri ed imbrogli sempre più sofisticati. Ad un certo punto si
presenta l’occasione della vita, la possibilità di vendere ad un
miliardario spagnolo una contraffazione di una serie di francobolli
rarissimi, le Nueve Reinas (Nove Regine) della Repubblica di Weimer.
Attraverso una serie di peripezie ai limiti dell’incredibile e
ostacoli superati con superba genialità l’affare va in porto, ma al
più giovane della coppia sorge il dubbio sull’irrealtà di tutto
quanto è accaduto…
Sembra d’obbligo il riferimento a La casa dei giochi di David
Mamet, e i richiami possono essere molti per un film che si basa anche
su regole di genere e su una tematica già quasi classica: Il
bidone, di Fellini, La stangata di George Roy Hill, oppure
il più recente Pacco doppiopacco e contropaccotto di Nanni Loy.
A proposito di quest’ultimo c’è una coincidenza suggestiva in Nueve
Reinas, nascosta nel reiterato riferimento alla canzone di Rita
Pavone Il ballo del mattone, che funge anche da sigla di
chiusura. “Il mattone” è infatti la popolare truffa napoletana,
descritta nel film di Loy, che consiste nel sostituire all’ultimo
momento la merce venduta al malcapitato cliente con un mattone,
appunto. Un ponte tra Napoli e Buenos Aires, una parentela tra
micro-mondi della truffa che il titolo della canzone evoca
segretamente.
Infine, a concludere con i riferimenti, per la perizia narrativa
mostrata dall’esordiente Belinsky, che si è fatto le ossa in più
di un decennio di lavoro nella pubblicità, la critica argentina lo ha
paragonato all’Aristarain degli anni ’70, maestro nell’arte del
racconto filmico. Nueve Reinas riprende il gioco di specchi del
teatro nel teatro, della messa in scena interna alla diegesi, con il
suo caratteristico e affascinante effetto di confusione tra realtà e
finzione, e lo fa in un modo talmente efficace (corroborato anche dall’ambientazione
in un albergo extra-lusso della seconda parte del film), che il dubbio
di irrealtà suggerito da uno dei personaggi trasporta lo spettatore
in una dimensione quasi metafisica, che ci ricorda la profondità del
gioco nel gioco (di virtuale nel virtuale) di un film per altro così
diverso come eXistenz di David Cronemberg.

Parallelamente, lo sguardo sulla
Buenos Aires contemporanea mantiene un tono realistico che fa
emergere, pur nell’artificiosità ed eccezionalità della storia, la
vita quotidiana del sotto mondo di truffatori e picari moderni che la
popolano. Sono figure di un certo fascino per lo spettatore, perché
la loro attività si basa sull’ingegno e non sulla violenza, il
repertorio dei trucchi costituisce una vera e propria tradizione, e
inoltre perché hanno anche un codice etico (infatti il truffatore
truffato è anche quello che trasgredisce ogni regola morale).
Tuttavia, la loro massiccia presenza nella realtà urbana può anche
fungere da indicatore del livello di crisi economica in cui versa
attualmente il paese.
Per il premio speciale della giuria ci spostiamo in Uruguay, con En
la puta vida, della giovane regista Beatriz Flores Silva. Il film,
basato su fatti realmente accaduti, tratta il problema della
prostituzione in Uruguay e soprattutto la condizione delle prostitute
portate in Europa e tenute in ostaggio dalle organizzazioni criminali.
Il tono iniziale del film è piuttosto quello di una commedia, e il
personaggio principale, Elisa, esercita la prostituzione senza alcun
tipo di costrizione o problematica morale, come dice “yo no soy puta,
trabajo de puta” (“non sono una puttana, lavoro come puttana”).
Il suo sogno è quello di mettere insieme il capitale sufficiente ad
aprire un negozio di parrucchiera insieme all’amica Lulú, e la
prostituzione sembra il modo più rapido ed efficace. Ma nell’esercizio
del suo lavoro Elisa conosce “El cara”, un uomo ricco e
affascinante che le parla dell’Europa, dove le ragazze possono
guadagnare fino a tremila dollari al giorno.
Elisa non sa resistere, ed innamorata dell’uomo, gli chiede di
portarla a Barcellona. Ma qui, dall’altro lato dell’oceano, scopre
che la realtà è diversa dalle sue fantasie. Le cose si complicano
anche per “El cara” che, in seguito ad una rissa in cui uccide un
travestito brasiliano, è arrestato dalla polizia. Alla sua uscita di
galera, grazie ad un accordo di Elisa con la polizia cui offre
informazioni sul giro dei brasiliani (rivali di “El cara”), l’uomo
decide di far capire alla ragazza come stanno veramente le cose. Per
toglierle dalla testa l’assurda idea di sposarsi con lui, “El cara”
picchia brutalmente la donna, in una scena che segna un radicale
capovolgimento del tono narrativo, facendole anche capire che non le
spetta un soldo di quelli da lei guadagnati e rifiutandosi di
restituirle il passaporto. Elisa comprende di colpo la sua reale
condizione di schiava.
Più avanti scoprirà anche che i figli, lasciati a pensione da una
signora in Uruguay, sono finiti all’orfanotrofio, dato che l’uomo
non ha mai spedito i soldi della retta. Per questo, e per la
precedente morte dell’amica Lulú, Elisa decide di collaborare con
la polizia e di incastrare “El cara” e tutti i soci dell’organizzazione,
in un processo che li condanna a diversi anni di galera.
I fatti raccontati, seppure con numerose licenze, sono realmente
accaduti tra Montevideo e Milano nel 1992, e sono esposti nel libro
del giornalista Mario Urruzola El huevo y la serpiente. Se nel
film sono stati trasferiti a Barcellona è perché nessun produttore
italiano si è voluto interessare al progetto della pellicola, che in
pochi mesi di proiezioni in Uruguay ha polverizzato i record di
incasso nazionali, e superato anche film americani di successo.
Oltre all’importanza tematica, che denuncia una condizione troppo
spesso ipocritamente ignorata e dimenticata, è da mettere in evidenza
la modalità del racconto, che assume uno sguardo fortemente
focalizzato sulla protagonista femminile (uno sguardo di genere, un
film sulle donne girato da una donna), basandosi soprattutto sui suoi
sogni, sulla sua genuinità e freschezza di carattere, capace non solo
di resistere e rovesciare la drammatica situazione in cui si trova, ma
anche di illuminare con la sua presenza lo squallore della realtà; di
rendere piacevole, con la sua innata vitalità, una storia così
sordida.
Purtroppo il lieto fine del film non corrisponde del tutto alla
realtà, in quanto la vera Elisa riuscì sì a tornare a casa,
grazie anche all’interessamento al suo caso da parte del giornalista
e delle autorità, ma oggi la donna è desaparecida, e si
ignora se si sia nascosta o se abbia subìto la rappresaglia delle
organizzazioni criminali, secondo quanto ha dichiarato la regista alla
proiezione del film al Festival.
Interamente in Europa si svolge la storia raccontata dal cileno Luis
Vera, Bastardos en el paraíso, premio alla miglior regia. Il
regista ha vissuto e lavorato a lungo in Svezia, nel suo esilio dal
Cile di Pinochet, dopo avere trascorso alcuni anni in Perù e Romania.
La tecnica di ripresa, messa in scena e recitazione, è molto simile
al Dogma di Lars Von Trier, anche per l’uso del digitale: camera a
spalla, mossa, effetto verità documentaria, dialoghi spesso
concitati, situazioni collettive riprese “dal vero”. Un cinema,
come afferma l’autore, che “si libera dalla spettacolarità degli
effetti speciali” per proporre riflessioni ed emozioni profonde, che
rielabora e aggiorna, secondo chi scrive, la poetica del realismo.
Produzione (Latinordisk Films), attori, dialoghi sono per la gran
parte svedesi e l’ambientazione è Stoccolma, principalmente i
quartieri periferici dove risiedono gli immigrati, tra cui le “teste
nere”, i sudamericani, spesso rifugiati politici. Un mondo che il
regista conosce sicuramente bene.
La storia narra la parabola di Manuel, figlio di rifugiati cileni, che
vive la schizofrenia di una doppia identità, costruita sull’eterna
promessa del “ritorno” verso una patria che non ha mai realmente
conosciuto. Al contempo, mostra l’esistenza di sottili meccanismi di
esclusione nei confronti degli immigrati, che se migliorano la loro
situazione materiale rispetto al paese di provenienza, vivono un’emarginazione
da cittadini di seconda categoria. In questa situazione, l’unica via
che Manuel riesce ad individuare per farsi rispettare nella società
che lo discrimina è quella criminale, l’illusione e il miraggio di
denaro e potere facile. I valori del padre, l’onestà, la dignità,
la lotta, non hanno alcun senso per il giovane, in una società in cui
anche i giovani svedesi vivono ormai solo per i soldi e il successo.

La narrazione si struttura in due
tempi intorno ad un fatto violento tratto dalla cronaca nera del 1994:
una rissa con arma da fuoco all’esterno di un locale notturno nel
quale non era stato consentito l’ingresso a dei giovani immigrati.
La stampa locale diede risalto alla notizia, come sintomo del “problema
immigrazione”, delle difficoltà del modello scandinavo di
accoglienza e benessere generalizzato, e motivo di una crescente
xenofobia. Per Vera l’episodio costituisce il momento culminante del
percorso di Manuel e dei suoi amici, che dalle bravate tipiche dell’adolescenza
slittano progressivamente verso la delinquenza vera e propria. Al
delitto segue il procedimento giudiziario con cui i giovani sono
condannati a diversi anni di galera, ma che rappresenta anche l’occasione
per un esplicito contro-processo alla società scandinava, rea di non
avere mai offerto reali occasioni di integrazione, colpevole di un’ipocrita
accoglienza parziale degli immigrati, accuse realizzate in aula dall’ormai
anziano ex professore di liceo dei ragazzi.
In questo senso il film è in grado di mettere a fuoco problematiche
inerenti ai due mondi messi in contatto. Se infatti in Cile è stato
visto principalmente come denuncia della xenofobia europea e
riflessione sulla problematica identità degli esiliati, per gli
europei può essere uno specchio nel quale approfondire il tema del
vuoto di valori, del preoccupante affermarsi di una cultura
individualista e violentemente consumista, frutto della fine delle
utopie di cambiamento. Emblematica è infatti la scelta finale di una
delle protagoniste, Lena, che decide di riprendere l’eredità del
vecchio professore dedicandosi ai bambini, per proporre almeno la
speranza in un futuro diverso.
Concludiamo con Bicho de sete cabeças, di Laíz Bodansky, film
brasiliano sull’inferno delle istituzioni psichiatriche, cui è
stato elargito il premio alla miglior opera prima e il premio della
giuria degli studenti della città. La storia si basa sulla tragica
esperienza di Austregésilo Carrano, da lui narrata nel libro Rincón
de los malditos (nella traduzione spagnola). Attualmente Carrano
è attivista del movimento anti-manicomiale in Brasile, dove, secondo
le sue denunce, ancora settantamila uomini e donne subiscono la
violenza delle istituzioni psichiatriche autoritarie. Una nuova legge,
votata il passato Aprile, si propone di chiudere questi centri, che
spesso ritengono i “pazienti” molto più del dovuto per poter
usufruire dei fondi pubblici, come mostrato dal film e come confermato
dal ministro della sanità brasiliano José Serra in un articolo del
quotidiano del Costa Rica La Nación, ma il processo può
richiedere ancora degli anni.
La storia di Neto, protagonista del film, mostra come dai suoi
atteggiamenti appena un po’ ribelli (vuole viaggiare da solo e senza
molti soldi, si dedica a “graffitare” i muri della città e infine
fuma occasionalmente degli spinelli), il padre concluda la necessità
di internarlo e sottoporlo ad una cura psichiatrica. Medici ed
infermieri della clinica agiscono in base a una routine repressiva che
mira soltanto al mantenimento dei pazienti nella struttura, e che è
responsabile del loro peggioramento. La chiusura forzata, l’eccesso
di farmaci, e infine l’elettroshock punitivo per un tentativo di
fuga, provocano in Neto un effettivo squilibrio mentale dal quale non
riuscirà a riprendersi. Quando finalmente esce dalla clinica, è in
uno stato fortemente depresso, e cade poi in un’ulteriore crisi che
lo porta ad un secondo internamento, ancora peggiore del primo. Qui ha
l’ostilità diretta di un infermiere piuttosto brutale, che alla
fine cerca anche di lasciarlo morire nel suo tentativo di suicidio,
senza soccorrerlo.
Alla violenza delle “cure” psichiatriche si aggiunge la
problematica dell’incomprensione generazionale tra genitori e figli.
È infatti il padre che costringe Neto nella clinica, convinto che sia
l’unico modo per curarlo da quella che crede sia tossicodipendenza.
Soltanto alla fine, in seguito ad una lettera che Neto gli scrive
prima di tentare il suicidio, sembra rendersi conto del suo errore, e
decide di liberare il figlio dai tentacoli del “mostro psichiatrico”.
Il film ha suscitato molto interesse in Brasile, soprattutto negli
ambienti legati alla medicina e alla psichiatria. Infatti non solo ha
il merito di denunciare apertamente una situazione per molti
sconosciuta, ma la modalità di rappresentazione evita attentamente di
proporre un’immagine stereotipata o caricaturale della follia.
La parte iniziale del film mostra il personaggio di Neto nella sua
vita quotidiana: è un ragazzo normale che aspira alla libertà, e non
c’è nulla nel suo carattere che faccia presagire il tragico destino
che lo attende. In questo modo il tema viene avvicinato nella
percezione: non si tratta di fatti lontani che riguardano “i pazzi”,
come se si trattasse di una categoria separata, ma di una realtà che
ci tocca direttamente, e così lo hanno sentito gli studenti che hanno
premiato il film. Hanno partecipato alla co-produzione del progetto
Fabrica Cinema (dell’azienda Benetton) e la RAI.
I film premiati:
Miglior film: Un amor de Borges, di Javier Torre, Argentina,
2000.
Miglior sceneggiatura: Nueve Reinas, di Fabián Belinsky,
Argentina, 2000.
Premio speciale della giuria: En la puta vida, di Beatriz
Flores Silva, Uruguay, 2001.
Miglior regia: Bastardos en el paraíso, di Luis Vera, Cile,
2000.
Miglior opera prima e premio della giuria studentesca: Bicho de
sete cabeças, di Laíz Bodansky, Brasile, 2001.
Miglior fotografia: La fiebre del loco, di Andrés Wood,
fotografia di Joan Littín, Cile, 2001.
Premio del pubblico: História do Olhar, di Isa Albuquerque,
Brasile, 2001.
Vi
e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di
vista cliccando qui
Archivio Cinema
|