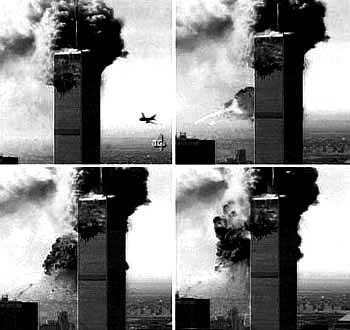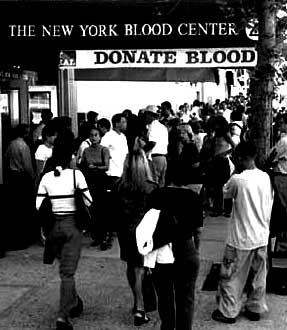|
Il Terrorismo, la guerra
e il valore del sapere
Gli attentati dell’11 settembre a New York e Washington hanno
modificato la nostra ordinaria visione del mondo, hanno portato
dolore, morte, danni economici, hanno suscitato indignazione,
hanno provocato una necessaria reazione armata degli Stati Uniti
e degli alleati. In poche ore siamo stati costretti a ripensare
molte cose della nostra vita quotidiana, per molteplici aspetti
(economici, sociali, politici, religiosi, psicologici etc.). È
un momento in cui occorre determinazione e sapienza nella risposta,
ma è anche un momento di sconcerto per milioni di persone.
Reset ha chiesto a studiosi di varie discipline di riflettere
sul loro sapere e di dirci quale contributo ritengono di poter
comunicare in modo che sia utile a tutti, per superare lo sconcerto,
per orientare la ragione, per aiutare la collettività a dare il
massivo vigore all’uso pubblico della ragione. Su questo numero
speciale di Reset www.reset.it
ospitiamo i contributi di studiosi ed esperti delle discipline
del sapere; dalla filosofia al diritto, dalla sociologia alla
storia delle religioni, dall’economia alla politica, il sapere
ci si presenta come occasione di riflessione per trovare risposta
alle domande e per porre nuovi interrogativi.
Vogliamo chiamare anche i lettori di Caffé Europa e di Reset ad
offrire un loro contributo, scrivendo a specialereset@libero.it,
per cercare di ragionare insieme sulla realtà che stiamo vivendo
e sugli sviluppi che ne possono nascere.
( Hanno collaborato: Elisabetta Ambrosi, Stella Bianchi, Mauro
Buonocore, Clementina Casula, Ettore Colombo, Ilaria Favretto,
Ingrid Fuchs, Michela Gentili, Barbara Iannarella, Chiara Rizzo.)

Serve un
piano Marshall contro il terrorismo
Daniele Archibugi*
La caduta del muro di Berlino doveva aprire una fase della politica
mondiale fondata sulla legalità, la democrazia e la cooperazione
tra i popoli. Bisogna impedire che la caduta delle Torri gemelle
non chiuda questa fase di speranza. Occorre uno sforzo politico,
etico e culturale gigantesco per conseguire questo risultato.
Tutti noi comprendiamo pienamente che i nostri fratelli e sorelle
americani si sentano oggi più insicuri, più vulnerabili e, soprattutto,
profondamente offesi nella loro vita civile. Bisogna rendere esplicito
che non è in corso una guerra del mondo contro gli Stati Uniti,
ma al contrario una guerra del mondo civile contro un gruppo isolato
d’esaltati assassini.
Quando il numero delle vittime è ancora incerto, oggi la preoccupazione
principale riguarda il futuro. Il nostro futuro non è nelle mani
di gruppuscoli di terroristi senza nome, ma in quelle di un Presidente
eletto democraticamente, di organi istituzionali (Parlamento,
Corte Suprema, ecc.), i quali negli Stati Uniti agiscono di fronte
ad un’opinione pubblica che dispone di un accesso istantaneo all'informazione.
A loro ci dobbiamo appellare affinché il mondo intero non ricada
nelle barbarie della lotta di tutti contro tutti.
L’obiettivo politico dei terroristi è uno solo: riportare il pianeta
in una sfera di paura, di diffidenza, di lotta tra civiltà e culture
diverse. Se vogliamo veramente sconfiggere i terroristi, dobbiamo
opporre una visione del mondo fondata sulla trasparenza, la fiducia,
il confronto tra le civiltà.
Noi europei possiamo svolgere un ruolo molto importante. Siamo
culturalmente vicini al popolo americano, e geograficamente ai
popoli arabi. Se oggi vogliamo aiutare il popolo americano, dobbiamo
riuscire a tramutare la sua (e nostra) legittima collera in azioni
politiche che non siano solo repressive e di breve periodo, ma
anche costruttive e durature. Siamo tutti consapevoli che non
si risponde al terrorismo con il terrorismo, ma poi, paradossalmente,
ben pochi prendono posizione quando si sente il Ministro della
Difesa della democrazia americana "non escludere" l'uso
di armi atomiche. Che cosa sarebbe l'atomica se non una risposta
terroristica, e con conseguenze più indiscriminate e letali, agli
atti di terroristi stessi? Come mai i governi europei non hanno
immediatamente ribattuto chele armi atomiche sono inutili per
combattere il terrorismo, ma che invece occorrono le indagini,
le polizie, i tribunali?
Come europei, dobbiamo oggi far riemergere la migliore tradizione
democratica del popolo americano, non metterci a ad applaudire
ogni volta che sono mostrati i bicipiti.
Negli anni successivi alla Seconda Guerra mondiale, gli Stati
Uniti hanno agito con grande saggezza nei confronti dei nemici
del giorno prima. Dopo aver liberato l'Europa dal fascismo, hanno
deciso di punire i responsabili con il Tribunale di Norimberga
piuttosto che con la rappresaglia. Ma hanno anche pensato anche
al futuro remoto, contribuendo in maniera decisiva a rimuovere
le cause della dittatura che si era affermata in Germania, Italia
e Giappone. Le istituzioni democratiche di molti paesi europei
devono molto al fratello americano. Tramite il Piano Marshall,
gli Stati Uniti hanno aiutato la ricostruzione economica, condizione
essenziale per il progresso delle istituzioni democratiche.
Oggi ci vuole oggi una reazione ugualmente coraggiosa, un vero
e proprio Piano Marshall contro il terrorismo, al quale partecipino
tutte le nazioni civili, e il cui onere sia sostenuto dai paesi
più ricchi.
Molte persone stanno discutendo su quali siano le azioni efficaci
per snidare e punire i colpevoli. Spero solo che si trovino i
diretti responsabili, e che questi possano il prima possibile
essere portati di fronte alla giustizia, di fronte ai parenti
delle vittime. Spero allo stesso tempo che non ci siano vittime
innocenti raggiunte dai proiettili e dalle bombe dei paesi democratici
solo perché si trovano incolpevolmente e inconsapevolmente accanto
ad un terrorista.
Mi permetto invece di indicare le azioni necessarie volte ad estirpare
le basi sociali del terrorismo.
Far entrare in vigore immediatamente la Corte penale internazionale,
cui affidare il compito di giudicare in modo trasparente e imparziale
gli individui responsabili di crimini contro l’umanità, inclusi
i reati di terrorismo.
Creazione di una Polizia internazionale, a disposizione dell’istituenda
Corte penale, dotata di intelligence sofisticata, volta a individuare
le basi operative del terrorismo.
Rafforzare i poteri della Corte di giustizia internazionale per
valutare l’operato degli stati e la loro connivenza con il terrorismo.
In particolare, richiedere alla Corte di giustizia un parere giuridico
prima che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU decreti la legittimità
dell’uso della forza contro gli stati.
Impegno della comunità internazionale al fine di risolvere il
conflitto tra Israele e Palestina.
Interventi finanziari al fine di eliminare i campi profughi, dove
le inumani condizioni di vita agevolano il reclutamento dei terroristi.
* dirigente Cnr

No alle semplificazioni
Laura Balbo*
La «domanda» verte sul possibile contributo di ciascuno (per come
in questi giorni elabora gli avvenimenti dell’11 settembre: e
questo lo facciamo tutti, sia dentro di noi, sia verso gli altri)
per «superare lo sconcerto, orientare la ragione, aiutare la collettività
a dare il massimo vigore all’uso pubblico della ragione». Io penso
sia essenziale aggiungere a queste un’altra finalità: quella di
«contrastare le semplificazioni».
Il mondo della politica e il mondo dei media hanno ragioni ben
ovvie, e comprensibili, che portano a «semplificare»; ed è a questo
che abbiamo assistitito. Ma proprio a questo «gioco» non voglio
stare, a questa modalità non detta ma così generalmente condivisa,
che ha scelto di offrire, in questa tremenda circostanza, una
risposta di rassicurazione e semplificazione.
Non accetto, né come «intellettuale» né come «europea»,
la prevalente lettura readymade che ci viene somministrata, non
accetto questo compatto coro di interpreti (troppo sicuri e rapidi)
di avvenimenti complessi. Come intellettuale, perché se riconosco
a politici e gente dei media le irrinunciabili ragioni del loro
semplificare, rivendico il diritto di non fare altrettanto (nei
confronti almeno di alcuni interlocutori,i miei studenti
per esempio; in alcune situazioni di dibattito più approfondito
e vigile; e in ogni caso in questi momenti, ancora tanto provvisori,
imprecisi). Come «europea», perché di fronte a eventi di portata
davvero mondiale (anche nel nostro immaginario: quando mai prima
ci era successo di avere davanti agli occhi nello stesso momento
lo spazio da New York a Kabul, la folla dolente nello Yankee Stadium
e le migliaia in preghiera nelle moschee dell’Afganistan, la sofferenza
e la paura e anche la rivendicazione di identità sia degli uni
che degli altri) non posso non tener conto del fatto che sono
«collocata»(positioned: il termine inglese è quello che mi appare
più preciso e utile) in questa parte del mondo -l’Europa,
l’Occidente- e non in un’altra; e che comunque si tratta, «the
west and the rest», occidente o islam, di «costruzioni»:
costruzioni sociali e culturali.
Dunque di fronte alla macchina di semplificazione che si è messa
in moto : appunto Occidente e Islam, noi vittime e loro
terroristi e fanatici, noi che siamo legittimati a definire
gli eventi per tutti, noi da cui dipendono le sorti del
mondo il contributo che si dovrebbe dare è di modestia, umiltà.
Alcuni, certo non tutti, di questo sentono la mancanza: e se non
fossimo, ancora una volta, in grado di prevedere e di capire;
se tutto di nuovo ci sfuggisse, poiché davvero la complessità
degli eventi mette in scacco la razionalità e la possibilità di
«governo» ?
Di fronte a tutto questo, provare ad essere intellettualmente
poco arroganti, segnati da ambivalenze e dubbi, e capaci di reggere
la non-semplificazione: è un contributo utile?
*Sociologa

Non è un
fantasma senza volto
Oliviero Bergamini *
“Niente sarà più come prima”, si è sentito ripetere in questi
giorni. Purtroppo, non è così. Certamente, a livello emotivo e
simbolico l’attacco alle torri gemelle e al Pentagono rappresenta
una novità sconvolgente, perché per la prima volta nella storia
gli Stati Uniti sono stati colpiti in modo così drammatico sul
loro territorio nazionale. La loro aura di invulnerabilità è stata
squarciata, e il senso di smarrimento che anche molti europei
hanno provato per questo testimonia la capillarità con cui l’idea
della “diversità” americana è penetrata nelle coscienze.
Indubbiamente, inoltre, gli attentati hanno posto il mondo di
fronte a una realtà inquietante: il fatto che all’interno della
nostra opulenta e compiaciuta società possano agire organizzazioni
terroristiche animate da un fanatismo irriducibile rispetto ai
valori “civili”, e capaci di sfruttare abilmente un misto di tecnologia
“bassa” (i coltellini usati nel dirottamento, i contatti personali
che sfuggono ai sistemi di sorveglianza) ed “alta” (i simulatori
di volo con cui i dirottatori hanno certamente provato più volte
lo schianto sulle torri gemelle.)
Queste novità, tuttavia non vanno estremizzate; non devono degenerare
in una psicosi, far pensare ad una nuova “era dell’insicurezza”.
Gli analisti militari, da tempo consideravano il terrorismo internazionale
una minaccia prioritaria. Esso ha una genesi, una storia, strutture
e modalità di azione che per quanto complesse sono ricostruibili,
e contrastabili utilizzando metodi adeguati. Non è un fantasma
senza volto, una creatura indistinta e demoniaca da combattere
con una crociata. È un fenomeno complesso e ramificato, ma come
ogni altro, umano, materiale, articolato in reti finanziarie,
operative, logistiche che possono essere colpite con un lavoro
sistematico e razionale.
Soprattutto, la “guerra contro il terrorismo” non deve diventare
l’occasione per ripetere errori di politica estera e militare
devastanti. In che cosa può consistere la “new war” proclamata
da Bush ? Bombardamenti di civili innocenti in Afghanistan e Iraq?
Improbabili azioni via terra? Il rovesciamento di un regime –
quello dei Talibani – che gli Stati Uniti hanno contribuito a
creare, da sostituire con un altro governo fantoccio ?
Le stragi dell’11 settembre dovrebbero stimolare un ripensamento
complessivo della politica americana, e indirizzarla verso un
approccio più razionale, informato, consapevole della grande complessità
degli elementi in campo, rispettoso delle sensibilità e degli
interessi dei popoli islamici. Solo questo, accanto a un riorientamento
complessivo dell’intelligence, potrebbe davvero rappresentare
un duro colpo per il terrorismo. Se negli ambienti militari la
sindrome del Vietnam è ancora presente (ma il cambiamento generazionale
nelle forze armate ne sta gradualmente indebolendo il ricordo),
in quelli politici essa pare praticamente scomparsa. Dopo la guerra
del Golfo e la caduta del muro di Berlino, gli Stati Uniti sembrano
di nuovo pervasi da una ottusa convinzione di poter “fare giustizia”
su scala globale; uno strano senso di onnipotenza, cui fa da schizofrenico
contraltare il nuovo senso di insicurezza e vulnerabilità. E così
tornano scene già viste per tutto il corso della Guerra Fredda;
una leadership politica che usa un linguaggio assurdamente totalizzante
(“giustizia infinita”), che assume unilateralmente impegni di
portata mondiale; che si crea da sé un problema di credibilità
ed è poi costretta a procedere sulla strada di un intervento militare
tanto massiccio quanto incerto negli obiettivi; che semplifica
scenari estremamente complessi e rischia di sopravvalutare le
forze effettive del “nemico”; che identifica i propri interessi
con quelli del mondo. Tutto questo, non appare cambiato dopo gli
attentati dell’11 settembre; e le conseguenze rischiano di costituire
la maggiore vittoria del terrorismo.
* docente presso l’Università di Bergamo, si occupa di storia
politica e militare degli Stati Uniti .

Cambia la
logica del confronto
Giorgio Bogi
La sinistra è di fronte ad una fase di politica internazionale
che sarà lunga e richiederà scelte e passaggi difficili. Dopo
l’attentato dell’11 settembre la popolazione ha bisogno di precisi
orientamenti, di fronte ad una condizione di incertezza, di paura,
che non ha precedenti negli anni recenti della nostra storia.
Il primo punto politico, allora, è che non c’è molto spazio per
sottili distinguo, per atteggiamenti prudenti, o per furbizie.
Serve invece ancorare il proprio atteggiamento politico ad una
posizione di grande chiarezza per poter esprimere un ruolo di
guida, di chiaro orientamento, appunto, che altrimenti sarà svolto
dalle forze della destra, e con esiti forse meno rassicuranti.
Per farlo occorre individuare il senso dell’attacco portato dal
terrorismo internazionale, l’11 settembre. Colpiscono, in quel
che è avvenuto, la spietatezza, la ferocia e la barbarie. Colpisce
la portata eccezionale dell’attentato alla sicurezza, alle regole
di base della convivenza civile, ai valori, anche economici, del
mondo cosiddetto occidentale. Ma ad una riflessione razionale
non può sfuggire che il significato che si svela dietro il salto
di qualità compiuto dal terrorismo è la disarticolazione di ogni
tentativo di stabilire delle regole condivise di governo della
situazione mondiale. Un problema che non riguarda solo gli Stati
Uniti e i loro alleati, né riguarda solo l’Occidente o le democrazie.
Il vero attacco è quello portato alle uniche regole politiche
conosciute su cui può attuarsi la speranza di governo della situazione
mondiale: quello che si cerca di fondare anzitutto attraverso
l’Onu, pur con tutti i suoi limiti, attraverso organismi internazionali
(Bce, Fmi, …) ma che passa altresì attraverso altre organizzazioni
sub-mondiali, a cominciare dall’Unione Europea.
Nel momento in cui ci si confronta, anche duramente, sugli effetti
della globalizzazione e sulle regole per governarla; nel momento
in cui si cerca di prendere atto del fatto che la diffusione e
la condivisione dei benefici della globalizzazione richiedono
forti interventi di riequilibrio a favore delle aree più deboli
del mondo, il terrorismo, questo terrorismo, cambia la logica
del confronto, esponendo al rischio di inaridire ogni terreno
di dialogo razionale.
Di fronte a questo tipo di attacco, e di pericolo, l’errore che
la sinistra non deve commettere è quello di rimanere incastrata
nella morsa tradizionale del condizionamento “pacifista” e di
quello “anti-americano”.
Se la risposta necessaria deve essere tesa a ristabilire la superiorità
di un confronto basato su regole condivise, non si possono avere
pregiudiziali rispetto al ricorso ad un intervento, certo non
di vendetta, ma comunque commisurato alla sfida e all’obiettivo
di ricostruzione delle regole e delle relazioni. Non è la guerra
per difendere i nostri confini, o i nostri consumi, ma lo spazio
di una speranza comune alla grande maggioranza dei paesi del mondo.
Le regole disarticolate dal terrorismo non coincidono con quelle
imposte da una “politica imperiale”, ma hanno la loro legittimazione
appunto come strumento disponibile di governo della situazione
mondiale: e per questo andranno rese sempre più efficaci. Il pregiudizio
“anti-americano” nel caso specifico non ha senso: gli Stati Uniti
possono aver commessi degli errori (e molte omissioni sono state
commesse da noi europei) nel governo delle crisi mondiali. Ma
non è questo che oggi può guidare le decisioni. L’attacco alle
Torri di New York genera una oggettiva destabilizzazione che colpisce
tutti: a cominciare dai paesi che possono riporre solo in una
soluzione, diciamo razionale, dei problemi mondiali, cioè basata
su regole, le speranze di crescita e di riequilibrio delle risorse.
E questo è un contributo della nostra cultura democratica.
Di fronte a questa sfida, la ratio effettiva della risposta non
è neppure la punizione dei colpevoli, ma la difesa di uno spazio
razionale di discussione e di soluzione dei problemi mondiali,
entro il quale i conflitti anche più duri possano essere formalizzati
e depurati della loro carica di violenza. È questo, più che il
connotato di barbarie diretta, che costituisce l’effettiva legittimazione
della lotta senza cedimenti al terrorismo.
*parlamentare ds
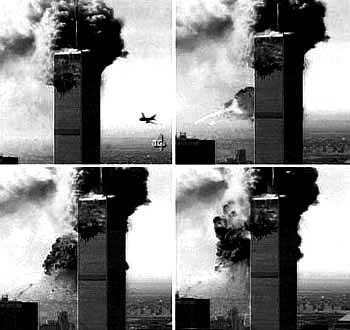
Europa, due
volte colpevole
Giampaolo Calchi Novati*
Quale che sarà l’impiego effettivo dei mezzi che sono stati esibiti
come se si trattasse di una parata militare e dei 100 e più paesi
i cui governi hanno compiuto l’atto rituale del riconoscimento
dell’“impero”, sarebbe un torto per il carattere virtualmente
illimitato della globalizzazione supporre che una chiamata alle
armi e una mobilitazione di queste proporzioni, all’intersezione
delle linee della geopolitica del futuro fra Medio Oriente, Asia
centrale e Cina, in cui conta soprattutto il modo di collocarsi
nel mercato, fra cooptazione e marginalità, sfuggano alle regole
generali e rispondano a motivazioni contingenti, per quanto drammatiche
e senza precedenti. È singolare che siano proprio i cultori della
Realpolitik, quelli che la praticano per interesse e quelli che
la invocano per paura di apparire obsoleti, a non cogliere i fatti
nella loro sostanza evocando i conflitti di ieri e miti abusati
come l’“antiamericanismo”. A confronto, è più aggiornato Berlusconi
con la sua tanto deprecata esternazione sull’arretratezza e illiberalità
innata dell’Islam, visto che una simile raffigurazione corrisponde
ai pregiudizi di una fetta della cultura politica e soprattutto
ai sentimenti e alle paure di vasti settori dell’opinione pubblica
in Italia e in Europa, disorientati dalle trasformazioni in atto
e insicuri della propria condizione.
Fra Est-Ovest e Nord-Sud il mondo dell’ordinamento bipolare, dotato
di un suo equilibrio, era articolato lungo frontiere “ideologiche”
che in qualche modo attraversavano i singoli paesi. Nel “nuovo
ordine mondiale” proclamato da Bush padre non solo non v’era più
posto per la dimensione Est-Ovest, essendosi dissolto il presupposto
dell’esistenza (e della “minaccia”) di nazioni o forze politiche
“antisistema”, ma anche la dimensione Nord-Sud perdeva di nettezza
dal momento che nessuna “rivoluzione” avrebbe più trovato sbocchi
credibili e solidarietà in uno dei due vertici del sistema. Si
era veramente chiusa una fase storica: la confrontazione globale
in un mondo diviso. Le conseguenze del collasso del blocco sovietico
non si fermavano alla scomparsa dell’antagonista degli Stati Uniti,
gettando le basi dell’egemonia dell’unica superpotenza superstite,
garante dell’unica forma “lecita” di accumulo e distribuzione.
Ferma restando la priorità assoluta della regione petrolifera,
proprio gli Stati dell’Est europeo sono assurti a principale terreno
di conquista del capitalismo, il boccone più succoso dell’allargamento
dei mercati rovesciando alla lettera l’esclusione di Urss e “satelliti”
decretata nel 1946-47 per incompatibilità con le regole del “mondo
libero”. E che destino aspettava la volontà di indipendenza che
i popoli e intanto le élites dei paesi dell’Asia e dell’Africa fuoriusciti dal campo coloniale
per effetto della decolonizzazione avevano coltivato e parzialmente
soddisfatto anche grazie al riferimento politico e comportamentale,
poco importa se reale o nominale, che offrivano il non-allineamento
e i modelli non-capitalisti?
Si poté intuire come si sarebbe assestato il sistema mondiale
quando nel 1990, senza soluzione di continuità con la fine della
guerra fredda, gli Stati Uniti - per “punire” Saddam Hussein reo
di aver invaso il Kuwait - dislocarono da Est a Sud l’armamentario
militare e propagandistico che era servito per il “contenimento”
dell’Urss e del comunismo. Nell’ottica dell’Occidente, deciso
a difendere i propri privilegi con tutti i mezzi, era comprensibile
il timore che l’accesso a beni che considera di sua spettanza
ovunque si trovino potesse essere ostacolato dall’inevitabile
turbolenza della transizione o dalle ambizioni dei ceti civili
o militari emergenti con lo sviluppo. Non ci sono differenze sostanziali
con le dinamiche della guerra scatenata da e contro Milosevic.
Non sempre la “posta” ha un nome e cognome in chiaro come quando
c’è aria di petrolio. Titolari di un dominio incontrastato, gli
Usa possono scegliere gli avversari “giusti” conferendo un’apparenza
di Idealpolitik all’affermazione e espansione del loro strapotere.
Per colmo d’ironia, con la crisi temporanea o irreversibile dei
progetti di liberazione di portata universale, l’opposizione a
quello che si può ben chiamare “imperialismo”, a condizione di
non pensare che sia lo stesso dell’Inghilterra vittoriana, ha
la tendenza a rifugiarsi in politiche autoritarie o identitarie
che danno solo l’illusione di placare le frustrazioni diffuse.
Le guerre non sono pagate solo dai “mostri” che vengono via via
costruiti ad hoc, e che spesso sono solo gli scarti della strategia precedente.
Il “terrore” è una componente essenziale della normalizzazione
in atto: “colpirne uno per educarne cento”, come recita una massima
un tempo molto in voga. Se mai, Bush e Clinton hanno convocato
al proprio fianco gli alleati, che, anche loro, dipendono dalle
medesime risorse e sfruttano una stessa rendita di posizione.
Ciò che la Casa Bianca non è disposta a sopportare - e che può
impedire o con l’unilateralismo abbozzato da Bush figlio nei primi
mesi di presidenza o con l’arruolamento di tutto il mondo (neppure
più della sola Nato come avvenne per la Jugoslavia) sotto la bandiera
a stelle e strisce - è un’Europa che, mentre l’America svolge
i compiti del gendarme, si rafforzi a sua spese stabilendo rapporti
di buon vicinato con le aree in via di sviluppo o di liberalizzazione
(i Balcani, il Medio Oriente, la stessa derelitta Africa).
L’apocalisse a New York e Washington, da questo punto di vista,
ha colmato la misura. È bastato mostrare in ogni telegiornale
per due settimane le terribili immagini delle due Gemelle di Manhattan
in fiamme per avvolgere il mondo in una nebbia di retorica e imporre
una specie di unanimismo obbligato. Questa volta forse la messinscena
della preparazione è più importante del seguito. Nel calore e
furore della battaglia, infatti, è forte il rischio che sorgano
di nuovo perplessità, distinguo e resistenze. Anche in Europa,
dove, Gran Bretagna a parte, l’esercizio della potenza “civile”
è più consona agli interessi delle singole nazioni che non l’uso
insistito della sanzione militare con l’ostentazione di fini etici
(la giustizia infinita, il Bene contro il Male) e risultati sempre
più simili a quelli di un’operazione coloniale di tipo classico
(occupazione del territorio, istituzione di costosi protettorati,
sostituzione delle leaderships
in carica con dei “collaboratori”). Ma saranno soprattutto i governi
arabi e musulmani che patteggiano con gli Stati Uniti ad essere
più vulnerabili, realizzando paradossalmente il solo obiettivo
razionale che si intravvede dietro gli attentati, ammesso che
il nemico invisibile sia Osana bin Laden o qualche altra scheggia
della nebulosa islamistica.
La forza di cui dispone l’Occidente è tale che esso, come insieme
di paesi definiti ma anche come idea o metafora, è ormai una realtà
oggettivamente “diversa” dal resto del mondo o “superiore” (ancorché
non nel senso delle rozzezze di Berlusconi). Sta in questa sua
grande forza la maggiore responsabilità dell’Occidente. Probabilmente
gli Stati Uniti ne sono consapevoli. Ma si limitano a tingere
di “moralità” la loro strategia totalizzante, comprese le guerre
per correggere i propri errori o le deviazioni dei propri protetti.
Doppiamente colpevole l’Europa, che nella sua passiva mediocrità
non osa proporre qualcosa di più “inclusivo”. I “progressi” della
politica mondiale promossi o promessi dall’Occidente – uno scenario
che ha a che vedere con la globalizzazione ma che non è solamente
la internazionalizzazione dei mercati e della comunicazione riguardando
anche temi come l’ordine e la giustizia - sono sempre lì lì per
produrre un salto di qualità ma per il momento gli spazi di libertà
per chi, nazione o classe sociale (non necessariamente i poveri),
non appartiene al blocco vincente sono angusti e addirittura disperanti.
Dopo tutto, il liberalismo non ha mai trasferito, nemmeno concettualmente,
il suo apparato ideale e normativo sulle formazioni non liberali
(e lo dimostrano il colonialismo e le guerre coloniali, il razzismo,
l’apartheid).
L’Occidente - o almeno l’Europa - è in grado di credere finalmente
ai principi che predica contrapponendo il diritto alla violenza
e la pace alla spirale delle guerre nella periferia o semiperiferia
di cui anche il “centro” è parte attiva già da prima dell’11 settembre?
Nonostante la visibilità che, anche al di là delle semplificazioni
del citatissimo Huntington, assumono in pressoché tutte le crisi
i richiami alla fede o alle civiltà e tradizioni dei due opposti
fondamentalismi, il problema è essenzialmente storico, frutto
del divenire e non della stasi o del determinismo, trattandosi
di ricomporre in una storia di tutti e per tutti le storie diverse
ma intrecciate e reciprocamente contaminate che i vari popoli
hanno vissuto o credono di aver vissuto.
*Storico. Insegna Storia dell’Africa alla facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Pavia

Da quale punto
di vista?
Marina Calloni*
La potenza simbolica, l’impatto socioeconomico, la valenza politica
e le reazioni individuali che l’attacco alle Twing Towers hanno
avuto sull’opinione pubblica, non può che aver segnato un profondo
solco nella memoria collettiva, spingendo ad un’immediata risposta
bellica. Da ormai tre settimane non si fa che parlare di altro
e la nostra vita collettiva è cambiata. Diventa allora quasi imbarazzante
trovare “argomenti originali” rispetto al molto o al troppo di
cui si è già detto. In effetti, sono più le domande di fondo che
vanno poste, piuttosto che le certezze: dove si dirigerà ora la
storia? Come poterci riorientare? Cosa ci aspetta? Ma vi è un
problema specifico: da che punto di vista mi posso porre, per
“giudicare” quanto accaduto?
In realtà l’attuale sfera pubblica, mondialmente diffusa, ha cancellato
quell’antico privilegio che era riservato al sapere degli specialisti
come opinion makers. Inoltre sono state le immagini stesse ad
aver indotto tale cambiamento: si è potuto tanto vedere, quanto
partecipare in diretta alla devastazione e alla morte di migliaia
di persone. Telecamere, soprattutto amatoriali, hanno contribuito
a togliere il mistero dell’attacco terroristico e hanno invece
impresso la certezza. Se non esiste più quel ristretto pubblico
di lettori, che stavano alla base dell’idea di sfera pubblica
illuminista, teorizzata da Kant, cosa significa allora fare un
“uso di massa” della “ragione pubblica”? Ma com’è possibile procedere,
a partire da se stessi, ben consapevoli che non sempre si può
parlare in nome della comunità, del partito, della chiesa o di
che altro, e ben sapendo che le nostre parole saranno praticamente
inefficaci rispetto a ciò che è in atto? Che senso ha sottoscrivere
appelli, che in questi ultimi giorni si sono esponenzialmente
moltiplicati, soprattutto via Internet? Che cosa significa essere
pacifisti, quando, di fatto, una guerra “nuova e silenziosa” è
già iniziata?
Difficile appare il compito di isolare un solo elemento della
questione e impossibile appare anche la possibilità di affrontare
l’accaduto nel suo insieme, poiché le diverse angolature prospettiche
possono anche confliggere. Diversa è, infatti, la prospettiva
se consideriamo la vicenda dal punto di vista, economico, finanziario,
politico, oppure se l’affrontiamo dal punto di vista del “pubblico”
e della “gente comune”. Eppure questi aspetti sono perlopiù complementari.
La globalizzazione non può, infatti, che essere “glocale”, poiché
i suoi effetti – finanziari e politici – coinvolgano le nostre
singole vite, anche a migliaia di chilometri di distanza: dai
parenti delle persone uccise, a chi ha perso soldi negli investimenti
in borsa, fino a chi – da parti opposte – si sta preparando ad
offrire la propria vita per la “patria” e i valori in cui si crede.
Questa “nuova guerra”, che per ora è territorialmente circoscritta,
in realtà è già totale: ognuno può essere vittima del terrorismo
e tutti gli stati – per ragioni politiche e religiose – ne sono
coinvolti. Tutti possono dunque diventare possibili attori o vittime
di atti terroristici o di attacchi bellici in relazione ad una
stessa causa scatenante. Tutti sono pertanto “direttamente interessati”
al dibattito pubblico mondiale.
Al proposito, vorrei però sottolineare un ulteriore aspetto, ovvero
come l’idea stessa di ragione pubblica e di politica sia cambiata,
proprio in relazione a ciò che è accaduto e al coinvolgimento
di una diversificata sfera pubblica mondiale, interessata a più
livelli all’evento. Per il ricercatore diventa allora necessario
elaborare nuovi strumenti concettuali e strategie analitiche per
comprendere più adeguatamente la nuova logica di un discorso politico
e pubblico di tipo “glocale”, proveniente sia dalle sfere istituzionali,
sia dal basso. Dobbiamo dunque individuare similitudini, differenze,
ma anche contaminazioni fra le diverse culture e le contrastanti
dialettiche argomentative.
Dobbiamo tra l’altro rivedere i nostri stessi “pregiudizi culturali”,
come ad esempio il modo in cui dipingevamo il fondamentalismo
islamico, frutto di contraddittori processi di decolonizzazione,
della definizione bipolare dell’ordine del mondo e della sua successiva
deflagrazione. È infatti un fenomeno post-moderno che col medioevo
ha ben poco a che fare. Nonostante le apparenze, ha infatti assorbito
concetti occidentali, fra cui l’idea di individuo e di razionalità
strategica. Si pensi alla disponibilità e all’abilità nel fare
gli investimenti di borsa, per finanziare atti terroristici. Si
guardi all’attacco alle torri: i kamikaze erano giovani che avevano
fruito di una buona educazione tecnica e avevano assunto abitudini
di vita americane, avendo lì abitato per anni. E pur tuttavia
questa “integrazione” era finalizzata alla sua stessa distruzione:
offrire da martiri la propria vita in nome di Allah, pensando
di avere in cambio la felicità nell’aldilà. Si pensi inoltre alla
connessione fra la perizia di volo e l’abilità nell’usare apribottiglie
per minacciare e sgozzare i piloti, prendendone il posto. E pur
tuttavia i registi del terrore sembrano interpretare “sentimenti
di base”. Viceversa, non potremmo capire ciò che intendeva dire
quel giornalista pakistano (uno dei pochi che aveva intervistato
Usman Bin Laden), quando all’intervistatrice occidentale aveva
risposto che non vi era nulla da meravigliarsi se Bin Laden era
diventato un eroe per molti islamici: rappresentava i loro sentimenti
di opposizione contro gli Stati Uniti che continuano a imporre
i loro modi di vita, e che nello stesso tempo non sono intervenuti
per difendere dalla morte molti loro correligionari, a partire
dai palestinesi.
Indubbiamente i poteri forti (intelligence bellica e finanza)
hanno ritrovato una loro legittimazione politica nell’attacco
militare, concepito come necessaria azione di risposta ad una
violenza subita, cancellando con ciò ogni differenza. In questo
rinato clima di tensione e confusione, cosa possono fare i ricercatori?
Possono contribuire a far meglio comprendere la situazione presente,
a patto però che affinino il proprio bagaglio analitico e concettuale,
accomiatandosi da precedenti luoghi comuni ideologici. Oltre alle
nuove logiche del terrore (in Italia sappiamo però che si può
vivere la normalità anche in situazioni di “leggi eccezionali”),
bisogna saper decifrare meglio i messaggi del dissenso, contenute
nelle nuove identità collettive, tanto in Occidente, quanto in
Oriente. La forza non può coprire l’opposizione. In senso pragmatico,
significa usare i proprie expertise per offrire nuovi strumenti
d’analisi ad una società modificata, sviluppare ricerche “cross-borders”
e concepire la cooperazione internazionale non solo in termini
economici, bensì come finalizzata allo sviluppo delle capacità
umane, fondato sul rispetto dell’integrità psicofisica della persona.
I diritti umani non sono solo da intendersi come la carta votata
nel 1948 all’Onu; non sono solo un prodotto occidentale, voluto
da Paesi vincitori. Nascono piuttosto come pretesa di giustizia
dall’esperienza della violenza, dalla necessità di darsi procedure
democratiche per evitare l’arbitrio. Ma tale interesse inizia
là dove si lavora: nella ricerca e nel confronto con gli studenti,
che – come dimostrano molte indagini recenti – riescono sempre
meno ad individuare un piano di formazione per la propria vita,
in altre parole a concepire l’idea stessa di futuro e avere desideri
di trasformazione sociale. La ragione pubblica nasce infatti dagli
ambiti concreti della vita quotidiana, dal confronto fra le differenze
e dalla prospezione di un diverso futuro: solo allora si potranno
individuare gli spiragli per una democrazia cosmopolitica.
*Docente di Filosofia Politica e Sociale, Università degli Studi
di Milano-Bicocca

Saper distinguere
Luciano Canfora*
L’idea che avete avuto mi sembra molto utile, oltre che non ovvia..
Mi chiedete di riflettere sull’utilità della disciplina
che pratico (la filologia) rispetto allo “sconcerto” che è calato
su tutti in conseguenza dell’ultima crisi. Può giovare quella
pratica disciplinare? Credo di si, nonostante la Filologia sia
considerata abitualmente disciplina remota e addirittura a-politica.
La brevità è d’obbligo, e sarò telegrafico. Dico spesso
ai miei studenti che uno degli usi della filologia è la capacità
di leggere criticamente un giornale, di porsi sempre il problema:
chi ha dato notizia e perché? Su quale fondamento? Quanta parte
di essa è determinata dal luogo in cui essa appare? Il principale
esercizio critico per non essere travolti e ridotti ad automi
è saper distinguere tra notizia, propaganda, manipolazione, invenzione.
Imparare ad ogni passo a distinguere il fatto dal racconto del
fatto. Questa aiuta a tenere fredda la mente, a non diventare
cittadini-oggetti.
* Filologo

Non dimentichiamoci
dei “diritti umani”
Paola Cavalieri*
Di fronte ai fatti terribili che hanno sconvolto New York, dopo
la naturale reazione emotiva di rabbia, di pietà per le vittime
e di ansia di fronte al crollo di una visione del mondo, possiamo,
io credo, fare appello alla ragione nelle sue varie forme.
Come ragione teoretica, essa può ovviamente aiutarci a comprendere
quanto è accaduto. Può per esempio farci capire che, al di là
del loro impatto emotivo, il generico riferimento al "terrorismo"
e la tesi di una contrapposizione tra civiltà sono spiegazioni
insoddisfacenti: il primo perché vacuo, in quanto il concetto
di terrorismo, come quello di guerra, si riferisce ai mezzi usati,
e non dice nulla sugli agenti e sugli scopi; e il secondo perché
tautologico, in quanto, invece di spiegarli, si limita a riproporre
i fatti. In questa luce, un'interpretazione che appare assai plausibile,
in quanto sembra rendere razionalmente conto degli avvenimenti,
è la tesi di Eric Hobsbawm secondo cui dietro l'attentato alle
Twin Towers si celerebbe non un generico odio contro l'Occidente,
ma il concreto obiettivo di un'organizzazione clandestina di destabilizzare
gli attuali equilibri di potere nelle aree petrolifere a controllo
islamico, a vantaggio dei paesi e dei gruppi di potere legati
all'integralismo religioso. Questa operazione farebbe leva da
un lato sul malcontento e sul sentimento panarabo di vaste aree
di popolazione musulmana sfruttate tanto dal predominio occidentale
quanto dalle proprie classi dirigenti, e dall'altro sulla possibilità
che la reazione americana abbia un effetto deflagrante per i regimi
cosiddetti "moderati".
Se questa ipotesi ha senso, quello che suggerisce la ragione pratica
di tipo prudenziale, cioè finalizzata al raggiungimento dei propri
obiettivi, sembra essere di non compiere gesti che offrano ai
movimenti integralisti dei singoli stati musulmani un'occasione
per costringere i propri regimi a sottrarsi all'attuale rete di
alleanze, o addirittura per rovesciarli, e di programmare nel
contempo politiche economiche atte a migliorare il tenore di vita
delle classi più diseredate, cominciando così a correggere quella
pratica di "scambio ineguale" che costituisce un fattore
di povertà per gli stati del terzo mondo.
Quanto all'aspetto forse più importante, ossia a quella ragione
pratica di tipo morale che mira ad implementare principi di giustizia,
si può dire che esso rappresenti anche il punto più difficile,
perché notoriamente l'ambito della politica estera è più refrattario
della sfera istituzionale interna all'influenza di vincoli di
carattere etico. E tuttavia, sembra che, se si vuole andare oltre
ad una forma - in parte problematica - di giustizia retributiva,
ci sia qualcosa che deve essere tenuto fermamente presente. Si
tratta di quell'insieme di principi che costituiscono la massima
acquisizione etica della civiltà laica sviluppatasi in alcune
specifiche aree del mondo, e che si raccolgono nella dottrina
universale dei diritti umani - una dottrina così potente da contenere
in sé, come ho sostenuto altrove, la possibilità di un'estensione
ad individui non-umani.
In questo caso, tenere presente i diritti umani vuol dire per
lo meno due cose. In primo luogo, per quel che riguarda i mezzi
utilizzati - dato che le fonti ufficiali da cui possono provenire
violazioni dei diritti umani non sono solo regimi e governi, ma
anche istituzioni come gli eserciti - significa non violare direttamente
tali diritti, colpendo popolazione innocente. In secondo luogo,
per quel che riguarda i fini perseguiti - sulla base dell'idea
rawlsiana che una delle funzioni dei diritti umani consista proprio
nel determinare i limiti della sovranità statuale - significa
favorire per quanto è possibile la sostituzione di regimi antiegalitaristici
e discriminatori (si pensi al trattamento delle donne in Afghanistan)
con sistemi istituzionali egalitaristici ed equi. E ciò perché,
come ha giustamente sottolineato Alain Finkielkraut, l'idea occidentale
che il benessere, la libertà e la vita di ogni individuo abbiano
lo stesso valore e debbano essere egualmente garantiti, non può
rimanere una prerogativa dell'Occidente.
* Eticista

Bastava seguire
l’odore dei soldi
di Giulietto Chiesa *
Quello che sta succedendo cambierà radicalmente anche il modo
di fare giornalismo. Tutti i giornalisti e gli operatori dell’informazione
dovranno elevare molto il livello della loro capacità critica
e autocritica ed evitare di farsi prendere in giro dalle “bugie
di guerra”. Ci saranno meno informazioni e dunque i giornalisti
dovranno essere più corrivi e capaci di aggredire il potere, come
per esempio hanno dimostrato di essere in Unione Sovietica, quando
il potere non dava o riduceva al minimo informazioni e notizie
su quello che stava facendo. Infine, e ci tengo molto a dirlo,
i giornalisti dovrebbero riscoprire l’elemento etico della loro
professione: gli imbecilli – di tutte le etnie, religioni e latitudini
– prosperano anche e soprattutto sulla base delle notizie “false
e tendenziose” che verranno loro distribuite. Sarebbe importante
cercare di spezzare questa catena.
Quello che è successo non è qualcosa d’altro o di diverso da noi,
ma un pezzo del nostro mondo che è impazzito. Vorrei dire tre
cose. La prima è che è “nel nostro mondo” che vivono i terroristi,
uomini disposti a tutto e con una terrificante voglia di disciplina
e di fanatismo, ma che sono uomini molto più “occidentali” e “occidentalizzati”
di quanto pensiamo. La seconda è che noi occidentali abbiamo costruito
un mondo troppo diseguale per poter vivere in pace. L’Occidente
ha cercato di imporre il suo marchio di fabbrica a tutto il mondo
e gli Stati uniti in particolare si sono convinti di poter imporre
il loro modello all’intera umanità, come se stesse per nascere
un “secolo americano”. Che totale follia. Come può pensare 1/6
del pianeta di poter imporre la sua volontà a tutto il mondo?
La terza cosa che voglio dire è che se è vero che tutta la gioventù
del mondo vorrebbe vivere a New York, cosa succederà se le genti
del mondo non possono o non vogliono vivere come a New York?
Come è possibile, ad esempio, cercare di occidentalizzare la Cina,
un miliardo e mezzo di persone, da parte di un mondo occidentale
che non arriva a 800 milioni? Come si può pretendere tanto?
È vero, il fondamentalismo islamico è stato usato dagli Usa per
abbattere l’Urss, ma è molto più antico dell’America e dello stesso
Occidente. Del resto, è tutto l’Islam che, inferiore per tecnologia,
è di certo più profondo e più radicato per pensiero e per cultura
del nostro mondo. In ogni caso, la tesi dello scontro di civiltà
è grave e pericolosa: decisivo sarebbe invece riconoscere la pluralità
del mondo, la sua diversità attraverso rapporti internazionali
giuridicamente regolati con leggi che valgono per tutti e non
attraverso la legge del più forte, come pretendono gli Usa. La
comunità internazionale ha invece a disposizione poteri deboli
e risibili, come si vede dal silenzio dell’Onu.
In Afghanistan, dove ora sto per tornare, sono stato l’ultima
volta in febbraio-marzo ed ho avuto la netta sensazione
che il regime dei Talebani fosse in grave difficoltà. Prima di
allora c’ero stato nel 1996 e la cosa che mi aveva impressionato
di più era proprio questa: il Paese viveva nelle stesse, misere
e terribili, condizioni nelle quali lo avevo lasciato, un Paese
dunque raso al suolo sia dal punto di vista morale che materiale.
Il consenso per il regime dei Talebani è via via scemato, anche
i rapporti con il Pakistan si erano deteriorati da tempo, quelli
con gli americani erano già interrotti. Inoltre, la resistenza
dell’Alleanza del Nord, guidata da Massud, si faceva via via più
insidiosa. Ma una cosa deve essere chiara: il regime dei Talebani
non si sarebbe potuto mai insediare se dietro di loro non ci fossero
stati i pakistani con le loro armi e i loro servizi segreti e
dietro ancora una formidabile serie di interessi strategici degli
Stati Uniti. Tra questi, il principale era senz’altro quello di
tagliare fuori la Russia dal grande serbatoio di petrolio del
Mar Caspio seguendo un canale che, appunto, tagliando fuori i
russi, favorisse afgani e pakistani. Interesse primario di due
delle grandi “sette sorelle” del petrolio, la Delta Oil (arabo-saudita)
e la Uno Call (interamente Usa). Dell’oleodotto – dal costo di
due miliardi e mezzo di dollari – fu iniziata la costruzione,
con il consenso dei Paesi citati prima nonché del Turkmenistan,
visto che doveva passare anche sul suo, di territorio, per arrivare
poi in Afghanistan, vicino Erat, e scendere poi giù in Pakistan
per sbucare nel Golfo Persico. Ma i talebani non sono riusciti
a tenere sotto controllo tutto il loro territorio e così l’affare
è sfumato. Inoltre, vi è tutta la questione – che descrivo con
dovizia di particolari nel mio libro “Afghanistan anno zero” –
dei proventi del traffico di droga, consistenti in circa 250 tonnellate
l’anno di oppio che è stato coltivato in territorio afgano prima
dai muhaijddin e poi dai talibani, con gravissime responsabilità
dell’agenzia Onu sui narcotici, diretta da Pino Arlacchi, che
ha finanziato il commercio dell’oppio. Vi sono prove inconfutabili
di questi traffici, come pure del riciclaggio dei proventi del
traffico di droga e di armi transitato per l’Afghanistan per un
valore stimabile in 10 miliardi di dollari, come spiega in uno
studio fondamentale, “Talebani, il grande gioco”, l’analista pakistano
Abdul Rashid.
Il Pakistan è senz’altro, punto di passaggio di soldi, armi e
droga che transitano in Afghanistan, e il gioco è condotto
in particolare dal servizio segreto pakistano, e poi naturalmente
gli Usa. Ma vi è anche un’altra fondamentale e importantissima
responsabilità, quella delle banche – svizzere, di altri Paesi
europei, anche italiane, e americane – che permettono la circolazione
di 10 miliardi di dollari l’anno i quali poi finiscono nelle varie
società off shore. Del resto, è accertato che su un volume di
scambi generale che supera i mille miliardi di dollari, 60/70
miliardi di dollari sfuggono ad ogni controllo. Si tratta dei
soldi della droga e delle armi e del loro riciclaggio, che avviene
nelle principali e più importanti banche d’affari del mondo. Basta
seguire i soldi, il loro odore, e si risale ai criminali.
*giornalista

Non deve vincere
la cultura del sospetto
Innocenzo Cipolletta*
Lo sviluppo dell’economia moderna, quella che viene definita nuova
economia, ed i processi della cosiddetta globalizzazione, hanno
tra i loro fondamenti la libertà di comportamento e la fiducia
reciproca. Non si sarebbe potuto immaginare uno sviluppo così
forte della nuova tecnologia, una sua rapida diffusione e una
crescita di reddito così importante se il mondo non avesse progredito
sulla strada delle libertà (civili ed economiche) e se non si
fosse allargata l’area della fiducia che nel mondo coinvolge
ormai oltre un miliardo di persone.
Gli atti di terrorismo dell’11 settembre negli USA sono diretti
anche contro questa esplosione di libertà, malgrado essi siano
stati possibili proprio grazie ad essa. Questa apparente contraddizione
è insita nelle società che si aprono: l’ampliarsi delle libertà
aumenta il rischio di azioni da parte di chi opera contro di esse.
Il prodursi di tale rischio genera spesso un ritorno verso una
maggiore chiusura e verso una atmosfera di sospetto reciproco
che produce processi di involuzione. Quando ciò avviene, allora
si può dire che il terrorismo ha effettivamente riportato una
vittoria, ancorché parziale e temporanea, perché ha intaccato
il modello di vita contro cui combatte e lo ha avvicinato a se
stesso.
In una certa misura è inevitabile che ciò avvenga, ma è bene aver
sempre a mente il rischio di involuzione per evitare l’instaurarsi
di un circolo vizioso che ci potrebbe far regredire nella vita
democratica. Per questo occorre ricorrere con precauzione a misure
che limitano le libertà. Prendiamo un caso secondario, quello
del divieto di avere rapporti economici e finanziari con persone
e società sospettate di avere relazioni con il terrorismo mondiale,
divieto a cui hanno aderito la maggior parte dei paesi. La misura
è condivisibile nei sui obiettivi, ma la sua applicazione anche
nei casi di operazioni lecite e senza alcuna conoscenza dei rapporti
con persone indagate, sarà difficile e, se protratta nel tempo,
potrà essere fonte di distorsioni, ingiustizie e soprusi, venendo
così a generare una società del sospetto. Infatti, se oggi può
essere relativamente agevole indicare un numero limitato di persone
e società da mettere al bando, sarà comunque difficile individuare
anche tutte le attività collegate ad esse che si camuffano in
vario modo. Poi ne nasceranno altre che cercheranno in tutti i
modi di nascondersi, sicché è da ritenere che si dovrà mettere
in azione una sorta di polizia mondiale volta a selezionare i
flussi finanziari e ad indagare sulle diverse attività. Poiché
l’esigenza di sicurezza farà premio su tutto, è da ritenere che
saranno sufficienti pochi sospetti per far entrare questa o quella
attività nelle liste di proscrizione. E chi potrà mai escludere
episodi di calunnia a scopo di falsare la concorrenza? In epoca
di guerra fredda non sono state poche le aziende accusate di aver
venduto prodotti o servizi strategicamente sensibili ad aziende
di paesi dell’altra parte della cortina di ferro, che hanno subito
ritorsioni economiche più o meno giustificate.
Questo esempio, come quelli relativi a tante altre procedure di
controllo e di restrizione, può apparire secondario a fronte dell’efferatezza
dei terroristi, dell’enormità del loro atto e delle reazioni belliche
che rischiano di prodursi. Ma di esempi di questo genere se ne
possono fare diversi fino a comprendere molte delle attività umane.
La vita di milioni di cittadini del mondo libero è fatta anche
di quotidiane piccole azioni che vengono svolte sulla base delle
abitudini e della fiducia reciproca: mettere dei filtri a queste
azioni, instaurare un clima di sospetto e di sfiducia reciproca
vuol dire minare alle basi le nostre democrazie.
Ecco perché occorre fare attenzione, nella lotta al terrorismo,
a non sacrificare anche le fondamenta del nostro vivere civile,
consapevoli che le nostre libertà comportano anche il rischio
che qualcuno si approfitti di esse. È un rischio che abbiamo saputo
correre fino all’11 settembre scorso e che oggi ci appare enorme
a fronte dell’eccidio commesso. Ma v’è da augurarsi che anche
nel futuro sapremo correre tali rischi, magari riducendone la
portata con lo sviluppo economico e civile diffuso e rivalutando
la globalizzazione che, se riduce le differenze tra le diverse
culture come qualcuno teme, consente anche di diffondere le libertà
individuali fondamentali per l'umanità.
*Dirigente Marzotto

La ferita
della Palestina
Napoleone Colajanni*
Anche se largamente usato rimane sempre valido il richiamo che
l’emozione non deve far passare in secondo piano il ragionamento.
Più che mai in una situazione come l’attuale in cui l’emozione
è grande per un evento assai più coinvolgente, grazie ai mezzi
di comunicazione, di quanto non fosse l’assassinio di Serajevo
che diede il pretesto per la prima guerra mondiale. Ragionare
significa riconoscere che il terrorismo può davvero diventare
il nemico più pericoloso del mondo occidentale, e proprio per
questo occorre riflettere su due questioni: come è nato e come
è possibile combatterlo, con la seconda questione che dipende
dalla risposta che si dà alla prima.
Nel terrorismo o meglio nel terrorista c’è una certa componente
psicologica o persino caratteriale, ma questa può spiegare soltanto
il comportamento degli individui. Nella storia, quando ha avuto
un peso reale, il terrorismo ha avuto sempre un retroterra ideale,
una ideologia, come complesso di argomenti per legittimare la
propria posizione. Gli anarchici dell’Ottocento credevano che
uccidendo i re e le imperatrici si potesse arrivare alla distruzione
dello Stato, concezione ingenua derivata dall’incapacità a comprendere
la natura dello Stato moderno. Oggi il retroterra più forte del
terrorismo è il nazionalismo, collegato il più delle volte a condizioni
di vita inferiori rispetto alle nazioni dominanti, e rafforzato
spesso, ma non sempre, dalla componente religiosa. Nell’Irlanda
del Nord questo avviene, diversamente dalle province basche dove
aggrediti ed aggressori sono tutti e due buoni cattolici. Di passata,
potrò essere stato disattento, non ho mai sentito Papa Woitila,
condannare apertamente i cattolici irlandesi o baschi. Naturalmente
ci sono religioni che contengono una spinta al sacrificio individuale
molto più grande di quanto non sia in altre, e questo è il caso
dell’Islam, non esplicitamente, ma consentendo interpretazioni
che vanno in questo senso. Si può capire che in questo modo nascono
i kamikaze.
Il terrorismo di oggi è ben diverso da quello anarchico è la conseguenza
storica dell’imperialismo, di quell’espansionismo militare, economico,
culturale, che per due secoli ha caratterizzato la posizione dell’occidente
verso altri popoli, cercando di subordinarli, e le cui conseguenze
durano tuttora. Espansionismo che diventava tanto più oppressivo
quanto più elevato era il livello di civiltà e di cultura dei
popoli che investiva. Tre aree avevano cultura e civiltà originali,
e quindi hanno resistito maggiormente: la Cina, l’India, il mondo
arabo. Una quarta, il Giappone, ha scelto autonomamente, con la
rivoluzione Meiji, di assimilarsi al mondo occidentale e mettersi
in concorrenza con esso. La pratica distruzione di altri popoli,
come gli indiani dell’America del Nord e del Sud e degli aborigeni
australiani, il caos che regna tra i popoli africani, fanno parte
del quadro, ma proprio la mancanza di una civiltà e di una cultura
sufficientemente articolate di questi popoli non ha permesso loro
di resistere.
Con le tre grandi aree non è stato così. Ma due di esse, la Cina
e l’India hanno trovato in sé la strada per la propria emancipazione,
l’India, pur lacerata al suo interno da profonde contraddizioni,
ha raggiunto l’indipendenza con una ideologia geniale e originale,
quella del Mahatma Gandhi, la Cina con la lotta armata contro
le appendici dell’occidente nel proprio territorio. Il mondo arabo
resta invece ancora subalterno, diviso, con alcuni regimi che
non possono seriamente essere definiti indipendenti, incerto sulla
strada da percorrere, e con una ferita ancora aperta come quella
della Palestina. È questa e non l’Islam la motivazione della contrapposizione
col mondo occidentale, che trova il suo apice nell’avversione
verso gli Stati Unità, considerati giustamente come la punta di
diamante dell’occidente. Certo l’Islam è stato un veicolo per
diffondere certe concezioni fuori dal mondo arabo, in Iran o in
Afghanistan, ma sarebbe profondamente errato interpretare la crisi
come risultato di una contrapposizione tra l’islam e l’occidente.
Le basi della contrapposizione sono storiche e politiche e ciò
porta fra l’altro a giudicare interessanti dal punto di vista
teologico, ma sprovvisti di significato politico e di conseguenze
pratiche gli attestati che alla religione islamica vengono rilasciati
da molti, compreso Giovanni Paolo II. Che poi la religione islamica
consenta un’interpretazione che possa portare all’autodistruzione
è un’altra questione, non è il centro del problema, fornisce un’arma
ad una lotta che ha altre radici.
Come combattere allora il terrorismo? I mezzi militari sono efficaci
solo in piccola parte, si può fare dell’Afghanistan una terra
bruciata, ma il terrorismo risorgerebbe, perché non mancherebbero
né i nuovi Bin Laden né i nuovi kamikaze. La sicurezza all’interno
dei paesi occidentali va certamente rafforzata, ma bisogna trovare
un equilibrio con i diritti di libertà. Colpire nell’immediato
ed affidarsi ai tempi lunghi della globalizzazione è illusorio.
Puntare sulla globalizzazione per esportare un modello di civiltà
è impossibile, sarebbe in pratica una edizione aggiornata dell’imperialismo
ottocentesco, col suo «white man’s burden». La globalizzazione
può avere un impatto positivo in quanto facilita lo sviluppo economico,
ma non è una risposta alle esigenze di popoli che hanno una propria
civiltà. Sbagliano profondamente ad esempio quanto ritengono che
la Cina possa venire assimilata al modello capitalistico per il
fatto che si diffondono le musiche, i balli, e gli abbigliamenti
occidentali, e ciò vale anche per un mondo come quello arabo che
pure è stato più lungo di quello cinese a contatto con l’occidente,
ma ne ha ricavato solo umiliazioni e frustrazione.
La risposta può essere quindi solo politica. Nessuno può farsi
illusioni che si possano avere risultati a breve tempo, come del
resto non può portarli nemmeno l’azione militare. Nei confronti
del mondo arabo l’Europa non è mai andata oltre le belle parole
e i segnali di fumo. La risposta politica degli Stati Uniti,
dopo che nel 1956 con l’impresa di Suez l’Europa fu estromessa
dall’area si è fondata su tre punti: azioni mirate di rappresaglia,
qualche volta fallimentari (si ricordi il tentativo di uccidere
Gheddafi o l’attacco ad una fabbrica di farmaceutici di Khartum
scambiata per officina dei veleni); un sostegno ai regimi arabi
moderati; difesa ad oltranza di Israele come punto di appoggio
di tutta una politica. Tutti debbono rendersi conto oggi che questo
tipo di risposta è inadeguato, anzi può aggravare la situazione,
in primo luogo perché si tratta di una strategia che tiene conto
soltanto dei gruppi dirigenti e ignora il sentimento dei popoli.
Quel che è necessario è un radicale rovesciamento della politica,
a cominciare dalla Palestina, che deve necessariamente comportare
tempi non brevi se vuole raggiungere il consenso interno.
Il compito ricade interamente sugli Stati Uniti e sulla sua classe
dirigente. Gli alleati possono fare ben poco, a parte qualche
invio di unità speciali nell’immediato; passato il momento della
solidarietà si renderanno conto, tranne naturalmente il Regno
Unito, della complessità della situazione e prevarrà la voglia
di non correre avventure. L’ondata bellicista che all’interno
degli Stati Uniti attualmente chiede vendetta è perfettamente
comprensibile e nessun governo può prenderla sottogamba, ma prima
o dopo finirà per illanguidirsi. La preoccupazione maggiore è
quella che viene dagli orientamenti della classe dirigente americana,
che non appare unita. Quando il segretario alla difesa Donald
Rumsfeld parla di bombe atomiche o di coinvolgere altri paesi
non si rende conto di andare contro gli interessi del suo stesso
paese a cui oggi si richiedono calma a consapevolezza. Altri,
come il segretario di Stato Colin Powell sembrano averlo capito.
È vero che gli europei non possono far nulla, ma solo dicendo
apertamente quel che pensano possono dare un aiuto a quelli che
vogliono avere dei risultati, perché i falchi non possono risolvere
niente, possono solo prolungare ed aggravare il conflitto.
*Economista

Rimettiamoci
a pensare
Fausto Colombo*
Ci sono almeno due ordini di motivi per cui - per uno studioso
di media come me - la tragedia dell'11 settembre cambia radicalmente
le cose.
Il primo riguarda quello che definirei il paesaggio quotidiano.
Che è mutato radicalmente ma in una forma particolare,
dolorosa e lancinante. Perché - come ha ricordato in un
suo recentissimo intervento Alberto Abruzzese - nulla di ciò
che è accaduto può dirsi completamente nuovo dal
punto di vista mediatico. Le immagini che abbiamo visto in televisione
erano già state messe in scena dal cinema in mille film
catastrofisti. Gli effetti sulla popolazione occidentale sono
descritti in una serie impressionante di volumi sulla propaganda.
Infine, la ripetizione ossessiva della morte in diretta e la mistificazione
della guerra televisiva hanno già trovato i loro cantori:
rispettivamente in Benjamin (e più tardi nell'analisi dell'oscenità
in Bazin) e nei molti analisti del rapporto fra media e conflitto
(non ultimo Baudrillard). Eppure molto era nuovo, e in particolare
la verità di quelle immagini, l'innegabile effettualità
che ci schiaffeggiava davanti ai nostri schermi. Quella verità
spostava per così dire di lato le nostre consapevolezze.
Il paesaggio familiare diventava perturbante, secondo un processo
già descritto da Freud più o meno un secolo fa.
Dunque il noto che si fa inquietante, angosciante, semplicemente
pericoloso. E di nuovo siamo in presenza di una storia già
raccontata da quel genere così radicato nella cultura moderna
dell'Occidente che è l'horror, lo spaventevole letterario.
Ecco, un andirivieni di riconoscimento e orrore ha colpito lo
studioso di media, con una oscillazione il cui periodo non si
abbrevia con il tempo: una oscillazione che continua e forse non
potrà più cessare, insieme alla vertigine che procura.
C'è poi un secondo ordine di motivi. Riguarda il ruolo
dello studioso. Ruolo che - per le scienze umane e la sociologia
in particolare - è stato passato al microscopio soprattutto
negli anni settanta, in quel movimento del pensiero francese che
da Foucault arriva a De Certeau. Il primo ha mostrato il radicamento
dello scienziato sociale nello stesso cuore della modernità,
del controllo, della disciplina, dell'articolazione misteriosa
ed efficace del potere. Il secondo ha radicalizzato il problema
dell'origine del discorso scientifico (storico in particolare).
Quella riflessione si è adagiata sul largo fiume del rispecchiamento
degli intellettuali, e non ha mai smesso di agitare i sonni di
noi tutti. Ora quelle questioni - mai sopite - tornano con la
stessa violenza degli aerei gettati contro i simboli della modernità.
Qual è il compito dell'intellettuale? Ci si chiede - come
a tutti i cittadini - di schierarci, di non fuggire o di non compiere
distinguo troppo sottili. E' tutto evidente, chiaro, persino cartesiano.
Ma io penso che la lezione di Foucault e De Certeau non possa
essere rimossa. Penso che il mestiere dell'intellettuale sia di
capire le radici dei fenomeni e di trasmetterle. Penso a "Farenheit
451" e agli uomini libro.
E immagino che quest'anno ai miei studenti spiegherò con
ancora maggiore precisione che il nostro è solo un mondo
possibile, abitato dai nostri sogni e dai nostri incubi. Ma che
la miscela può mutare. Loro sono giovani, tanto più
giovani di me. Hanno diritto di sapere e di lasciare la loro traccia.
La lasceranno se si interrogheranno sul loro ruolo, sulla complessità
della storia e sull'indicibilità del male. La lasceranno
soltanto se si ostineranno a essere intellettuali. Penso che la
semplicità dei fatti sia una mistificazione: dove appare
lampante bisogna indagare, scoprire, guardare un po' di traverso.
Questo farò, più di prima. Non è questione
di seminare dubbi, ma di fare come Tomasz ne "L'insostenibile
leggerezza dell'essere" di Kundera: è scappato dalla
Cecoslovacchia invasa dalle truppe sovietiche. Ma decide di tornare.
Un amico vuole farlo riflettere; fermarlo. Ma lui canticchia un'aria
celebre: "Es musst sein" così deve essere.
Così, io torno a pensare. Provate a fermarmi, se potete.
* docente di Teoria e Tecnica della comunicazione di massa all'Università
Cattolica di Milano e direttore dell'Osservatorio sulla Comunicazione.
Quale tolleranza?
Raimondo Cubeddu*
Si discuterà a lungo, come l’immane tragedia americana richiede,
sui sistemi di sicurezza anti-terrorismo, sulla loro efficacia,
sul fatto che la minaccia tante volte denunciata sia stata inspiegabilmente
sottovalutata. Non ci sono cascati addosso soltanto macerie e
morti, ma anche l’illusione di poter vivere in condizioni di sicurezza,
ed affidandoci alla tecnologia, in quella parte del mondo aperta
alla convivenza di etnie, di religioni e di civiltà, ma circondata
da un universo di povertà, di intolleranza e di fanatismo religioso.
Difficile prevedere quali conseguenze tutto ciò potrà avere, anzitutto
per quella tendenza, apparentemente inarrestabile, alla concentrazione
della popolazione nelle grandi città.
È stato detto, e forse giustamente, che una fase della nostra
civiltà è terminata con i tragici fatti di questi giorni. Ma proprio
in questo momento bisogna difenderne e riaffermarne con vigore
i valori fondamentali, e rivedere quella sorta di eccessiva tolleranza
per gli intolleranti che da qualche decennio si era impadronita
della civiltà occidentale in preda, per alcuni, all’edonismo,
al nichilismo ed al relativismo. Una tolleranza può aver favorito
la credenza nella nostra debolezza politica e morale.
Di fronte a tutto ciò l’errore maggiore è quello di trasformare
un conflitto tra civiltà in un conflitto tra religioni. È indubbiamente
vero che quella globalizzazione che ha dissolto gli stati nazionali
in un’unica civiltà composta da una pluralità di culture, di etnie
e di fedi religiose ha riproposto il tema degli esiti distruttivi
che i conflitti confessionali avevano negli stati nazionali. E
se si potesse osservare, forse anche giustamente, che dei conflitti
a sfondo religioso se ne ha ormai abbastanza, non meno vistoso
è il fallimento 1) della credenza che il mondo si avviasse pacificamente
ad una forma di governo cosmopolitico fondato su quei valori e
diritti che noi ritenevamo universali e che invece sono soltanto
occidentali; e, 2) della teoria che la paura della morte violenta
(Hobbes) o della fame (Locke) avrebbero indotto gli uomini a comportarsi
in maniera più civile e ad uscire dallo stato di guerra di tutti
contro tutti. Questa, purtroppo, era soltanto la nostra esperienza
storica, non la tendenza di un’inesistente “storia universale”.
Forse ancor più difficile sarà accettare le limitazioni alle libertà
individuali e allo “stato di diritto” che si renderanno necessarie
in uno “stato di guerra” contro un nemico spietato ed imprevedibile
quale il terrorismo. Ed è per questo che bisogna aver fin da ora
chiaro che le eventuali restrizioni delle libertà individuali
dovranno essere temporanee. Se guerra sarà, sarà per difendere
la libertà dai violenti, e non per ridurla ulteriormente o definitivamente.
Nel difendere una civiltà che con tutti i suoi limiti ha voluto
e saputo distinguere la sfera della convivenza civile dalla sfera
della religione (la filosofia politica dalla teologia politica),
tale distinzione, nonostante le palesi difficoltà, deve essere
tenuta viva. Ciò che significa anche riconoscere che il modello
di mercato globalizzato è stato vittima del proprio successo.
Ha prodotto sia una serie infinita di aspettative individuali
e sociali che solo parzialmente poteva soddisfare nei tempi attesi;
sia la consapevolezza che la sua adozione avrebbe prodotto la
distruzione di culture, civiltà e religioni. In altre parole un
misto di attrazione e di odio del quale oggi vediamo prevalere
il momento dell’odio. È indubbiamente vero che tutto ciò è stato
anche favorito dalla credenza che si potesse esportare il modello
di vita e di diritti umani della civiltà occidentale senza traumi
e senza che le altre civiltà elaborassero adeguati modelli istituzionali
e di comportamento economici. Ma è anche vero che siamo stati
dei grandi ingenui nel pensare che tutto ciò non avrebbe prodotto
delle violente crisi di rigetto.
La nostra forza non deve consistere nell’imposizione al mondo
di un modello la cui civiltà si identifica con la propria religione,
ma di un modello che ha accumulato una certa esperienza nel consentire
la convivenza di libertà, di civiltà e di religioni.
*Ordinario di Filosofia Politica all’Università di Pisa

Dobbiamo studiare
l’arabo
Giuseppe De Rita*
È davvero un evento che cambia il mondo quanto è accaduto a New
York l’11 settembre scorso? Secondo me, per quanto odiosa possa
sembrare questa affermazione, si tratta invece di un evento che
certifica un cambiamento già in atto. Il mondo ha ormai da molti
anni un assetto policentrico. È proprio questo policentrismo che
riduce il potere del cuore del sistema, rendendolo meno importante
e quindi più attaccabile. Senza che ciò comporti tuttavia una
modifica del sistema stesso. Quello che appare più comunemente
ai nostri occhi è una concezione monarchica del sistema: leggiamo
con questa chiave la globalizzazione o il potere finanziario simboleggiato
da Wall Street. Se accettiamo che ci sia un assetto monarchico,
allora dobbiamo pensare che ci sia un cuore rappresentato da un
re o dalla potenza militare o da due torri. È difficile accettare
questo paragone ma è un po’ come quando le nostre Brigate Rosse
rapirono Moro nel ’78. Lo fecero per colpire al cuore il sistema,
convinti che in questo modo sarebbero riusciti a disintegrarlo.
Con lo stesso intento oggi i terroristi hanno attaccato il cuore
dell’America. Eppure io resto convinto di una cosa che già scrissi
nel rapporto Censis del ’78: il sistema non ha un cuore unico.
Viviamo in un assetto di policentrismo reale come dimostrato anche
dal fatto che lo stesso processo di globalizzazione avviene per
diffusione e non per verticalizzazione. O dal fatto che bisogna
tener conto di nuove potenze nel sistema mondiale come l’India,
la Cina, l’Europa. Ci sono articolazioni dei poteri – espressione
questa che va usata al plurale - estremamente forti. Assistiamo
ad un marcato stop all’etnocentrismo americano ed europeo visto
che ormai dobbiamo tener conto delle altre culture, di quella
islamica o di quella cinese solo per fare due esempi. Voglio aggiungere
una considerazione pratica: oggi noi occidentali dobbiamo imparare
l’arabo mentre finora ci cullavamo nella certezza che tutti dovessero
imparare l’inglese: se un arabo conosce l’inglese e noi non conosciamo
l’arabo, lui è in grado di fare speculazioni finanziarie e azioni
terroristiche e noi non possiamo neanche fare le intercettazioni.
Viviamo insomma in un mondo che ha un assetto ad architettura
distribuita, per usare un termine informatico, e non monarchico.
Si tratta di un processo storico che durerà ancora almeno un trentennio,
nel corso del quale sarà sempre più ridimensionato il ruolo degli
Stati Uniti come superpotenza, superpoliziotto, superfinanziere.
Il periodo monarchico aveva per simbolo la bomba atomica, ma il
simbolo di questi anni è Internet che è appunto una rete.
Non fu facile convincere coloro che nel ‘78 parlavano di autunno
della Repubblica che il sistema reggeva nella quotidianità. Eppure
allora la sensazione di oppressione durante il rapimento di Aldo
Moro si avvertiva molto forte a Roma ma bastava allontanarsi di
qualche decina chilometri per tornare a vivere nella quotidianità.
Questo era possibile perché i poteri venivano ridistribuiti.
E questo è ancora possibile, se non ci si ferma al vivere le immagini
televisive e a verticalizzare le emozioni. La compresenza fra
policentrismo e quotidianità è l’unica arma che possiamo avere
contro l’aggressione al cuore del sistema, ed è anche ciò che
fa superare la nozione stessa di cuore del sistema.
*Presidente del Censis

È nato un
leader?
Ferdinando Fasce*
Parlare in una prospettiva un po’ più ampia della stretta cronaca,
di presidente, stile di leadership e capacità di governo dinanzi
a una tragedia così immane, per gli Stati Uniti e per quanti hanno
a cuore le sorti della democrazia e della libertà, come quella
del criminale assalto terrorista alle Twin Towers può sembrare
inopportuno. E può reinnescare la trita diatriba sull’ “antiamericanismo”,
tanto più popolare da noi quanto meno si conoscono gli Stati Uniti.
Poiché penso che il modo migliore di testimoniare la totale solidarietà
con il popolo americano e un sincero attaccamento al meglio della
formidabile tradizione culturale e politica d’oltre Atlantico
sia quello di guardare in faccia le cose, ritengo che sollevare
lo sguardo si imponga. Specie dinanzi alle reazioni, della stampa
e dei principali osservatori, d’oltre Atlantico e di casa nostra,
al discorso tenuto dal presidente George W. Bush giovedì 20 settembre
di fronte alle Camere congiunte. In quell’occasione, nel breve,
ma intenso e solenne, spazio di tempo di tale appello, Forrest
Gump, dicono le cronache, si è trasformato in un uomo di stato,
ha fatto volare la colonnina del gradimento al 91%, ha mostrato
di avere le doti di un Franklin Delano Roosevelt o di un Harry
Truman.
Dal punto di vista strettamente tecnico della performance retorica
presidenziale pare difficile dar torto allo storico della presidenza
Michael Beschloss che ha definito il discorso alle Camere da “10
e lode”.
Primo perché, vincendo le trappole della dislessia che secondo
alcuni studiosi lo affligge, Bush jr. è riuscito a leggere il
testo approntatogli da Condoleeza Rice, la consigliera alla sicurezza,
senza inciampi o cadute espositive.
Secondo perché il discorso confermava il commendevole sforzo,
già mostrato qualche giorno prima in occasione della visita alla
moschea, di correggere sensibilmente il tiro, rispetto alle prime
dichiarazioni sulle “crociate”, che avevano scatenato le giuste
recriminazioni dei musulmani (e di tutte le persone di buon senso),
dentro e fuori degli Stati Uniti.
Terzo perché, forse raccogliendo, sia pure molto parzialmente,
le indicazioni del grande esperto di studi strategici Michael
T. Klare, Bush ha definito in maniera più circoscritta che nelle
prime dichiarazioni la natura criminale della minaccia terrorista,
come Arthur Schlesinger jr. ha giustamente sottolineato.
Infine perché il discorso mostrava una risolutezza e autorevolezza
di toni ben lontane dallo smarrimento palesato dal presidente
nei primi giorni.
Tutto questo, però, non deve farci dimenticare che George W. Bush
non è e non è mai stato Forrest Gump, ma un uomo di punta dell’establishment
statunitense. Né può farci dimenticare la pervicacia con la quale
il presidente ha ripetuto per mesi una linea di politica estera
che ha spinto non qualche pericoloso e irriducibile “antiamericano”,
ma gli stessi osservatori d’oltre Atlantico oggi raccolti attorno
alla bandiera, a parlare, con preoccupazione, di un soprassalto
di “unilateralismo”. Sicché ha ragione il “Washington Post” a
notare che, se è vero che Bush pare diventato un leader nazionale,
non è ancora chiaro con quale indirizzo strategico e con quale
rapporto fra la nuova agenda che la storia gli ha imposto (superamento
dell’unilateralismo sul piano internazionale, misure parakeynesiane
su quello interno), le sue dichiarazioni programmatiche e la pratica
di governo esplicitamente conservatrice dei primi otto mesi.
È presto dunque per dire se dietro il leader capace di far suonare
le corde dell’emotività nazionale registrata dai sondaggi c’è
l’uomo di governo coerente in grado non solo di indicare obiettivi
concreti e ragionevoli (cosa sostanzialmente assente dal discorso
del 20 settembre), ma anche di fornire una visione del futuro
del paese e della sicurezza, civile e politica, dei suoi cittadini
meno miope di quella con la quale si è aperto, alla Casa Bianca,
il ventunesimo secolo.
* Professore associato di Storia e Istituzioni dell'America del
Nord nell'Università di Bologna.
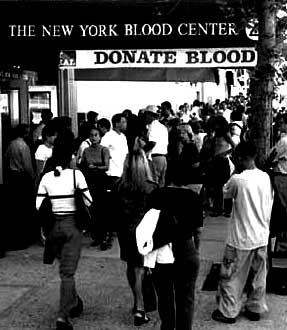
La giusta
proporzione
Alessandro Ferrara*
In questi giorni convulsi ne abbiamo sentite tante, di reazioni,
di sensazioni, di risposte "a caldo" che forse è bene
cominciare cercare di guardare più "a freddo" a ciò
che è successo l'11 settembre. Non credo che i saperi specialistici
di per sé diano risposte: ripasso mentalmente quelli per i quali
possiedo credenziali pubbliche ma non vi trovo risposte immediate,
solo spezzoni e spunti. Più che applicazione di un sapere, capire
quanto è avvenuto mi sembra piuttosto il lavoro del giudizio,
del bilanciare le tante cose singolarmente giuste dette da tanti.
Il difficile è dare loro "la giusta proporzione".
Soprattutto è il momento che ciascuno stia al suo posto. Gli intellettuali
non tentino di fare il mestiere dei politici. Mentre a questi
ultimi si chiedono (e giustamente) certezze, noi commerciamo in
dubbi e interrogazioni. Viviamo all'alba di un giorno di cui non
conosciamo che cosa porta in serbo a noi e ai nostri figli. Questo
sentimento non possiamo cancellarlo e il primo compito che ci
si impone è capire, non suonare il piffero per chicchessia.
L'11 di settembre l'America ha subito un attacco che per dimensioni,
effetto, implicazioni è un atto di guerra, forse il più terribile
della sua storia. Terribile. Perché nemmeno Hitler si sarebbe
mai potuto sognare di bombardare il Pentagono. Un atto che sconcerta
tutti noi occidentali - anche quelli che non amano i poteri simboleggiati
dal Wtc e dal Pentagono - perché l'oggetto dell'attacco va al
di là di quei simboli. È un attacco alla nostra forma di vita.
Credevamo di averle già viste tutte, quelle strane bestie di guerre
venute fuori dalla caduta del muro di Berlino. Ma non ci
sono solo le guerre etniche e le guerre "umanitarie".
Il nuovo secolo ci riserva anche le "guerre del terrore",
combattute da organizzazioni non statali contro stati. E chi dice
che non è guerra fa come Don Ferrante: non c'è uno stato dietro,
dunque non c'è guerra.
Secondo punto: se di guerra si è trattato, noi - noi Occidente,
noi Americani ed Europei insieme - abbiamo subito una prima sconfitta,
su cui occorre riflettere al più presto. E sui danni collaterali
di questa sconfitta è aperto l'inventario. Quel movimento per
una diversa globalizzazione che rappresentava un germoglio di
differenziazione nel mondo unipolare intanto è sparito dai giornali.
Quando si tratta della vita e della libertà, chi può preoccuparsi
più di tanto di MacDonald's e di come e dove la Nike produce le
sue scarpe da ginnastica? Questo schiacciamento al centro, tutti
dietro a Bush chissà fino a quando, nessuna altra priorità, sostenere
la Boeing e le borse in caduta libera che diventa un atto patriottico,
la Cia rilegittimata e a briglia sciolta come ai tempi d'oro,
questo è un conto separato che la sinistra ha con Bin Laden…
Come è stato possibile un attacco del genere? È stato reso possibile
dal fatto che forze ispirate dal fanatismo religioso hanno scoperto
di possedere un'arma letale, inaccessibile all'Occidente, contro
cui l'Occidente ha ben pochi rimedi, e rispetto alla quale i suoi
arsenali di aerei invisibili, sommergibili atomici, missili teleguidati,
bombe intelligenti, armi nucleari di teatro, e domani anche lo
scudo spaziale sono del tutto impotenti. E hanno usato quest'arma
in modo dimostrativo nel modo più eclatante possibile, a freddo,
una bella mattina di settembre, nel centro del financial district
di New York. Quest'arma è un'arma umana, non tecnologica. È l'utilizzazione
sistematica e razionale della disponibilità a morire, di una disponibilità
a morire che non proviene affatto dalla follia in senso clinico
ma si alimenta di fede religiosa e radici culturali e odio identitario.
La disponibilità al suicidio di cui parliamo non è frutto di uno
stato di esaltazione, il quale non può reggere per cinque anni.
Sono persone che hanno vissuto per anni all'interno della società
occidentale, amalgamandosi con la gente tanto da non farsi notare,
persone che hanno condotto una vita normale, sono andate al bar,
al cinema, hanno fatto vacanze e cercato distrazioni, ma in cinque
di contatto continuo con la società americana - non vivendo in
un bunker o subendo un lavaggio del cervello - non si sono lasciate
scalfire nel loro proposito. Purtroppo questa non è follia. E,
come ha coraggiosamente detto Susan Sonntag, non è neanche viltà,
perché non è vile chi muore deliberatamente per qualcosa, sbagliato
e aberrante per quanto sia agli occhi altrui questo qualcosa.
La conseguenza più difficile da metabolizzare è che non esiste
rimedio immediato, anticorpi atti a contrastare tutto questo,
e tanto meno un rimedio solo militare. Nel lungo periodo - e il
ventunesimo secolo è appena cominciato - il rimedio può solo venire
da una capacità di creare consenso. O cambiamo il terreno di coltura
su cui cresce questa mala pianta del terrorismo o loro cambieranno
la nostra società in una società blindata e paranoica. Una società
aperta e complessa come le nostre non può difendersi dalla minaccia
terroristica senza snaturarsi. La vita blindata che forse ci aspetta
per definizione va contro l'idea di una società aperta. Metal
detectors dappertutto, doppi e tripli controlli in aeroporto,
perquisizioni obbligatorie, tre ore di anticipo per prendere un
aereo, difficoltà nella mobilità geografica, guardie di frontiera
meticolose e feroci come i Vopos di Berlino Est, controllo delle
comunicazioni personali su vasta scala, schedature, presenza capillare
di forze di polizia antiterrorismo, forse anche leggi speciali
antiterrorismo, legittimazione della cultura del sospetto, tutto
questo significa cambiare la qualità della nostra vita per come
abbiamo imparato ad apprezzarla. E ancora non ci mette al riparo
dal gesto di chi è disposto a suicidarsi.
L'unico vero rimedio di lungo periodo è quello di tagliare le
fonti di approvvigionamento umano ai terroristi. Impedire cioè
quantomeno che i terroristi attraggano consensi non solo tra le
file del fondamentalismo islamico, come già purtroppo è inevitabile
che accada, ma che comincino ad attrarli anche tra i mussulmani
moderati, poi magari tra i mussulmani non arabi e poi al limite
tra i diseredati della terra neppure mussulmani. Noi in Italia
abbiamo vinto la lotta contro un terrorismo che su scala ridotta,
nazionale, era riuscito a produrre uno stesso senso di totale
sconcerto con il rapimento di Aldo Moro. Non abbiamo vinto quel
terrorismo mettendo un poliziotto ad ogni angolo di strada. Lo
abbiamo vinto quando quelli che pensavano alle Brigate Rosse come
a "compagni che sbagliano" hanno cominciato a non pensarla
più così.
Su scala globale questo richiede che si disinneschi quel generatore
di frustrazione politica, rappresentato dal conflitto arabo-israeliano,
il quale rende esplosiva la miscela di odio antioccidentale e
diponibilità a immolarsi. La difesa dell'occidente è diventata
soprattutto una questione di intelligenza politica. Prosciugare
le sacche di frustrazione politica che radicalizzano in senso
antioccidentale gruppi già religiosamente orientati verso il fanatismo.
Questa è la sfida che ci sta di fronte, per non rendere lo sforzo
militare, pur necessario, inutile nel lungo periodo.
* docente di filosofia politica all’università di Parma

Gli oneri del
liberalismo
Anna Elisabetta Galeotti*
A due settimane dagli attentati in America, allo sbigottimento
iniziale è subentrata la paura di quel che può succedere, di un
conflitto infinito, insidioso che mina la nostra sicurezza quotidiana,
mentre espone popolazioni povere e affamate a risposte militari
che difficilmente riusciranno nell’intento di catturare la centrale
del terrore. Le preoccupazioni sono legittime e l’invito alla
moderazione ai leader politici e militari americani e occidentali
sono opportune, data la difficoltà a localizzare il nemico e trovare
le forme appropriate a questo speciale tipo di conflitto o guerra,
come tutti la chiamano. Non vorrei entrare nel merito di quale
tipo di risposta potrebbe essere migliore, problema che eccede
le mie competenze, quanto piuttosto svolgere alcune riflessioni
sul diritto all’autodifesa della nazione americana e dei suoi
alleati. Spesso le difficoltà del come vengono rimbalzate sulla
liceità del che: il fronte pacifista e no global marcia su questa
confusione, fa fatica nella condanna dell’attentato e della violenza
terrorista a non aggiungere di straforo una qualche collaterale
condanna all’odiato sistema capitalistico globalizzato, fonte
prima di tutte le nefandezze del mondo contemporaneo. Questa tentazione,
per chi mai la provasse, va resistita con grande fermezza per
una diversi motivi. Vale innanzitutto l’argomento generale che
due ingiustizie non fanno una giustizia e se pure dietro la ferocia
terroristica ci fosse l’esasperazione di popolazione affamate
e sfruttate dall’Occidente spietato -il che non è esattamente,
vista la sofisticata organizzazione finanziaria che sostiene il
terrorismo - questo non giustifica, né in alcun modo attenua la
condanna per le migliaia di morti innocenti intenzionalmente causate
con fredda determinazione. Né toglie ai familiari delle vittime
il diritto ad avere giustizia. Secondariamente, il tentativo di
stemperare l’atrocità degli attentati terroristici col rinvio
a colpe generali e originarie dell’Occidente capitalistico rappresenta
lo stesso atteggiamento, con segno rovesciato, di considerare
nemico l’Islam nel suo complesso senza differenziare. In questi
giorni abbiamo sentito l’invito ricorrente di leader politici,
religiosi, giornalisti e esperti a non fare l’errore di compattare
l’Islam in un’entità coesa, univocamente fondamentalista e votata
alla guerra santa, invito sacrosanto per ragioni di giustizia
prima ancora che di prudenza. Specularmente, si deve ribadire
che anche l’Occidente non esiste come entità unica, a vocazione
predatoria e affaristica. La globalizzazione ha generato e genera
problemi e sperequazioni nei paesi in via di sviluppo; cerchiamo
allora di affrontare questi problemi, uno per uno, con umiltà
e buona volontà, individuiamo le responsabilità dei vari attori
e delle varie agenzie, ma non parliamo di colpe collettive, attribuite
a tutti solo per il fatto di essere nati in certe zone del mondo,
e poi a nessuno. Se come dice Michael Walzer la guerra al terrorismo
si conduce su molti fronti, fra cui quello ideologico-intellettuale
è centrale, lasciar passare un concetto come quello di colpe dell’Occidente
significa prestare il fianco a una qualche giustificazione del
terrorismo: se tutti siamo colpevoli, le vittime delle Twin Towers
non sono, per definizione, innocenti. Una colpa generale e indiscriminata
lascia spazio all’idea, moralmente aberrante, di punizione altrettanto
indiscriminata, e questo i membri della rete del terrore ritengono
che siano le loro azioni. Noi invece che abitiamo le società liberali
e democratiche, che godiamo dei vantaggi del libero pensiero e
libera espressione, abbiamo l’onere, come individui e come collettività,
di discriminare nel nostro giudizio su questi atti e sulle risposte
ad essi. La giustizia liberale rifugge dai concetti di colpa e
punizione collettiva e questo costituisce per noi che abitiamo
questo mondo un onere relativamente alle risposte moralmente ammissibili
alla strage dell’11 settembre. Bombardare popolazioni inermi per
colpirne i governi non è possibile, come non è possibile colpire
a caso, non è possibile l’equazione arabo o musulmano= terrorista.
Ciò significa che fare giustizia sarà più complicato, lungo e
difficile, ma è parte del fare giustizia anche non fare confusione
sulle responsabilità e sul diritto all’autodifesa.
*Ordinario di filosofia politica all’Università del Piemonte orientale

Un giorno insensato
o forse inventato
Simonetta Gori Savellini*
È irreale che si pensi immediatamente, quando ancora stiamo vedendo
quanto accade, di stare assistendo a una vicenda epocale di quelle
che lasciano un segno nella storia degli uomini. Se questo è vero
di quale accadimento in realtà si tratta?
Terrorismo, ma quale terrorismo di chi, contro o a favore di chi?
Troppo semplice - anche se gli eventi rilevanti spesso sono essenziali,
almeno nel loro svolgersi - mentre più complessa può apparire
la lettura, l'interpretazione di quello che stiamo vedendo. Intanto
risulta già la percezione di quanto si crede di osservare in un
primo momento: si tratta di una finzione da film catastrofico,
viene forse mostrato un fotomontaggio e comunque quale è la realtà
se di questa si può, si deve ancora parlare?
Come oggi viene frequentemente osservato la vita non copia la
buona letteratura ma la cattiva televisione. Ma all'interno di
tanti programmi quale filone si deve scegliere?
Per comprendere forse si può partire dall'elemento più certo,
le vittime: di tante nazionalità, diverse per provenienza, lontane
per scelte professionali. Prima della morte spesso non emergenti
in una società assertiva, competitiva. A parte è il discorso sui
soccorritori e sulla loro scelta di rischiare, ma sapevano fino
a che punto?
Ora poi ci si chiede quali siano gli artefici dell'evento e alcuni,
molti pensano di poter indicare una sola causa che tutto comprende
e nulla esclude: il terrorismo e tale indicazione è comprensibile,
corretta, ma a quale terrorismo si fa riferimento e quante sono
le cause coinvolte nella genesi del fenomeno?
Non si comprende il ruolo dei cosiddetti agenti dei servizi segreti
che sembrano quasi trasformarsi in studiosi di storia capaci solo
di trovare spiegazioni a quanto è già avvenuto, mentre molti pensavano
che i servizi stessi potessero, addirittura dovessero evitare
prevenendo. Anche volendo accettare una spiegazione a fatti avvenuti
può apparire limitata e limitante la domanda a chi giova, ma viene
fatto di porsela ugualmente e sono probabilmente elencate internamente
in ognuno di noi conseguenze diverse.
Ci sono i guadagni dei mercanti di armi, ci sono i vantaggi di
chi ama dividere gli uomini in buoni e cattivi anche secondo la
razza di appartenenza e il paese di provenienza. Alla fine forse
sarà lo stesso succedersi storico degli eventi a farci leggere
meglio i segni di quanto è accaduto e portarci a comprenderne
meglio il significato.
Se in queste giornate iniziali di un nuovo millennio talora siamo
stati collocati nel ruolo di spettatori passivi, lo stesso scorrere
degli eventi ci costringe invece riconoscerci di nuovo artefici
di una storia che di nuovo riconosciamo ancora parte, maggiore
o minore, opera nostra.
*Docente di Storia Della Psicologia all’ Universita' di
Firenze

Violenza
e giustizia in età globale
di David Held*
Il maggiore filosofo dell'Illuminismo, Immanual Kant, scrisse
più di 200 anni fa che siamo "inevitabilmente fianco
a fianco" . Una violenta abrogazione della legge e della
giustizia in un luogo ha conseguenze su molti altri luoghi e può
essere sperimentata ovunque. Quando si soffermava su questi temi
e sulle loro implicazioni nel lungo periodo, non poteva sapere
quanto sarebbero diventate profonde e urgenti le sue preoccupazioni.
Dall'epoca di Kant, le nostre reciproche interconnessioni e vulnerabilità
sono cresciute rapidamente. Non viviamo più, se mai così
è stato, in un mondo di distinte comunità nazionali
che abbiano da sole il potere e la capacità di determinare
il destino di coloro che vivono al loro interno. Piuttosto, viviamo
in un mondo di comunità i cui destini si sovrappongono.
Le traiettorie e il futuro degli Stati-nazione sono ora pesantemente
confusi tra loro. Nel nostro mondo, non è solo l'eccezione
violenta che lega fra loro gli individui al di là dei confini
nazionali, ma è la natura effettiva dei problemi e dei
processi quotidiani a congiungere le persone in molti modi.
Dalla circolazione delle idee e dei prodotti culturali alle questioni
fondamentali sollevate dall'ingegneria genetica, dalle condizioni
dell'equilibrio finanziario al degrado dell'ambiente, il destino
e le fortune di ognuno di noi sono profondamente intrecciate.
La storia del nostro ordine globale non è una storia al
singolare.
Esistono molti miti riguardo alla globalizzazione ed uno in particolare
è pericoloso: cioè, quello che quest'età
sia sempre più definita dai mercati globali, dai processi
economici e da forze sociali che inevitabilmente sfuggono al controllo
degli stati e dei politici. Piuttosto, l'espansione dei mercati
delle merci, dei beni e delle finanze ha alterato il terreno politico.
Ma la storia della globalizzazione non è solo una storia
di espansione di mercati, di deregulation neoliberale e di abdicazione
da parte della politica; perché è anche una storia
di crescenti aspirazioni ad un diritto e ad una giustizia internazionali.
Dalle Nazioni Unite all'Unione Europea, dalle modifiche del diritto
di guerra alla difesa dei diritti umani, dalla comparsa di movimenti
ambientalisti internazionali all'istituzione di una Corte Criminale
Internazionale, c'è anche un'altra storia che viene raccontata
- la storia che cerca di riformare l'attività umana e trincerarla
al riparo della legge, dei diritti e delle responsabilità.
Questo è il motivo per cui l'11 settembre è un momento
determinante per il genere umano. La violenza terrorista è
stata un'atrocità di proporzioni straordinarie; è
stata un crimine contro l'America e contro l'umanità; un
oltraggio che va annoverato tra i delitti più nefandi del
mondo; ed è stato, senza dubbio, un attacco ai principi
fondamentali della libertà, della democrazia, delle regole
del diritto e della giustizia. Questi principi non sono solo occidentali.
Alcuni loro elementi nasconoo all'inizio del periodo moderno in
Occidente, ma loro validità va molto oltre. Poiché
questi principi sono le basi di una società giusta, umana
e decorosa, di qualsiasi religione o tradizione culturale. Parafrasando
il teorico legale americano Bruce Ackerman, non esiste nessuna
nazione senza una donna che desideri uguali diritti, nessuna società
senza un uomo che rifiuti la sottomissione e nessuna nazione in
via di sviluppo senza una persona che desideri i minimi mezzi
di sussistenza per poter affrontare la vita di ogni giorno.
I principi della libertà, della democrazia e della giustizia
sono le basi per la realizzazione e la difesa dell'uguale libertà
di tutti gli esseri umani, dovunque essi siano nati o cresciuti.
L'intensità della serie di reazioni alle atrocità
dell'11 settembre è pienamente comprensibile da qualsiasi
punto di vista. Non possono esserci molte persone nel mondo (nonostante
le immagini di festa in alcune zone veicolate dai media) che non
abbiano provato shock, repulsione, orrore, sconcerto, rabbia e
desiderio di vendetta. Tale varietà di emozioni è
perfettamente naturale nel contesto degli eventi attuali. Ma non
può essere la base di una risposta più saggia e
ponderata.
I principi fondanti della nostra società, i valori realmente
attaccati l'11 settembre, ci impongono di fermarci a riflettere;
di non generalizzare troppo la nostra reazione sulla base di un
singolo momento e di un singolo insieme di eventi; di non saltare
a conclusioni basate sui timori che si sviluppano in un solo paese;
e di non riscrivere, di non rifare la storia da un posto solo.
La lotta alla paura deve poggiare su nuove basi. Non si può
ritornare all'approccio disorganizzato e compiacente nei confronti
del terrorismo del 10 settembre. I terroristi devono essere sconfitti
e coloro che li proteggono e li finanziano devono essere messi
di fronte ad una resa dei conti. In queste circostanze la completa
non tolleranza è pienamente giustificata. Il terrorismo
va contro le nostre ambizioni e i nostri principi più cari.
Ma qualsiasi reazione giustificabile, sostenibile e difendibile
all'11 settembre dev'essere in armonia con i nostri valori fondamentali
e con le aspirazioni della società internazionale alla
sicurezza, al diritto, all'amministrazione imparziale della giustizia
- aspirazioni dolorosamente realizzate dopo l'Olocausto e la Seconda
Guerra Mondiale.
Se i mezzi utilizzati per combattere il terrorismo contravverranno
a tali principi, forse il sentimento del momento potrà
essere soddisfatto, ma si accrescerà la nostra reciproca
vulnerabilità. Finiremo con l'andare ancora un passo indietro
rispetto ad un ordine mondiale più sicuro e giusto. Questo
potrebbe facilmente implicare la crescita dell'intolleranza nei
confronti di tutti i tentativi di protesta e di modifica delle
circostanze politiche, anche di quelli rispettosi della legge
e pacificamente orientati.
La guerra e i bombardamenti sono una delle opzioni per l'immediato
futuro; ma un'altra è l'istituzione di una Commissione
Internazionale sul terrorismo globale che potrebbe essere ispirata
ai modelli dei tribunali di guerra di Tokyo e Norimberga, che
operi sotto l'autorità delle Nazioni Unite rivitalizzate
e dotate di nuova energia. Una commissione del genere potrebbe
essere potenziata per scoprire i responsabili del nuovo terrorismo
di massa e consegnarli alla giustizia. Sostenuta dalla possibilità
di imporre sanzioni economiche, politiche e militari - e supportata
tra l'altro dalle capacità militari delle Nazioni Unite
e della Nato - potrebbe essere la base di un sistema di indagine
e di punizione che richiede un appoggio globale.
Potrebbe essere la base non solo per il rafforzamento degli assetti
legali e multilaterali esistenti, ma anche il punto di partenza
per contribuire alla creazione di un nuovo ordine democratico,
giusto e attendibile.
I mezzi devono essere in accordo con i principi minacciati. Il
terrorismo dev'essere criminalizzato su basi internazionali, non
sradicato con un'atto violento e arbitrario.
Io non sono un pacifista. La ragione di queste raccomandazioni
non è quella di evitare l'uso della forza coercitiva in
ogni circostanza. Piuttosto, dipende dal desiderio di continuare
a costruire sugli elementi più umani e giusti del nostro
ordine globale che sono stati stabiliti nei vari ultimi decenni,
e di difenderli in modo tale che essi possano ricevere rispetto
e fedeltà da tutti, dovunque.
Ma, per usare una sola frase, dobbiamo essere forti non solo nei
confronti del crimine ma nei confronti delle cause del crimine.
Chiunque siano stati i responsabili degli attacchi terroristici
dell'11 settembre, sappiamo che ci saranno sempre volontari per
missioni suicide, bombardamenti suicidi e raggruppamenti terroristici
se non ci preoccupiamo delle più profonde questioni della
pace e della giustizia sociale nella comunità globale.
Nella nostra età globale plasmata dalle immagini guizzanti
della TV e dei nuovi sistemi informativi, le enormi ineguaglianze
nelle opportunità di vita in molte regioni del mondo alimentano
un delirio di rabbia, ostilità e risentimento.
Senza una giusta pace in Medio Oriente e senza il tentativo di
ancorare la globalizzazione ai principi significativi della giustizia
sociale, non ci potrà essere una soluzione duratura al
genere di delitti a cui abbiamo appena assistito.
Naturalmente, crimini del genere possono spesso essere opera di
semplici alienati e fanatici e quindi non ci può essere
la garanzia che un mondo più giusto sia anche un mondo
più pacifico sotto tutti gli aspetti.
Ma se voltiamo tutti insieme le spalle a queste sfide, non c'è
speranza di migliorare le basi sociali del divario spesso sperimentato
nei paesi più poveri e più emarginati. Gravi ingiustizie,
legate a un senso di disperazione nato da generazioni di oblio,
alimentano l'odio e l'ostilità. Il sostegno popolare contro
il terrorismo dipende dal convincere la gente che c'è un
modo legale e pacifico di indirizzare le proprie insoddisfazioni.
Kant aveva ragione; la violenta abrogazione della legge e della
giustizia in un luogo riecheggia in tutto il mondo.Non possiamo
accettare l'onere di stabilire la giustizia solo in una dimensione
dell'esistenza - la sicurezza - senza allo stesso tempo cercare
di stabilirla ovunque.
*Professor politics alla London School of Economics
Quale globalizzazione
vogliamo?
Pietro Ichino*
Un primo punto di vista: il maledetto ventesimo secolo non
vuole finire. L’11 settembre abbiamo assistito a un altro
suo drammatico sussulto: un contraccolpo dello scontro mediorientale,
le cui radici storiche affondano, ben oltre lo sterminio nazista
degli ebrei e la nascita dello Stato di Israele, nei grandi sommovimenti
della prima metà del “secolo breve” che ne hanno costituito le
premesse.
Un secondo punto di vista: è incominciato (male) il ventunesimo
secolo. L’11 settembre abbiamo voltato pagina rispetto a un mondo
diviso tra grandi potenze, in cui le guerre venivano preventivamente
proclamate da una nazione contro un’altra e si combattevano con
gli eserciti schierati, mentre i grandi scontri sociali avvenivano
all’interno di ciascuna nazione, tra ricchi e poveri di uno stesso
paese, tra padroni e lavoratori di uno stesso sistema produttivo.
Ora la guerra è tra le grandi potenze planetarie da un lato e
dall’altro manipoli di guerriglieri che si ergono a rappresentanti
dei disperati e dei diseredati della parte povera del mondo, che
si nascondono dovunque e colpiscono senza preavviso, che per colpire
non usano le proprie armi, ma ritorcono contro il nemico gli strumenti
stessi del suo potere: innanzitutto i suoi mezzi di comunicazione
e informazione di massa, ma anche i suoi mercati finanziari, le
sue scuole e centri di addestramento, le sue grandi opere civili,
i suoi aerei, persino il carburante in essi contenuto; e domani
– Dio non voglia – anche le sue industrie chimiche e le sue centrali
nucleari.
Un terzo punto di vista: la tragedia delle Twin Towers, come un
secolo fa quella del Titanic, segna la fine di una nostra seconda
Belle Epoque. L’11 settembre chiude bruscamente un periodo felice
e forse troppo spensierato di crescita economica che si credeva
illimitata, di pace tra i paesi ricchi e di progressiva integrazione
mondiale, umiliando la presunzione di onnipotenza tecnologica
e invulnerabilità dell’Occidente.
Coglie sicuramente una parte di vero ciascuno dei tre punti di
vista. Comunque si interpretino i fatti di questi giorni, non
cambia però il problema cruciale che l’Occidente deve risolvere:
quello di convincere la parte restante del mondo che la globalizzazione,
se ben governata, è un gioco a somma positiva da cui tutti – anche
la parte più povera del mondo – hanno soltanto da guadagnare;
e che le barriere tra i popoli e le nazioni possono essere abbattute
senza pregiudizio per la coesistenza di culture e religioni diverse.
Se questo è il vero problema, non mi sembra che su questo terreno
ci si possa attendere qualche beneficio dal grande dispiegamento
di potenza militare con cui gli Stati Uniti si propongono di reagire
all’atroce offesa subìta. Riusciranno forse ad abbattere il tetro
regime dei talebani in Afganistan, ma al prezzo dell’ulteriore
radicarsi in una parte considerevole del mondo islamico dell’idea
che la globalizzazione si identifica con l’egemonia politico-militare-culturale
americana sul mondo intero. Mi sembra una scelta ottusa, anche
da un punto di vista puramente egoistico: forse che potremmo sentirci
più sicuri, sui due lati dell’Atlantico settentrionale, quando
l’insediamento a Kabul di un governo filo-occidentale sarà stato
ottenuto a quel prezzo?
Certo, è giusto combattere senza tregua i regimi criminali, porli
in condizione di non nuocere, fare tutto il possibile per farli
cadere; così come è giusto stanare e punire severamente i terroristi.
Ma qualsiasi vittoria militare contro i primi e/o contro i secondi
sarà un buco nell’acqua se contemporaneamente non si sarà ottenuto
il loro isolamento politico e culturale. Vedo invece il rischio
che, nell’immenso vivaio dei diseredati al quale i terroristi
possono attingere, il colossale schieramento di portaerei, bombardieri
ed elicotteri americani nel Medio Oriente oggi produca un risultato
opposto.
Sono convinto che le migliori teste d’uovo della Casa Bianca queste
cose le sappiano benissimo. Il guaio è che in un sistema democratico,
quale certamente è quello statunitense, non è “giusta” la politica
che scienza e coscienza dei consiglieri migliori indicano come
tale, ma quella che come tale è percepita dalla maggioranza degli
elettori; e gli elettori statunitensi oggi sono troppo profondamente
feriti per ragionare lucidamente. In questo sta il vero successo
della mente diabolica che ha concepito e organizzato la strage.
* Docente di Diritto del Lavoro all’Università degli studi
di Milano

L’incontro con l’Altro
Paolo Inghilleri*
Ci sono dei momenti, purtroppo spesso tragici come questo, in
cui la Storia entra, in modo dirompente, nella Psicologia e nello
studio del comportamento: penso ad esempio alla riflessione di
Freud che, subito dopo il dramma della prima guerra mondiale,
preveggente il nascente nazifascismo, definì in modo esplicito
il concetto di pulsione di morte. È oggi davvero possibile accettare
l’idea, propria di tanta psicologia e delle neuroscienze contemporanee,
di un uomo e di una mente isolati dai loro contesti e dai loro
gruppi, regolati da stretti vincoli biochimici o cognitivi? Mi
immagino i pensieri, ma soprattutto le emozioni e gli affetti
delle vittime nei momenti degli attacchi; ma penso anche ad emozioni
e ragionamenti dei terroristi e dei kamikaze e delle loro famiglie,
padri, madri, forse figli….la scena di donne e bambini che in
paesi lontani, danzano di gioia, per l’attacco riuscito…Questi
eventi ci mostrano, come uomini e come scienziati, la complessità
dei fenomeni psicologici e sociali. Non ci può bastare una spiegazione
che si basi solo su pulsioni e dinamiche individuali (la possibile
psicosi di un terrorista, l’aggressività su base genetica di un
omicida, gli schemi cognitivi che stanno alla base del pregiudizio)
o solo su fattori di tipo sociale (la povertà, l’oppressione politica
ed economica). Occorre uno sforzo creativo per fornire nuovi modelli
per comprendere ed agire. Cosa unisce un giovane di New York,
uno di Kabul e uno di Milano? Non è forse la possibilità di poter
reciprocamente sentire e comprendere che la fenomenologia dell’esperienza
che si prova nel corso delle relazioni con il mondo esterno ha
caratteristiche simili a quella degli altri, anche lontani? E
che questa similitudine del funzionamento delle strutture esperienziali
e di coscienza avviene al di là delle differenze biologiche (ad
esempio il colore della pelle o il tasso di mediatori chimici
cerebrali) e culturali (ad esempio le norme, gli oggetti
di uso quotidiano, i sistemi simbolici). Anzi, è proprio la differenza
che permette questa assonanza: ognuno di noi ha infatti esperienza
“buona” quando può sperimentare la continuità della relazione
tra la propria identità e la cultura a cui appartiene, la quale
però tende a variare da luogo a luogo, da popolo a popolo. Il
comprendere che sentimenti e cognizioni che si provano seguendo
una idea politica, partecipando ad un rito religioso, stando con
la famiglia, facendo un lavoro che piace, sono gli stessi che
prova “l’altro”, al di là della diversità, talora enorme, di questi
elementi culturali, rappresenta un formidabile fattore di comunicazione
e di possibile sviluppo comune. L’ esigenza dello studio scientifico
e clinico della fenomenologia dell’esperienza (e delle sue basi
psicologiche, biologiche e culturali) va di pari passo con quella
dell’azione politica e quotidiana tesa a creare continue possibilità
di ponti tra individui di paesi e culture differenti: questo,
a mio avviso, rappresenta l’impegno attuale e più urgente per
ogni cittadino ed ogni studioso. Occorre favorire lo sviluppo
globale di scuole, situazioni lavorative, forme artistiche e
spettacolari dove i giovani del mondo possano mettere in gioco
le loro intelligenze, la loro creatività, il loro benessere, i
loro problemi e possano sentire la diversità e l’unione delle
esperienze soggettive.
*Ordinario di Psicologia Sociale, Università degli Studi di Verona

È andato in scena
il gran finale
Maurizio Maggiani*
Quello che sono riuscito a leggere negli attentati terroristici
di New York e Washington è che non ho un futuro, che ho vissuto
per tutta un’epoca convinto che me ne sarei andato lasciando un
mondo diverso da come l’ho trovato quando sono nato, e che invece
me ne andrò con la certezza di lasciare un mondo peggiore di quello
che ho trovato. Mi è impossibile vedere un qualsiasi progetto
di redenzione, una speranza che possa realizzare, come dicono
gli anarchici, una Umanità Nuova.
Di fronte agli attentati la domanda che sono portato a rivolgere
a me stesso è se sto con gli Americani o con i terroristi, ma
io non voglio essere schiacciato tra queste due sole scelte: pensavo
di avere un’intelligenza, una dignità, una libertà di pensiero,
e invece non l’ho più, devo vivere con l’intelligenza degli altri,
con la dignità che si vogliono assumere gli altri, col pensiero
degli altri.
Prima di questi avvenimenti potevo pensare di poter vivere con
una speranza, ma ora ho l’impressione di aver assistito al gran
finale. Non è vero che è cominciata o sta per cominciare la terza
guerra mondiale, ma è finita ed ho perso perché il crollo delle
due torri non porta nessuna giustizia, nessuna speranza e nessuna
dignità.
Quello che sta per succedere invece è l’inizio della quarta guerra
mondiale. Noi, da parte nostra, non possiamo fare altro che stare
a guardare e provare a ragionare con i “se” che però non ci aiutano
per niente: se ci fosse una sinistra italiana potrebbe cominciare
una splendida, fruttuosa e lunga battaglia per le libertà. Ma
quello che vediamo é l’inizio di una nuova guerra al termine della
quale parleranno gli uffici stampa del vincitore e mi racconteranno
l’esito vittorioso di una guerra che mi ha comunque visto sconfitto.
*Scrittore

Un gigantesco
lutto da elaborare
Mauro Mancia*
Di fronte ad un avvenimento di morte così eccezionale è necessario
che ognuno, vicino o lontano dalla tragedia, rifletta sulle cause
che hanno potuto produrre eventi così catastrofici e disumani,
che lavori sulla propria mente e pensi alle proprie emozioni mentalizzando
l’angoscia ed elaborando una strategia che gli permetta di riorganizzare
e dare stabilità al proprio mondo interno che il terrorismo con
i suoi folli gesti ha fortemente destabilizzato.
L’apporto più consistente che la psicoanalisi può portare alla
conoscenza di questo evento che ha cambiato la nostra storia è
quello di indicare come elaborare il gigantesco lutto che si è
abbattuto su tutti noi e non solo sugli americani o sugli abitanti
di New York, e come proteggerci dalle risposte paranoidi con forti
componenti persecutorie che ognuno è spinto a dare di fronte ad
un attacco così mostruoso da parte di un nemico sconosciuto e
quindi ancor più persecutorio di un nemico visibile.
Da un’intervista di Alexander Stille a Phil Herschenfeld, psicoanalista
dell’Istituto di New York, emerge che in ogni superstite si sono
manifestati fenomeni gravemente isterici, come quel poliziotto
la cui mano destra è restata paralizzata, a suggerire che lo shock
non era pensabile e poteva essere significato solo con il corpo,
cioè con una conversione isterica. Altri si sono così profondamente
identificati con le torri gemelle che si disgregavano di fronte
ai loro occhi al punto da temere una disgregazione della propria
identità. Questo dell’identificazione è un processo di grande
rilievo in queste catastrofi che le televisioni hanno contribuito
a portare in ogni casa nel mondo e ad amplificare creando quindi
situazioni emozionali che sono esplose quasi simultaneamente in
tutto il globo provocando una specie di “globalizzazione” dell’angoscia.
La destabilizzazione del mondo interno di ogni individuo del mondo
occidentale ha creato una situazione di angoscia unita alla paura
e alla diffidenza che hanno contribuito a creare un clima paranoico
in cui il vicino di casa, specie se mussulmano, poteva essere
visto come un pericoloso nemico.
Queste ansie sono state particolarmente forti nei bambini. Telefono
azzurro, ad esempio, ha raccolto testimonianze di bambini che
vedevano kamikaze dappertutto, che comparivano in sogni angosciosi.
Tutti questi bambini dichiaravano di non poter dormire e di avere
paura della guerra e non erano in grado di gestire le proprie
emozioni.
La concentrazione delle colpe nel personaggio Bin Laden e la sua
immagine ossessivamente presentata in TV e nella stampa hanno
certo contribuito a ridurre l’angoscia in quanto il nemico aveva
un volto, ma hanno creato il pericolo di un pensiero pre-logico:
poiché Bin Laden è mussulmano, tutti i mussulmani sono potenzialmente
terroristi.
Il personaggio Bin Laden resta tuttavia molto inquietante. Il
suo paradosso consiste essenzialmente nel fatto che i vari giornalisti
che lo hanno conosciuto e intervistato parlano di lui come di
un uomo timido, gentile, semplice, che non ha nessuna delle caratteristiche
del terrorista. Il suo phisic du rôle è piuttosto quello di un
mistico solitario, impegnato più in questioni religiose che in
organizzazioni di attentati terroristici. Eppure, nell’immaginario
mondiale si è creata di lui un’immagine di uomo cinico, ricco,
potente e fondamentalmente assente. Il suo potere, cioè, nasce
dall'essere assente, nascosto nelle montagne dell’Afghanistan
e quindi introvabile. Viene così ad impersonare l’oggetto persecutorio
per eccellenza che non si sa dove sia, ma che può colpire in ogni
momento.
Appare sempre più chiaro, inoltre, che i terroristi – sponsorizzati
o meno da Bin Laden – hanno creato una organizzazione capillare
che coinvolge anche il mondo occidentale. La razionalità vorrebbe
allora che l’operazione anti-terroristica fosse mirata e altrettanto
capillare e non diretta contro nazioni e cittadini indifesi. Non
è di forza che abbiamo bisogno in questo momento, ma di intelligenza.
E fa parte di questa intelligenza separare nel mondo arabo e mussulmano
la parte terrorista dalla parte più sana e non compattarle in
una guerra di religione o di civiltà, parlando senza conoscenze
storiche adeguate e senza sensibilità diplomatica di una cultura
occidentale superiore a quella mussulmana.
La parola guerra, per quanto sui generis, attiva antichi fantasmi,
aumenta l’angoscia in ogni cittadino del mondo occidentale e mussulmano,
crea panico che si ripercuote nel mercato azionario e nella produzione
internazionale. Capisco che Bush abbia dovuto, sotto l’impatto
emotivo, promettere agli americani vendetta, ma l’operazione deve
essere affidata alla razionalità e alla tecnologia più avanzata
in modo da paralizzare i nuclei terroristici che non sono soltanto
in Afghanistan ma anche in altri paesi. Vedo anche altre possibilità
come quella, forse non così difficile, di rovesciare il regime
dei talebani affiancando l’esercito antigovernativo del nord.
L’importante è comunque che tutto il mondo occidentale si mobiliti
per paralizzare questo movimento terroristico che rischia di distruggere
la nostra civiltà, e ad un tempo rinforzi la sua alleanza con
la parte pacifica del mondo mussulmano aiutandolo ad uscire dalle
difficoltà umane, giuridiche e sociali in cui è caduto.
* Neurofisiologo dell’Università degli Studi di Milano
Membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica
Italiana
Campo di studi: Neurofisiologia del sonno, ricerche sul sogno,
sulla memoria e sugli aspetti narcisistici della personalità.

Un gesto contro
l’Islam
conversazione con Renato Mannheimer*
In che cosa il proprio sapere può essere d’aiuto in momenti
drammatici come quelli attuali?
Il proprio sapere è l’esperienza di ciascuno di noi, un sapere
storico, politico e anche quotidiano che ci deve aiutare ad affrontare
le terribili circostanze nelle quali ci troviamo. Ma io credo
anche che questo sia uno straordinario momento di sapere e di
apprendimento per tutti noi: non a caso, dopo la prima iniziale
reazione di sconcerto, la reazione della maggior parte dell’opinione
pubblica è stata ragionevole, non certo irragionevole. Dunque,
riepilogando: una prima reazione di incredulità, una seconda di
paura, di terrore persino, e di sconcerto, infine una reazione
positiva, di ribellione, determinata nella sconfitta del male,
eccezion fatta per qualche settore isolato e minoritario.
Dunque, a suo parere, l’opinione pubblica occidentale vuole
portare fino in fondo questa guerra?
Io credo che l’opinione pubblica occidentale – massimamente quella
americana, al 90 % diciamo, ma anche quella europea, solo che
al 60-70%, dunque con una netta maggioranza a proprio favore –
abbia individuato una priorità ben precisa, quella di sconfiggere
il nuovo nemico dell’umanità, oggi rappresentato dal terrorismo,
fatto del tutto nuovo e imprevedibile solo fino a pochissimo tempo
fa. La schiacciante e determinata maggioranza che si è creata
intorno a tale obiettivo mi ha sorpreso.
Il cocktail guerra e recessione rischia di diventare esplosivo.
Non sappiamo che tipo di guerra sarà, ma certo è che la paura
della recessione economica sarà senz’altro molto forte. Però non
credo sia legata alla paura della guerra in se stessa, ma alla
situazione generale d’insicurezza e di paura. Ovvio che la crescita
economica ne risenta fortemente.
D’altra parte, sono in molti disposti ad accettare anche questo
rischio, specialmente negli Usa, ma anche in Europa. La gente
ragione in questo modo: se non facciamo la guerra, se non estirpiamo
il male del terrorismo alla radice, ci saranno altri attentati
e i terroristi potrebbero non fermarsi mai. Poi, come dicevo prima,
vi sono differenze tra l’opinione pubblica americana e quella
europea, ma entrambe ritengono utile, necessario e prioritario
un attacco militare per sconfiggere il terrorismo.
Quali ripercussioni la nuova drammatica fase che si è aperta
avrà nella vita quotidiana delle persone?
I terribili attentati di New York e Washington hanno colpito profondamente
la psiche dell’opinione pubblica. È aumentata, ad esempio, la
vendita di sigarette: la gente è nervosa, preoccupata. Inoltre,
l’elemento nuovo e cruciale di questo attacco terroristico è la
sua capacità di colpire ovunque e con modalità inaspettate. Io
ho mangiato all’ultimo piano delle Torri Gemelle lo scorso gennaio:
se avessero colpito allora, oggi non sarei qui. Il nuovo terrorismo
è un nemico insidioso e che si può attaccare ovunque: non si sa
più a cosa e a chi bisogna fare fronte e difendersi. Ecco perché
la condanna del terrorismo che miete vittime civili in modo indiscriminato
è totale e inequivocabile. Uno strumento di lotta, dunque, che
– a differenza del passato – diventa oggi inaccettabile, anche
se condotto in nome dei diritti e delle difficili condizioni di
vita di alcune popolazioni. Non a caso, non vi sono più stati
attacchi kamikaze da parte dell’Intifada palestinese dagli attentati
negli Usa in poi. Oggi, anche i palestinesi sanno che un attacco
terroristico non verrebbe più giustificato da nessuno.
Cosa dice a chi parla di scontro di civiltà?
Mi rifiuto categoricamente di pensare che i terroristi siano l’espressione
della civiltà islamica: si tratta semplicemente di estremisti
fanatici, come nel corso della storia ve ne sono stati anche tra
i cattolici o tra gli ebrei. Peraltro, chi conosce la civiltà
islamica sa bene che il mondo mussulmano e lo stesso Corano escludono
categoricamente l’uccisione di civili innocenti per affermare
l’Islam. Questo è un atto perpetrato contro l’Islam e contro la
sua storia. L’unico scontro di civiltà in atto – e che va portato
fino in fondo – è quello tra la civiltà dell’uomo e il fanatismo.
* Docente di Scienza politica all'Università di Milano.Studioso
dell’opinione pubblica.
*

Ecco perché
Rambo non ci salverà
Guido Martinotti*
“Attacco!L’è el gran dì. Ma chi capisen no che semm dree anda
a muriì” canta con ironia amara il fantaccino della Prima Guerra
Mondiale. Ed è difficile non condividere questo senso di fallimento
morale e intellettuale mentre sentiamo le notizie di centinaia
di aerei e navi che si muovono nel Golfo Persico. Come nella triste
canzone popolare c’è chi suona la tromba. E che lo facciano Bush
e (parte de) il suo governo non stupisce nessuno. Ma perché tutti
gli speakers(esses) delle radio di stato devono assumere quel
tono marzial-trionfale quando raccontano delle navi che partono
e degli aerei che volano verso il Golfo Persico?
Avrei una preghiera personale, ma dal profondo del cuore, per
queste ottime persone. Sentitevi le registrazioni dei vostri predecessori
durante la seconda guerra mondiale e, qualsiasi cosa vi abbiano
insegnato, non usate quel tono, non fate le stentoree voci di
guerra, chi le ha sentite annunciare avanzate che non c’erano
e rotte che venivano chiamate “ripiegamenti tattici” si è sentito
tradito da voi e vi odiava. La guerra è favorita anche da un clima
di guerra. Il parapaa, parapaa, parapaa, tenetelo in serbo per
il campionato di calcio, il Giro d’Italia o la notte degli Oscar.
Della guerra si può parlare con voce umana anche quando il mestiere
obbliga a dire cose false.
E purtroppo di cose false ne cominciamo già a vedere, a bizzeffe,
come quelle scene del carro armato con l’Afghano in turbante sopra,
che in una inquadratura muove qualche metro da sinistra a destra
del campo e in quella successiva torna indietro degli stessi metri.
Inquadratura ripetuta ossessivamente a ogni notiziario (Rete 4
del 26 Settembre). Il cronista può anche essere obbligato a questi
trucchi puerili per produrre un certo footage, ma non c’è bisogno
di aggiungerci un’adesione emotiva. E invece i mezzi di comunicazione
di massa si sono buttati sul clima e sulle immagini militaresche
con una foga, un’avidità e un’adesione emotiva che lasciano sconcertati
e fanno temere il peggio in caso di vere ostilità. Le voci del
dissenso come quella dello studente americano intervistato da
Radio Popolare la sera del 23 Settembre notano con grande inquietudine
soprattutto questa grande mobilitazione dei mezzi di comunicazione
che fa veramente paura perché lascia il comune cittadino totalmente
indifeso.
La Grande Armata Navale sta per attaccare un paese che non ha
neppure un metro di costa., con una densità di popolazione di
26 abitanti per kmq e che per parte del tempo è avvolto da una
sabbia così sottile che i visitatori si ammalano. Ho un ricordo
personale del grande sociologo tedesco René Koenig che per anni,
dopo una permanenza in Afghanistan, ha avuto seri problemi di
respirazione. Paradossalmente la densità abitativa dell’Afghanistan
non è molto diversa da quella americana (27.5 ab/kmq) ma è un
dato ingannevole perché negli USA il 75% della popolazione è urbana
e la percentuale di addetti è all’agricoltura è del 2.% mentre
in Afghanistan la popolazione urbana è del 19.2%. La speranza
di vita alla nascita nell’Afghanistan è di 44 anni per gli uomini
e 45 per le donne, in USA è di 73.0 per gli uomini
e 79,7 per le donne. Che cosa potranno fare in un paese così le
forze armate più potenti del mondo, con elicotteri i cui filtri
già in Iran hanno dato prova di non reggere troppo bene a condizioni
estreme è un mistero. Non lo dico io, lo spiega con buona
conoscenza di causa il generale russo che ha perso la guerra in
quel paese. “We will bomb them back into the Stone age”, è una
frase che se ricordo bene viene dalla guerra del Vietnam (con
i risultati per gli USA che abbiamo visto, 50.000 giovani americani
morti in dieci anni di guerra persa). Ma come dice lo scrittore
afghano Tamim Ansary, è “già stato fatto”. Nell’età della
pietra il paese è stato gettato da anni di guerre, dalla distribuzione
di dieci milioni di mine uomo (l’Afghanistan è il paese più minato
del mondo) e dai bombardamenti degli stessi talebani.
Una “guerra” che sembra quel racconto di fantascienza in cui militari
e scienziati (leggi guerrafondai e pacifisti) litigano sui mezzi
con i quali far fronte alla minaccia di un blob energofilo, che
vive cioè succhiando energia dall’ambiente. Gli scienziati riescono
a convincere i militari che un bombardamento sarebbe controproducente
perché il blob assorbirebbe l’energia delle bombe e se ne nutrirebbe
ingrandendosi. Allora i militari hanno il colpo di genio:”nuke
it!”- bombardalo con l’atomica. Senza sentire ragioni, caricano
il blob su un razzo a testata nucleare e lo spediscono nello spazio
interplanetario in un punto abbastanza lontano dalla Terra per
far detonare la bomba H al sicuro. Dopo l’esplosione i militari
esultano, il blob è stato spedito nel vuoto in minuscoli frammenti.
Ma gli scienziati, che continuano a tenere l’occhio al telescopio
si accorgono ben presto che i milioni di frammenti del blob si
dirigono rapidi verso il sole succhiandone l’energia immensa e
ingrandendosi a vista d’occhio.
Mentre i massmedia suonavano le fanfare e il Presidente americano
cercava di rinsaldare la propria opinione pubblica promettendo
“we will smoke them out” come si fa con gli insetti nocivi o con
le puzzole, si è prodotto un movimento piuttosto ampio di
moderazione e di ripensamento, che naturalmente è stato subito
bollato dai crociati come il generale Janne come buonismo, viltà
o connivenza con il terrorismo. Ma è esattamente il contrario,
chiunque abbia un minimo di discernimento capisce, o dovrebbe
capire, che “alzare il livello dello scontro”, come si diceva
una volta, fa parte della strategia evidente di chi ha organizzato
il massacro dell’11 settembre. Ma i contorni della strategia e
la natura degli attori sono ancora del tutto oscuri, nonostante
i fiumi di inchiostro e di immagini prodotti in queste poche settimane.
Il presidente del Consiglio però non ha dubbi, è uno scontro di
civiltà e noi siamo superiori. Mi ricorda un flemmatico amico
che risalendo da una immersione piuttosto impegnativa ragionava
così con lo squalo che gli stava davanti: ”Io sono superiore a
lui perché ho letto Platone”. Il Cavaliere, Platone forse non
lo ha letto, ma ha consiglieri che hanno idee precise sullo scontro
tra il nostro mondo e quello dell’Islam e soprattutto legge Guzzanti
che per salvare il padrone ((“io poi ho sofferto come una bestia
in Senato vedendo Silvio Berlusconi costretto se non a chiedere
scusa…”) rispolvera acrobaticamente la distinzione spenglerian-weberiana
tra “Kultur e Zivilisation”.
Non c’è da sorprendersi di quel che Berlusconi ha detto, e per
una volta tanto, l’ho sentito dal vivo. Intanto non è la prima
volta, né sarà l’ultima, che un uomo politico italiano fa la figura
del cugino sciocco degli americani. È nella natura della nostra
posizione nei confronti degli Usa, di “best friend” combinata
con la particolare foga di affollarsi nei primi posti del filoamericanismo
che contraddistingue molti politici e intellettuali nostrani.
Di suo Berlusconi ci ha solo aggiunto la sua sincerità, che è
quella di una classe media che non legge molto, che probabilmente
crede che Il crisantemo e la spada sia un film storico, Ruth Benedict
un autore di gialli e Clifford Geertz un suonatore di jazz, ha
vaghe ma ben radicate nozioni del mondo, basate su salde convinzioni
che la Fallaci sia la più grande letterata contemporanea (convinzione
totalmente condivisa dalla stessa) che Di Bella sia lo scopritore
del Dna, Sgarbi maestro di eleganza, e Muccioli l’autore di Paideia.
Nulla da stupirsi, Berlusconi la pensa così, esattamente come
i leghisti che seguono Telepadania sono perfettamente convinti
di quel che gli racconta l’avv. Taormina, che ne è parimenti fermanente
convinto, che gli albanesi sono feroci per un fatto genetico.
Mussolini peraltro era perfettamente convinto che gli americani
hanno la maturità intellettuale di un quattordicenne e non credo
che abbia mai cambiato idea. Le fortezze volanti, le navi Liberty,
le portaerei e i mezzi da sbarco? Un accidente della storia. Il
dibattito sul relativismo culturale tra Marshall Shalins e Gananath
Obeysekeyre? Pirlate. E via dicendo e soprattutto peggiorando
con la tecnica tutta italiota di dire e poi smentire. Ma Geddafi,
che è intelligente, rifiuta la modesta ritrattazione di Berlusconi
dicendo giustamente che Berlusconi era sincero e che esprimeva
ciò che pensa la “gente”.
Se non capiamo la natura di questo terrorismo, non riusciremo
a sconfiggerlo. Si potrà spianare l’Afghanistan, ma quelle che
i mass media chiamano “le volpi del Desert storm” rischiano di
fare la fine del coyote di quei cartoons che vi fano vedere in
aereo. Il coyote usa tutti gli strumenti del bricolage meccanico
americano (Acme steel nails, Acme TNT, Acme hunting pellets e
tutti gli innumerevoli prodotti che si trovano da Home Depot o
da Kmart) per incastrare il velocissimo road runner. E ogni volta
va a finire che il razzo gli scoppia in mano o il masso gli cade
sulla testa. Se potessi obbligherei tutti i generali americani,
compreso il texano Bush che ne è il capo in testa, a rivedersi
il cartoon del coyote prima di dare l’ordine di attacco. Tra l’altro
il cartoon è ambientato in un contesto desertico e polveroso non
molto diverso dai paesaggi afghani che ci regala la televisione.
Operazione Aquila Nobile, non meno di dieci anni. Ma in dieci
anni si fa un piano Marshall per l’Afghanistan e per tutta l’area
mediorientale in grado di portare questi paesi fuori dalla disperazione
e dare un impulso all’economia di tutto il mondo. Vi ricordate
le proposte di guerra alla fame di Ernesto Rossi e di Paolo Sylos
Labini? non erano poi tanto irrealistiche.
Il problema però non si può risolvere così facilmente. Che sia
“guerra” come piace ai militari o “atto criminale” come piace
alle assicurazioni, quello che è avvenuto è un atto di guerra,
tanto più pericoloso perché non è stato dichiarato da un
attore convenzionale. Ed è anche perpetrato con mezzi non convenzionali,
anche se abbondantemente previsti dall’immaginario scenico. Quello
straodinario abitante di Harlem con il cappelletto rosso che intervistato
dal corrispondente newyorkese di Santoro racconta che mentre il
primo degli aerei entrava in una delle Twin Towers lui se ne stava
davanti alla televisione a farsi una canna e la prima cosa che
ha pensato è stata: “Dio, questa roba deve essere davvero buona”.
E per capire la natura di questo terrorismo dobbiamo entrare nella
psicologia della disperazione. Che non è islamica o afghana o
orientale, ma appartiene al mondo del martirio e dell’eroismo.
I difensori di Alamo o i giovani tenentini che andavano all’assalto
sul Grappa erano dei suicidi o no?
Il terrorismo va combattuto, ma non è detto che il bombardamento
dell’Afghanistan sia il modo migliore per combatterlo. E se non
servisse a nulla o peggio fosse proprio una delle conseguenze
intese dai terroristi? Certo l’Fbi, la Cia e tutti gli altri servizi
avranno montagne di informazioni che noi non abbiamo, ma finora
non hanno dimostrato di essere molto “guzzi” o “sharp” e tutto
sommato al di là delle informazioni specifiche occorre poi tenere
presente principi generali . E anche chi è convinto che non si
tratti di un confronto tra l’Islam e la cultura occidentale (spero
davvero che non lo si proponga perché rischiamo anche di perderlo)
e chi è convintissimo che le diseguaglianze del mondo costituiscano
il terreno di cultura del terrorismo, esistono tempi e modo diversi
nell’intervento. Se brucia la casa potrò ben pensare che nelle
costruzioni si debbano usare accorgimenti finora tralasciati,
ma intanto bisognerà pure che spenga subito le fiamme.
Anche se siamo ben lontani, ma veramente lontani, dall’avere un
quadro chiaro, ci sono alcuni punti sui quali vale la pena di
fissare l’attenzione, intanto, come è buona norma, andandosi a
rileggere le dichiarazioni dei principali interessati che ci erano
sfuggite nel mare magnum delle informazioni stampate e raccontate
a) Ha ragione Bin Laden (non perché egli sia buono o giusto, ma
perché si tratta di un dato di fatto incontrovertibile) quando
dice – un paio di anni fa, se non sbaglio - che le compagnie petrolifere
hanno portato a casa miliardi di miliardi di dollari. Ma altrettanti
soldi sono rimasti nelle mani delle élites arabe, e Bin Laden
appartiene a queste. La quantità di denari accumulata nelle mani
di alcune porzioni di queste élites è inimmaginabile, come dimostra
la vicenda del Sultano del Brunei. E le operazioni di alta finanza
che hanno preceduto e accompagnato l’11 settembre puntano nella
direzione di gruppi che non sono solo poveri studenti del Corano
armati di Kalashnikov.
b) Non è invece inimmaginabile, anche se al di fuori del mondo
romanzato pochi ci hanno finora veramente pensato, che una parte
di questo denaro sia in mano a porzioni di queste élites che invece
di dilapidarli in scarpe e mogli come il sultano del Brunei, vogliano
usarlo per operazioni di potenza, cioè per fare politica.
c) La politica oggi la fanno anche le multinazionali e il petrolio
è multinazionale per eccellenza. Per non perdere di vista l’inquietante
ma ineliminabile legame tra l’immaginario e il reale, basterà
ricordare che due dei polpettoni dell’estate 2001, quello
di Tom Clancy e quello di Le Carrè, pur assai diversi per trama
e qualità, hanno in comune il vilain principale, una grande multinazionale.
Il romanzo di Tom Clancy è particolarmente interessante perché
l’eroe (diciamo l’Anti-smersh) è una forza speciale segreta nominalmente
internazionale – ma in realtà del tutto gestita dagli Yankees
– non diversa da quella che si sta organizzando oggi. Anticipo
le scrollate di spalle alla citazione di testi non paludati, ma
per capire quel che sta avvenendo occorre anche quella che Jim
Clark deviniva un certo grado di “nuttiness”. Cioè liberarci della
categorie convenzionali.
d) Ci sono focolai spinti di un fondamentalismo, che rimane ancora
largamente inspiegato per ferocia e capacità di sopravvivenza,
in paesi da cui dipendiamo energeticamente come l’Algeria. Ci
sono persistenze inspiegabili come quella di Saddam Hussein. Sfido
chiunque a dare una spiegazione plausibile del perché Saddam sia
ancora lì e che ci facciano i caccia che ogni tanto bombardano
militari e popolazione civile con azioni che le vittime non distinguono,
per ferocia e apparente futilità da quelli alle Twin towers.
e) Anche le multinazionali hanno bisogno di basi statali. Il che
non significa che la guerra venga da uno stato. È noto che le
grandi organizzazioni criminali competono con gli stati per controllare
il territorio e hanno bisogno dei famosi “santuari”, cioè dei
retrobottega in cui organizzare le retrovie. E la scelta dell’Afghanistan
come santuario è eccellente. Ma con tutta probabilità, dal punto
di vista strettamente militare, mentre Sas e Seals sono infiltrati
nel Panshir le squadre per il secondo colpo (o il terzo) sono
già sul luogo di possibili attacchi.
f) L’attacco dell’11 settembre si è proposto di dare una
lezione, non soltanto con il sangue, ma anche con l’eleganza di
una prova filosofica ben riuscita. E oltre che con l’orrore tutti
sono stati colpiti e atterriti anche dalla incredibile lucidità
dell’ideazione e dall’efficienza nella realizzazione. È stata
posta una sfida morale. Perché il suicidio pone una sfida morale
portata all’estremo. Dire così non significa ovviamente né condividere
le motivazioni dei suicidi o dei loro mandanti né lodarli. Ma
chi pensa che si possa vincere questa guerra limitandosi a ripetere
“l’orrore, l’orrore” si sbaglia. I dirottatori, sono stati chiamati
“vili e codardi”, termini usati soprattutto dalla stampa di destra
anche per definire i suicidi dell’Intifada. Ma sono termini sbagliati
che servono solo a confondere le nostre idee e ad accecarci. Come
si può definire vile chi sacrifica la propria vita per una causa?
Possiamo chiamarlo fanatico o criminale (anche se in questo contesto
il termine andrebbe ridefinito) ma non vile. Queste persone sono
degli eroi per milioni e milioni di persone, e trascurare questo
fatto, per dar aria alla nostra indignazione, fa un pessimo servizio
a noi, e non sposta di un micron l’ammirazione degli altri. Mi
ha molto colpito un passaggio del discorso del Presidente della
Camera nel quale l’On. Casini esprime il suo stupore per chi sacrifica
il bene supremo dell’istinto di conservazione per ragioni ideologiche.
Ma un cattolico dovrebbe ben sapere che questo è possibile. L’idea
di testimoniare con la propria vita per una idea l’hanno inventata
i cristiani con i martiri (testimoni) e questi atti figurano così
prepotentemente nel catechismo che mi ricordiobenissimo che c’è
stato un periodo della mia infanzia in cui il mio eroe era Tarcisio
e aspiravo a morire come lui. Non ci vuol molto a comprendere
come in contesti in cui l’esempio del martirio viene raccontato
non da un buon prete di campagna in una società relativamente
pacifica, ma nell’area della disperazione i ragazzini che ammirano
i Tarcisi del caso sono certamente molti e molti quelli veramente
disposti ad imitarli.
g) C’è un atteggiamento tipico dei benpensanti per cui chiunque
si sforzi di esaminare questi fatti senza far ricorso a categorie
convenzionali (il suicida vile e pazzo, le plebi fanatiche dei
musulmani, il diavolo Bin Laden eccetera eccetera) viene trattato
da delinquente. Eppure non ci vuole l’intelligenza e la competenza
di un Cardini (che si aggira sconsolato tra tutti i fogli della
destra per cercare di spiegare qualcosa sull’Islam) per capire
che in questa situazione non c’è nulla di convenzionale e che
se non corriamo rapidamente ai ripari facciamo tutti la fine dei
cavalieri francesi ad Azincourt. La povera Susan Sontag che ha
cercato di sollevare il problema delle motivazioni etiche dei
dirottatori si è subito fatta rimbeccare da Arrigo Cipriani che
peraltro ha solo proposto i soliti insulti, ma non ci ha dato
una spiegazione alternativa. Ma ci siamo dimenticati che
una delle chiavi di volta non solo del successo militare, ma soprattutto
della pace in Giappone è da attribuire al gruppo di Leighton che
studiava le culture a distanza e che consigliò McArthur di non
eliminare l’imperatore? Ricordiamo che ai tempi di Pearl Harbour
i militari americani erano per lo più convinti che i giapponesi
essendo piccolini le avrebbero prese dagli Yankee nel corpo a
corpo (remember judo?).
h) Purtroppo l’indignazione combinata all’ignoranza è una pessima
combinazione per un conflitto rischiosssimo che si annuncia già
più simile a una partita a scacchi che a una operazione di carri
armati nel deserto. E la destra ha già dato fiato alle trombe,
come dimostra il caso del reverendo Falwell che ha dovuto chiedere
scusa. Io non so se dall’altra parte della scacchiera ci sia il
diavolo e di qui l’angelo. Tendenzialmente rifiuto questo tipo
di costruzione che nella storia ha portato più danni che vantaggi.
Ma se c’è un diavolo è uno che sta giocando una partita in cui
noi siamo in svantaggio perché l’avversario ha certamente avuto
molto tempo per preparare parecchie mosse di riserva prima che
noi si capisca lo svolgimento della partita. La creazione
di una opinione pubblica che chiede una “retribution” immediata
a qualsiasi costo è quasi certamente una mossa della partita,
e chi ci cade rischia di farsi mangiare un bel po’ di pezzi prima
di recuperare l’orientamento.
i) Fortunatamente, nonostante tutti gli sforzi di una “destra
con le palle” che ormai parla come un personaggio di Tom Clancy,
in questa partita non c’è contiguità tra la sinistra e i terroristi
e l’operazione maccartista, già in pieno svolgimento, del “guilt
by association” qui non regge. Bin Laden e i Talebani non hanno
nulla neppur lontanamente di sinistra, semmai cercano di costruire
la situazione in modo speculare alle destre nostrane. Come loro
vogliono la crociata e lo scontro di civiltà. Ma la civiltà dei
Talebani è semplicemente un’altra forma di nazismo con il Corano
al posto della Bibbia, o del libretto rosso come nel caso di Pol
Pot. Sono tutti movimenti prodotti da un disadattamento tra modernità
e feudalesimo. Bin Laden è un capitalista feudale che ha i soldi
del petrolio e usa tutte le strutture del più sofsticato capitalismo
globale. Anche i nazisti parlavano a nome delle cristianità (Gott
mit Uns) e si appellavano ai valori dell’Occidente, ma l’Occidente
li ha combattuti in nome di valori universali, non occidentali.
E ha vinto perché c’è stata una alleanza con il comunismo, che
questi valori predicava, anche se i suoi regimi praticavano il
dispotismo. Anche oggi dobbiamo puntare ai valori universali,
e non è vero che il relativismo culturale ce lo impedisce, perché
esiste una dichiarazione universale dei diritti che serve da base
per la leva.
j) Si è detto che l’11 settembre segna la fine della globalizzazione,
ma è una di quelle stupidaggini che suonano bene, ma non dicono
nulla. Semmai un evento come quello dell’attacco alle Twin Towers
è la globalizzazione, dentro alla quale si perseguono scopi diversi
il profitto, il potere, la conoscenza, non meno della vendetta.
Non c’è la “globalizzazione buona” e la “globalizzazione cattiva”
questo concetto è il prodotto del puerile modo di ragionare dei
media, che devono sempre usare un linguaggio infantile. Esiste
un sistema d’accessibilità che crea delle opportunità, che vengono
usate da chi è in grado di impiegarle per i propri scopi. Punto.
L’attacco alle Twin Towers non fermerà il processo di globalizzazione,
non più di quanto le rapine ai treni abbiano fermato la diffusione
delle ferrovie.
k) Non è assurdo immaginare che la guerra di Bin Laden ( o del
califfo virtuale come lo chiama Gianni De Michelis) abbia
per obiettivo il Pakistan, l’Arabia Saudita o, perché no, anche
l’Algeria. La conquista di questi paesi darebbe alla multinazionale
nazi-islamista (non all’Islam) il potere di porre una seria minaccia
al sistema capitalistico mondiale. E al sistema mondiale tout-court.
Per tutte queste ragioni ho l’impressione che le mosse di risposta
all’11 settembre, soprattutto quelle alla Rambo, siano molto al
di sotto della sfida che è stata lanciata e che i vaneggiamenti
o le furbizie che si sono manifestati in queste settimane servano
solo ad accecare e a farci perdere la capacità di elaborare una
politica lungimirante. Può darsi che una azione militare serva
a colpire questo o quel gruppo di terroristi, ma la rete e il
terreno di cultura rimarranno in piedi finché non si elimineranno
le condizioni che le nutrono.
*Sociologo. Docente di sociologia urbana all’università di Milano-Bicocca

Il contrasto
diventi il dialogo
Enrico Menduni*
L'uso pubblico della ragione è difficile quando dall'altra parte
non c'è nessuno con cui trasformare il confronto in dialogo. Non
c'è un nemico. Satana aveva un impero, l'impero del male, poi
prosaicamente è passato in clandestinità. Le Brigate rosse lanciavano
proclami, quelli che i giornali chiamavano "farneticanti".
Gli attentati alle Torri e al Pentagono non hanno rivendicazioni.
Il sospettato Bin Laden nega, e scompare.
L'America ferita richiede una punizione esemplare, una esibizione
di forza, chiede che si faccia qualcosa anche se non sa che cosa
e dubita, nel proprio intimo, dell'efficacia. Bush deve trovare
una testa di turco (interessante metafora) su cui concentrare
le passioni di un popolo e l'Afghanistan dei Talebani si presta
assai bene. I bombardamenti non distruggeranno se non povere case,
nulla cambierà nelle cause profonde del terrorismo, ma ci saranno
e dureranno a lungo. Un gran polverone senza risultati e tanti
morti.
Il concentrato del sacrificio della vita più l'alta tecnologia
mina le basi della nostra convivenza e provoca inquietudini che
ci accompagneranno a lungo. Nulla si fa per capire le ragioni
di tutto questo. Ma non so se il momento sia adatto. Ora tutto
viene travisato, malinteso. Forse ci vorrà del tempo anche per
ragionare.
*Docente di Linguaggio televisivo all’università di Siena

Cambia il
rapporto Usa - Europa
Antonio Missiroli*
È facile dire che il mondo è cambiato l’11 settembre. Meno
facile è immaginare come, in quali possibili direzioni, e con
quali prevedibili effetti. Anche perché il mondo cambierà
soprattutto in base alla risposta che verrà data alla sfida
terroristica. Ad esempio, la solidarietà e la collaborazione
(anche militare) offerte a Washington dagli alleati europei nella
“guerra” dichiarata dal presidente Bush avranno implicazioni
importanti nelle relazioni transatlantiche, soprattutto per quanto
riguarda la sicurezza internazionale. Fino all’attacco contro le
Twin Towers e il Pentagono, infatti, Stati Uniti ed Europa si
erano trovati a dissentire su un numero crescente di temi: dal
protocollo di Kyoto alla non-proliferazione, dallo “scudo”
antimissile all’eurodifesa. I dissensi non erano cominciati con
l’elezione di Bush, si badi. Ma l’approccio adottato dalla
nuova amministrazione americana - il “multilateralismo à la
carte”, come l’ha definito un suo autorevole esponente,
l’ambasciatore Richard Haass – aveva senz’altro accentuato
le divergenze. Gli Stati Uniti apparivano sempre più reticenti ad
assumersi responsabilità complesse (dal Medio Oriente ai Balcani)
e sempre più concentrati su se stessi, dai tagli fiscali alla
difesa strategica.
Lo shock dell’11 settembre ha quanto meno rimescolato le carte.
Innanzitutto, purtroppo, gli Stati Uniti si sono scoperti più
vulnerabili che mai, e ad opera di un aggressore che non ha certo
usato missili nucleari intercontinentali ma, più semplicemente,
le linee aree interne americane: un aggressore assieme primitivo
nella sua violenza e post-moderno nella sua condotta - usando
strumenti civili contro simboli economici e politici - in
un’azione che è stata allo stesso tempo messaggio, mezzo e
fine. Nel dichiarargli “guerra”, gli Stati Uniti si sono
accorti di aver bisogno di collaborazione – anche da parte di
paesi non proprio amici – e di dover perfino svolgere proprio
quel ruolo di “sceriffo globale” che avevano appena dichiarato
di rifiutare. In questo contesto, gli europei hanno fatto la cosa
giusta: hanno offerto appunto una solidarietà incondizionata e un
sostegno invece più mirato, basato anche sulla loro esperienza.
Un’esperienza di lotta, più che di guerra, contro i terrorismi
– al plurale, endogeni come esogeni – che li hanno afflitti
nei decenni passati. Una lotta che puntava più a contenere e a
prevenire (e qualche volta dirottare altrove) il terrorismo
esogeno che a cancellarlo, ben conoscendone le capacità di
rigenerazione, e che accettava un certo livello di vulnerabilità.
Certo, gli europei hanno anche assunto un rischio: quello di
partecipare ad un’azione che difficilmente potranno determinare
in tutti i suoi aspetti e di cui potrebbero comunque subire le
conseguenze. Ma, appunto, hanno presentato agli alleati americani
la loro ‘carte’ del multilateralismo, che comprende
collaborazione diretta, condivisione delle responsabilità e dei
rischi ma anche, sperabilmente, una qualche influenza sul corso
dell’azione comune.
Difficile al momento indovinare cosa accadrà allo “scudo”
antimissile, o alla stessa Nato, soprattutto se sarà chiamata a
svolgere un ruolo militare diretto nella risposta all’11
settembre. Ma è probabile che, se gli Stati Uniti dovranno
trovare un equilibrio diverso fra unilateralismo e
multilateralismo, l’Europa dovrà trovarlo fra protezione e
proiezione, accelerando sia la sua integrazione interna sia la sua
capacità di azione esterna. Ciò vale tanto per le politiche
antiterrorismo - da condurre sempre più su scala transnazionale,
superando le schermaglie bilaterali sull’estradizione e sullo
scambio di dati - quanto per le operazioni di mantenimento della
pace. È quasi inevitabile, infatti, che l’impegno americano
nella “campagna” (forse il termine più appropriato) contro il
terrorismo finirà per lasciare sempre più l’Europa agli
europei - a cominciare dai Balcani - rafforzando in questo caso,
più che modificando, una tendenza già in atto, ad esempio in
Macedonia. Per diventare un attore internazionale degno di questo
nome e un partner credibile per gli Stati Uniti, l’Europa sarà
dunque costretta a fare i conti con le sue esitazioni e incoerenze
interne – il che non significa necessariamente che vi riuscirà.
* Ricercatore presso l’Institute for Security Studies, Western
European Union (Ueo - Unione Europea Occidentale), Parigi.

Uno scontro tra cattivi?
Stefano Nespor*
“All’improvviso, ho visto un missile contro il palazzo,
tutto ha preso fiamme, ho visto gente che si buttava fuori dalle
finestre e cadere, cadere; poi l’edificio è crollato. Sono
morte centinaia di persone”.
Non stiamo parlando del World Trade Center.
Questa è la deposizione di una donna che ha assistito alla
distruzione di un condominio residenziale nel centro di Panama
City, colpito da un bombardamento durante l’attacco degli Stati
Uniti, per ordine del presidente Bush (il primo), per catturare il
presidente\delinquente Noriega, portato al potere dagli stessi
Stati Uniti in precedenza. Vi ricordate di Panama, o televisione e
quotidiani non ne hanno parlato abbastanza?
È stato un atto di polizia, di autodifesa, di aggressione, di
guerra o di terrorismo?
Certamente, non è stato un caso isolato.
Questo significa che non siamo in presenza di uno scontro tra
buoni e cattivi. Siamo in presenza di uno scontro tra cattivi,
anche se di diverso grado e intensità.
Chi perde, in questo scontro, gli sconfitti, le vittime, sono
sempre gli incolpevoli.
A Panama, al World Trade Center e con buona probabilità in
Afganistan.
Eppure, il terrorismo e l’attacco al Wtc non sono la
conseguenza della politica militare, economica, ambientale degli
Stati Uniti?
Il terrorismo e l’attacco al Wtc sono molto di più. Sono un
attacco al pensiero occidentale, allo stato di diritto, all’idea
non tanto di libertà quanto di tolleranza che il pensiero
occidentale ha faticosamente conquistato, dopo secoli di guerre di
religione e di contrapposti fanatismi. Sono questi i valori che ai
fondamentalisti religiosi (non necessariamente fanatici, e non
necessariamente islamici) non piacciono.
È uno scontro non di politiche, ma di religione Bush (il secondo)
lo ha capito e per questo ha detto che Dio è con noi
(rispolverando parole in disuso dalla prima guerra mondiale).
Il Wtc marca qualcosa che tutti avevamo più o meno
sottovalutato (e che la Gran Bretagna ben aveva compreso nel XIX
secolo, allorché aveva perseguito l’obiettivo primario di
mantenere l’Europa continentale frazionata), e cioè la fragilità,
l’instabilità e l’imprevedibilità di un sistema monopolare
di governo del mondo.
*Avvocato

“Impariamo
a conoscerci”
Sergio Noja Noseda*
Mi ha sinceramente colpito la chiarezza della domanda-affermazione
di Reset nell’invitarmi a scrivere queste poche righe sugli
avvenimenti – gli aggettivi, pur centrati, si sprecano – dell’11
settembre 2001 .
Sì, gli attentati di quel giorno hanno modificato la nostra ordinaria
visione del mondo . Senza analizzarne le ragioni non fu tale il
bombardamento di Guernica, podromo tecnico alla distruzione di
Coventry e ai bombardamenti su Londra. Questi furono solo esempi
per l’ avversario: gli aerei alleati risposero con lo stessa tecnica
su Dresda e le altre città tedesche e in minima parte anche su
quelle italiane. Ma la coscienza della nostra civiltà , e secondo
me di tutte le civiltà disegnate dall’Huntington , compresa, è
bene dirlo subito, quella islamica si rifiuta di imitare quell’esempio
riempendo di missili edifici ed inermi cittadini .
L’incredibile infausto momento che abbiamo vissuto mentre gli
stragisti, che si suppongono di matrice islamica, uccidevano con
la loro pazza azione combinata migliaia di americani ignari di
cosa stava accadendo: dal super manager davanti alla sua scrivania
onusta di video terminali alla donna delle pulizie con il suo
carrello carico di scopette e di detersivi, non mi fa deviare
di un millimetro da ciò che ho lentamente elaborato nel mio pensiero:
l’Islam non è solo una religione ma una civiltà con tutti gli
estremismi del pensiero, estremismi che all’uomo risalgono e non
al mondo nel quale è stato educato e vive tanto è vero che anche
le efferatezze naziste fanno parte della civiltà europea. L'Islam
caratterizza con questo nome tutto ciò che congloba: lo si può
addirittura vedere come uno stato più che una religione nel senso
che ormai diamo in occidente a quest’ultimo termine e tutto ciò
di quel mondo è figlio e da quel mondo promana va chiamato "islamico".
L’Islam è una civiltà che nasce dalla religione islamica, come
la civiltà occidentale deriva dalla religione cristiana. Ma la
civiltà occidentale contiene in sé Voltaire come Hitler. E così
l’Islam è una civiltà composita, articolata che al suo interno
contiene anche un grande poeta come Abu-Nuwas che, come altri,
cantava il vino, proibito dalla religione. La religione islamica
è una religione di Legge, legge divina naturalmente. Alcuni Stati
all’interno di questa ecumene hanno stabilito che l’unica legge
in vigore sia la legge divina. Ma questo nulla ha a che vedere
con gli attacchi terroristici scatenati contro l’America. Il giovane
che uccise il generale Kléber durante la ritirata dei francesi
in Egitto, lo fece su un preciso disegno "politico"
che a lui era stato spacciato per religioso".
Confondendo gli stragisti ( sono orgoglioso di usare questa parola
coniata da Montanelli su “Il corriere della sera” e ristampato
su “Oggi” del 19 settembre nel nobile tentativo, riuscito solo
in parte, di eliminare dalla nostra lingua “bombarolo” e “kamikaze”:
bombarolo è sparito ma kamikaze è sopravvissuto) di New York e
di Washington , ancorché nati nell’Islam, musulmani e ispiratisi
all’Islam, con la civiltà islamica si commette un errore madornale.
Basta pensare che solo un piccolo numero di abitanti dell’Africa
è cannibale !
L’Occidente non cada nella trappola dello scontro fra civiltà.
Samuel Huntington ha fatto un bellissimo lavoro nel disegnare
le civiltà ma ha commesso l’errore di porre nel titolo del suo
libro la parola clash ovvero ‘scontro’.
Sono sempre stato convinto, ed oggi più che mai, che questa parola
vada sostituita con "contrapposizione", sfida, competizione,
che non necessariamente devono essere armate. Il pericolo risiede
ancora nell’ignoranza, perché le masse arabo-musulmane vivono
per quello che gli hanno trasmesso e insegnato gli avi e oggi
i media e non per quello che realmente è la nostra e al limite
la loro civiltà".
Si parla tanto di aggressività della “civiltà islamica”. Certamente
lo è ma nel senso che intende portare l’Islam al mondo, cioè convertirlo.
Ma questa non è prerogativa dell’Islam: anche la religione cristiana,
infatti, è missionaria, tende al proselitismo, cosa che non è,
per fare un esempio, la religione ebraica. Ci sono peraltro religioni
missionarie, come quella buddista, che non prevedono la lotta
armata: i tibetani erano un popolo guerriero e crudelissimo ma
che, convertito al buddismo, è diventato un popolo pacifico e
pacifista.
Non possiamo praticare oggi quella che una volta, buona per lo
spirito dei tempi, fu "la politica delle cannoniere"
di sua Maestà Britannica. Non possiamo usare la tragedia di Manhattan
per regolare i conti con l’Islam, fosse anche solo con la sua
parte più radicale. È questo, ancorché capace di cambiare il modo
di fare la guerra su base planetaria , il comportamento di un
limitato numero di persone fondamentalmente in malafede, rispetto
all’Islam – ma anche da noi: chi non ricorda il film Il Dottor
Stranamore ? - e che, come molte volte nella sua storia, hanno
strumentalizzato la religione per fini di potere. Questo anche
e proprio all’interno dell’Islam dove la religione è stata spesso
e volentieri strumentalizzata da gruppi di potere per uno scontro
politico alla mors tua vita mea tra le varie fazioni. A ciò va
aggiunto che oggi la cosiddetta “Guerra Santa” - tralascio le
spiegazioni pseudo-filologiche – è una “bufala” che piace molto
in occidente a chi ama vedere l’Islam fatto di minareti, lune,
e cammelli mentre l’Islam ha imparato a gestire sofisticatissime
tecnologie con una fantasia e una creatività andata al di là di
ogni nostra , purtroppo statica , immaginazione.
Entrando nel particolare vi è un grosso – uso quest’aggettivo
per dire che il fenomeno è più “grossolano” che “grande”’ – ostacolo
che non è facile rimuovere: quello della “conoscenza reciproca”
.
Di qui e di là, diciamo del Mediterraneo, si studia poco l’altro
e comunque di più in Occidente l’Islam di quanto non si studi
l’Occidente in Oriente.
Gli è che le Chiese cristiane si sono sempre occupate, e a loro
modo a ragione, di essere missionarie e di mostrarsi felici della
conversione dei musulmani . Il materiale pubblicato nei secoli
è stato ed è sempre missionario. Basti pensare che questi libri
nelle lingue dell’Islam, massimamente l’arabo, furono sempre stampati
a Roma in dimensioni ridotte per essere occultati in dogana e
che, quando nel 1922 si parlò di “repubblica” nell’ex Impero Ottomano
la stampa cattolica si aspettò milioni di convertiti che, con
tristezza in Vaticano, furono solo due!
Rimanendo in questo campo le difficoltà corrono all’ estremo con
il cosiddetto “colloquio tra le religioni” portato avanti dal
Vaticano a Roma con il Pisai, il Pontificio Istituto di Studi
arabo islamici, e da molti vescovi come a Milano con il misero
caso del Cadr, il Centro Ambrosiano di documentazione per le religioni
. Ancora una volta si batte sul tasto “religione” - anche se la
prima frase del documento illustrativo del Cadr dice “alle soglie
del terzo millennio, l’incontro fra le diverse culture e tradizioni
rinnova il volto delle società -- e non su quello della “civiltà”.
Tra le religioni non si può e non si deve “dialogare”. Questo
è il mio pensiero. Ogni dialogo porta con se sempre una nube ove
si nasconde , e anche malamente, un “tentativo di conversione”
.
L’unica possibilità di dialogo è uno sforzo dei governi e delle
istituzioni ad esso legate per promuovere la conoscenza reciproca
senza parlare di religione. E qui vedremo .
*docente di Lingua e Letteratura araba presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano

La
democrazia come la dittatura?
Corrado Ocone*
Abbiamo visto, in questi giorni, tante immagini. E abbiamo letto
tanti commenti e interpretazioni. I punti fermi alla fine, a mio
modo di vedere, sono pochi. Ne enuclerei sostanzialmente due:
l’attacco alle Torri Gemelle di Manhattan è forse il primo
eclatante episodio di un nuovo tipo di guerra (new war), che io
chiamerei la guerra postmoderna; l’Occidente, o ciò che
approssimativamente chiamiamo tale, si è trovato sprovviste di
armi concettuali e pratiche atte ad affrontare questo nuovo tipo
di guerra.
L’attentato di New York è, per vari motivi, qualcosa di più di
un tradizionale atto terroristico. Ma è pure, da un altro punto
di vista, qualcosa di meno, o meglio qualcosa di diverso, da una
guerra, o almeno dalla guerra come siamo abituati a concepirla.
Rispetto ai tradizionali atti terroristici, quello dell’11
settembre presenta caratteristiche nuove. Ha destato meraviglia il
fatto che i terroristi abbiano dimostrato una profonda maestria
nell’utilizzo delle più sofisticate possibilità offerte dal
progresso occidentale ( possibilità tecniche, economico-
finanziarie, di comunicazione mediatica). Ma è secondo me
importante sottolineare anche il fatto che, almeno fino ad oggi,
sia mancata, da parte dei terroristi, una formale
rivendicazione dell’attentato: che anzi i talebani abbiano
detto: “all’America ben gli sta, ma non siamo stati noi”. La
strategia di chi ha colpito è quella di seminare panico, di
diffondere paura, di generare incertezza. Di trasmettere un
messaggio ambiguità: un messaggio insieme di lontananza (“siamo
diversissimi da voi”), ma anche di vicinanza (“siamo fra voi,
stiamo assediando la vostra cittadella che nonostante tutta la
vostra potenza non è affatto così sicura come credevate” ).
I terroristi uniscono l’estremamente arcaico di
un’interpretazione quasi “rurale” della religione con
l’estremamente contemporaneo del sapersi muovere con destrezza
fra i nostri più raffinati e sofisticati strumenti. D’altronde
il postmoderno è proprio questo: la capacità di muoversi fra
vecchio e nuovissimo, fra locale e globale, fra misticismo e
razionalismo astratto.
Le domande che ora sorgono sono tutte inquietanti: ammesso e non
concesso che Bin Laden sia l’unico mandante dell’operazione,
quanti Bin Laden potenziali o reali, quanti stati e quante
organizzazioni intra e interstatali, possono presto agire con
uguale impeto e forza? E il fatto stesso che l’impensabile sia
accaduto non allarga per ciò stesso lo spettro delle possibilità?
E come può l’America colpire un nemico che, anche se distrutto,
può riemergere come un araba fenice (nomen omen) in un altro
posto; che, come è stato detto, non è solo altro da noi ma anche
fra noi (studia nelle nostre università, fa affari con noi,
conosce meglio di noi le tecniche della comunicazione simbolica e
politica)? E un eventuale attacco all’Afghanistan come può
essere di esempio se in molti non temono, anzi cercano, la propria
morte e la morte della gente comune? Si consideri a tal proposito
un fatto: se la morte dei civili era nelle guerre antiche rara; se
poi nel “secolo breve” è diventata un semplice “effetto
collaterale”, detestabile ma comunque da mettere in conto; ora,
nella nuova guerra, nella guerra del nuovo secolo, i civili sono
di proposito l’obiettivo che si vuole colpire. E perciò, come a
New York, si colpisce dove ( come nei grattacieli ) ve ne sono di
più. Noto en passant: un misticismo religioso così radicale non
è poi tanto lontano dal nichilismo cinico di tanti giovani
occidentali, di tanti gruppi da “Arancia meccanica” che per
noia o indifferenza, senza un motivo, uccidono.
Cosa fare? Come agire? Quali alleanze deve cercare chi finora ha
creduto nella ragione e nel liberalismo e vuole continuare a
credervi anche nella postmodernità?
Per agire, secondo me, dobbiamo iniziare a capire. Comincio con
l’osservare, a tal proposito, che una volta tanto Berlusconi ha
ragione (d’altronde non c’è da preoccuparsi nel dare ragione
al Cavaliere: i leader politici tutto sommato contano poco e
passano, mentre i valori rimangono). La civiltà occidentale è
superiore alle altre: non diversa, ma superiore. Solo se anche noi
di sinistra avremo il coraggio di dire ciò, di dirlo a voce alta,
avremo un futuro.
Capiamoci. L’Occidente ha commesso e commette non solo tanti
errori, come qualsiasi individuo o aggregato di individui, ma ha
commesso e commette continuamente nefandezze e porcherie. Ma il
problema è un altro. In certi casi, se si vuole comprendere a
fondo qualcosa, bisogna tenere rigorosamente distinto l'ambito
empirico da quello ideale. E, sul terreno ideale, l’Occidente,
ripetiamolo, è superiore. Il suo principio è infatti etico:
l’Occidente promuove sempre in primo luogo il dialogo, il
confronto, la soluzione ragionata, persino l’onorevole
compromesso. Di fronte all’altro da sé l’Occidente inteso
come concetto ideale non si pone mai, all’inizio, di petto, ma
sfodera subito le armi della critica e dell’argomentazione. Dal
diverso trae fuori tutto quanto è accettabile e condivisibile e
lo metabolizza. Trasforma l’altro e ne è trasformato.
L’Occidente non è un’ipostasi, non è nulla di statico, non
è un insieme fisso di valori. E’ piuttosto un insieme di valori
in continua trasformazione. Ma di valori appunto si tratta. Ha
ragione Panebianco ahimé (anche questa volta bisogna dar ragione
a chi spesso non ci convince). Il nemico dell’Occidente è il
relativismo, cioè un modo falso di intendere i suoi valori. Che
sono valori forti e che vanno fortemente difesi, anche se sono i
valori del pluralismo, della tolleranza, della democrazia.
L’Occidente non può porsi in modo paritario verso il suo
contrario né verso chi ritiene che tutto sia uguale, la
democrazia come la dittatura. L’Occidente offre spazio al
diverso, il suo contrario lo demonizza. Per poter continuare a
dare spazio al diverso l’Occidente deve perciò combattere il
suo contrario.
D’altronde, il fatto stesso che tanti antioccidentali a buon
mercato siano fra gli abitanti dell’Occidente, soprattutto fra i
giovani, è un segno della sua forza: l’Occidente dà così
tanto spazio alla critica da permettere che persino i
superficiali e gli irriflessivi dicano la loro. Sarebbe però
auspicabile che almeno le élites intellettuali abbandonino una
volta tanto la facile strada del “politicamente corretto” e
che comincino a ragionare senza atavici preconcetti. Nell’arte
del capire, cioè nella messa in opera della sua essenza più
profonda, consiste l’unico contributo che l’Occidente può
dare in questo momento.
Il sapere può dare un importante contributo alla battaglia che
tutti combattiamo, e va da tutti accuratamente coltivato. Ancora
una volta è però essenziale che siano i chierici a dare
l’esempio e a non tradire.
*Giornalista 
Meno libertà
per tutti
Massimo Paci,*
Ripensare a quanto è successo è già un momento
di sconcerto e la prima osservazione non può che essere
personale: in queste poche settimane io stesso ho subito una sorta
di riposizionamento etico-pratico e vedo come misere e insignificanti
alcune questioni della vita quotidiana che prima mi sembravano
momenti cruciali della mia vita o grandi temi, grandi battaglie
sulle quali spendersi, compresi i difficili e complessi consigli
di amministrazione del grande ente che oggi presiedo, l'Inps.
Ma queste incombenze quotidiane mi appaiono ben diverse, oggi,
dai problemi di fondo del mondo d'oggi: è come se mi risvegliassi
da una situazione d'assenza dei valori fondamentali dell'esistenza.
Bisogna che noi tutti rimettiamo nel giusto e dovuto ordine le
cose, anche noi scienziati, intendo.
Del resto, se il distacco dalle cose minori della vita è
proprio dello scienziato, bisogna capire di quale scienziato stiamo
parlando. Lo scienziato classico (il filosofo o il naturalista)
osserva le cose senza lasciarsi coinvolgere (è un classico
l'esempio del "naufragio con spettatore") con un atteggiamento
che può portare a guardare a un terremoto come inevitabile
conseguenza degli sconvolgimenti naturali (come Plinio il Vecchio
davanti alla distruzione di Pompei). Poi c'è un altro tipo
di scienziato, quello sociologico, che ha una visione altrettanto
distaccata, ma meno coinvolta dalla politologia o dalla storia
perché studia la scienza del comportamento irrazionale
degli uomini, la scienza degli effetti inattesi. Il sociologo
non è un osservatore neutrale, ma partecipante e lo sforzo
dovrebbe essere proprio quello di riuscire a capire cosa succederà
adesso e quali effetti avranno sul futuro le risposte che cerchiamo
di dare. Ecco, ad esempio io credo che la guerra sia una risposta
sbagliata in quanto non c'è un esercito nemico evidente
da combattere, ma credo anche che le restrizioni alle nostre libertà
saranno sempre maggiori. Il crollo dei consumi, persino la limitazione
di certe forme di pubblicità, che è uno degli effetti
di questa guerra, anche forme salutari di autocontrollo e di autoriduzione
dei propri sprechi, si accompagna però ai rischi di una
popolazione civile limitata e autoregolamentata nelle proprie
scelte. Controlli sempre più stringenti sugli aerei, negli
stadi, persino nella circolazione automobilistica, limitazione
alla privacy negli Usa, l'introduzione della carta d'identità
nel Regno Unito, alcune tentazioni censorie presenti persino nel
nostro Paese, rischiano di essere un rimedio peggiore del male
e non aiutano a fare il vuoto attorno ai terroristi ma aumentano
il controllo occhiuto dello Stato sulle vite delle persone e spingono
i cittadini a chiudersi a doppia mandata a casa propria. Del resto,
è lo Stato stesso - nella sua concezione classica, nazionalistica,
territoriale - che non è in grado di combattere un terrorismo
che è ovunque, che si riproduce su scala mondiale, mentre
il pericolo di un'involuzione radicale delle libertà nella
società moderna si fa, anche grazie a questi tragici fatti,
via via più concreto. Temo che questo attitudine al controllo
dall'alto non potrà che crescere e dunque il terrorismo
finisce per manifestare il suo vero volto, quello di strozzare
la "globalizzazione buona", che ne esce sconfitta. Dunque,
avremo più barriere e più controlli, si ridurranno
la mobilità delle persone e lo scambio d'informazioni.
Una catena di effetti perversi e inattesi, è la dote del
terrorismo, e pericolosissima.
*sociologo e presidente dell'Inps
La ragione
democratica
Gianfranco Pasquino*
Dove come quando abbiamo sbagliato noi occidentali, democratici,
progressisti? E, adesso, possiamo rimediare, e come? Sì, credo
che quello fra il mondo arabo-musulmano e l’Occidente sia effettivamente
uno “scontro di civiltà”. Non è tale perché si contrappongono
due religioni, l’islamismo e il cristianesimo, che entrambe contengono
radicati pericolosi sanguinosi fondamentalismi. E’ tale, invece,
nell’accezione più pregnante di civiltà: usanze, credenze sociali,
aspettative, comunioni di storia e memoria, stili di vita.
A fatica e mai completamente, in Occidente siamo
riusciti a separare la politica dalla religione e a renderla un’attività
per lo più autonoma dai dettami religiosi e da coloro che, purtuttavia,
continuano a pretendere di dettare i comportamenti. Non mi risulta
che l’interpretazione prevalente del Corano consenta, faciliti,
accetti la separazione fra politica e religione.
A fatica e incompiutamente, in Occidente siamo riusciti
a costruire sistemi politici nei quali il potere viene affidato,
temporaneamente, a chi vince le elezioni, e viene utilizzato secondo
regole precise che stabiliscono, fra l’altro, che l’opposizione
deve avere suoi spazi e non deve mai essere eliminata. Non mi
risulta che esista un solo Stato arabo nel quale il potere è stato
acquisito da governanti che hanno vinto libere elezioni e nel
quale gli oppositori hanno qualche possibilità e qualche probabilità
di conquistare pacificamente il potere di governare.
A fatica e contraddittoriamente, in Occidente abbiamo
esteso i diritti civili, politici e sociali a tutti i cittadini
e, spesso, anche ai non-cittadini. Non mi risulta che esista eguaglianza
di diritti in nessuno Stato arabo persino a prescindere (ma perché
mai?) dalla deplorevole condizione delle donne in Afghanistan,
in Iran, in Arabia Saudita. In Occidente critichiamo le inadeguatezze
dei nostri sistemi politici e dei nostri governi e le violazioni
che continuano ad avvenire, e di cui siamo acutamente consapevoli,
in nome di principi e di criteri formulati in Occidente, ma che,
in qualche modo, possiamo oramai considerare universali. Non è
certamente un caso se, dal Pakistan di Benazir Bhutto all’Algeria,
dall’Egitto alla Birmania del Premio Nobel Aung San Suu Kyi, gli
oppositori facciano costante e tenace riferimento ad una concezione
di democrazia, di diritti, di giustizia sociale che è nata in
Occidente ed è, anche grazie a loro, diventata universale.
Condividendo questi principi, questi diritti, queste
concezioni noi europei e americani, perché non abbiamo provato
ad esportarli? Abbiamo forse sbagliato nel pensare che “loro”,
gli altri, gli arabi hanno tradizioni che debbono essere rispettate,
che sono ugualmente valide, anche quando mutilano le loro donne,
lapidano gli adulteri, tagliano mani e teste a ladri e oppositori?
Abbiamo forse sbagliato a pensare che non esistano effettivamente
diritti umani universali? Abbiamo forse sbagliato a disinteressarci
perché, in fondo, era un problema loro, dell’arabo della strada,
quello di detronizzare elites corrotte, violente, ingiuste che
si appropriano di tutte o quasi le ricchezze dei loro paesi e
mantengono le “loro” masse in uno stato di impoverimento brutale
per meglio asservirle e manipolarle? Crediamo, in maniera etnocentrica,
che quei popoli non siano capaci di costruire e praticare la democrazia?
Siamo assertori di un deprecabile e fallimentare relativismo etico
e culturale?
Per fare un buon uso collettivo della ragione, credo
che dovremmo cominciare a discutere del valore universale della
democrazia, dei diritti, della giustizia sociale (magari sapendo
e dicendo che le società giuste sono abitualmente molto più sviluppate
delle società ingiuste). Dovremmo abbandonare un malposto, malformulato,
fuorviante etnocentrismo che è, in effetti, razzismo, più o meno
consapevole (noi, sì, sappiamo fare funzionare una democrazia,
loro, no, non sono adatti). Senza rinunciare alla punizione dei
terroristi, che è un principio cardine dei sistemi giudiziari
di qualsiasi democrazia, dovremmo lanciare una potente e pressante
offensiva diplomatico-culturale. In assenza di una critica delle
idee rimarrà soltanto la critica delle armi. Si giungerebbe ad
uno scontro di fondamentalismi, che sono l’esatto contrario del
ragionare discreto, argomentato, prolungato che l’Occidente ha
imparato spargendo per secoli il suo sangue, il sangue dei suoi
dissenzienti, dei suoi democratici.
*Politologo

Il centro
e la periferia dell’Impero
Pasquale Pasquino*
La mattina dell’11 settembre stavo andando al mio ufficio nella
School of Law della New York University, dove insegno, quando la
torre est del World Trade Center mi è scoppiata davanti agli
occhi. Ci ho messo più di qualche ora a capire che la combustione
del carburante dell’aereo aveva prodotto una temperatura di 2000
gradi, e che ne bastano mille per fondere le putrelle d’acciaio,
che sostenevano l’impalcatura delle Twin Towers.
Quando allo stupore dinanzi al crollo si è sostituito l’orrore
per i morti sono scappato a casa di un amico non per paura, ma per
il bisogno insopprimibile di non essere solo e di poter parlare
con qualcuno di ciò che stava accadendoci addosso.
Nei giorni che hanno seguito l’attentato terroristico a New York
abbiamo diviso il tempo fra il forzarci a riprendere, al più
presto ed al meglio, le nostre attività quotidiane ed il parlare
di quello che, in un terso mattino d’estate, aveva stralunato le
nostre vite.
La prima reazione è stata, insieme ai gesti della solidarietà,
la parola. Non solo come tentativo di articolare una risposta
razionale agli eventi, ma come un mezzo di sfogo delle paure, di
condivisione delle angosce, di tentativi, confusi, dolenti o
furiosi di anticipare lo sviluppo degli eventi.
Ieri sera, però, il paese si è fermato e si è messo
all’ascolto. Il 20 di settembre, il Presidente Bush ha parlato
dinanzi al Congresso per l’America; e, volenti o nolenti, questa
è ormai la voce che riassume per il prossimo futuro la volontà
della nazione colpita.
G.W. Bush ha parlato il linguaggio del primo impero senza più
frontiere. Michael Walzer, una delle voci più limpide della
cultura liberale americana, ha richiamato stamattina sulle colonne
del New York Times la necessità in questo momento di definire il
"campo di battaglia" di una strana guerra che non
conosce frontiere. A me sembra che il carattere saliente di questo
scontro sia che esso proviene al tempo stesso dal centro e dalla
periferia dell’impero. Dall’interno degli Stati Uniti, perché
è qui che vivevano i terroristi che hanno abbattuto il World
Trade Center ed è in questo paese che hanno imparato a guidare
gli aerei, usati nel loro attacco come missili da guerra contro i
simboli del nostro mondo. Dalla periferia, perché non c’è più
un luogo altro, come negli anni della guerra fredda e fino alla
fine dell’illusione comunista, che identifichi un’alternativa
possibile alla nostra concezione della civiltà, un altrove con
cui l’occidente debba misurarsi, fare i conti o proteggere
frontiere comuni. Nemmeno la Cina pseudocomunista rappresenta più
un’alterità di questo genere, affaccendata com’è a costruire
la sua versione predemocratica di una società di mercato.
Sono rimaste ai confini dell’impero solo lande desolate: le città
morte dell’Afganistan, i milioni di poveri cristi oppressi dal
tiranno di Bagdad, i palestinesi abbandonati a loro stessi in
Cisgiordania e nella striscia di Gaza. E altri luoghi di
inenarrabile miseria, dai villaggi del Magreb alle baraccopoli dei
più poveri fra i paesi abbandonati da dio e dagli uomini.
Questa periferia dell’impero soffre, sempre, in silenzio come
nell’Africa nera. Essa talvolta maledice e brucia le nostre
bandiere; raramente produce, purtroppo per noi e per loro, una
forza d’odio che va oltre la soglia della vita, nutrendo squadre
di dannati che gridano di nuovo, contro di noi e contro se stessi,
il vecchio ritornello di "viva la muerte".
Il nemico dell’occidente è questa palude infetta dove si
confondono povertà materiale, miseria morale di ogni specie, e
l’assenza feroce di ogni speranza.
L’impero colpito, e sia chiaro che io con esso io mi identifico
perfettamente, ieri sera ha ruggito ed è pronto oggi a combattere
ed a pagare il prezzo di una lotta lunga e difficile contro gli
insetti feroci che infestano la palude e che portano altrove, fino
alle nostre case, la peste della morte nostra e loro. E certo
questo combattimento di emergenza è dolorosamente inevitabile.
Anche se nessuno ci può promettere che sarà condotto in modo
intelligente ed efficace.
Ma se la palude non sarà bonificata, se le lande non verranno un
po’ alla volta ricoperte di alberi, se la nostra ricchezza non
diventerà, in qualche misura, anche la loro, se gli sbatteremo in
faccia le porte della speranza, ai nostri figli e ai figli dei
nostri figli capiterà di dover dire: guai a noi, per colpa di
quei nostri padri che hanno vinto.
* Docente alla School of Law della New York University. 
Il sapere, un bimbo che
deve crescere
Luigi Pedrazzi*
Di fronte al terrorismo, che dall’11 settembre sembra divenuto
una potenza mondiale di tipo nuovo, e alla guerra crociata che
gli Usa si propongono di condurre cercando l’appoggio di una larghissima
e difficile alleanza internazionale, la vostra domanda, coraggiosamente
(o ingenuamente?), chiede quale sia il valore del “sapere” .
Modestissimo, direi, almeno al fine di preparare e dirigere azioni
politiche. Altri aspetti dell’interiorità umana, molto diversi
qualitativamente dal sapere (la paura, il pregiudizio, le abitudini
comode, l’ambizione, l’arroganza ideologica, i calcoli di interesse)
prevalgono nel determinare le decisioni umane, senza che
sia utilizzato gran che del sapere esistente: quel sapere che
già è in atto nella mente degli uomini più riflessivi, o sta disseminato
silenzioso nelle nostre biblioteche, o oggi è potenzialmente accessibile
in migliaia di siti, file, link. Per tacere dei cuori che sono
sapienti per l’esperienza del dolore e della semplice bontà di
voler bene al prossimo.
Sono prevalenti tra noi decisioni che utilizzano solo un minimo
del sapere esistente (e quasi nulla della fraternità sperimentata):
Esse prendono forza piuttosto dalle ondate delle emozioni e si
incanalano in improvvisazioni sovente pericolose: avviene ad opera
di singoli uomini, nell’ambito delle loro responsabilità private,
e, in misura ancora più abbondante, ad opera delle persone che
hanno responsabilità pubbliche, al vertice delle nostre istituzioni,
sotto la pressione di tanti “sondaggi” delle opinioni: con conseguenze
pesantissime, quali emergono in tempi medi e durano poi a lungo.
Anche per questo il “sapere”, tra noi, è sempre un bimbo che deve
crescere, aspettando che nella storia prendano un volto più adulto
gli eventi che di continuo entrano nel nostro cronotopo, talvolta
con una irruenza che lacera schemi a lungo prevalenti. Oggi,
in particolare, dobbiamo riconoscerci in attesa di “aggiornamenti”
indispensabili.
La potenza terroristica che ha organizzato l’attacco agli Usa
teletrasmesso al mondo l’11 settembre dalla organizzazione mediatica
che ci avvolge, ripeterà altri attacchi? Dove localizzati? Con
quali esiti?
O dovranno passare molti mesi e anni, prima che un 11 settembre
si ripeta? E , allora intanto, la guerra crociata di Bush ne prenderà
il posto nei media, con tutte le sue vicende e le sue canzoni?
La grande guerra americano –internazionale, già dichiarata ma
per ora combattuta solo con un raffica di cento annunci, si svolgerà
davvero per anni contro il terrorismo internazionale, che ha nel
fondamentalismo islamico la sua internazionale, la sua cellula
staminale? Salderà con i suoi dolori, e qualificherà con le sue
vittorie, un diverso ordine internazionale, necessariamente più
pluralistico e più equilibrato di quello di ieri e di oggi? O
svelerà che gli Usa, nonostante tutto, sono un gigante d’argilla
zeppo di illusioni, e quindi un vero ordine internazionale
arretrerà quasi all’anno zero?
O, restano del tutto lontani da sviluppi di tipo “pluralistico”,
la celebrazione e la verifica dei rapporti di forza prodotti dalla
guerra e dai suoi risultati obiettivi, confermeranno che l’attuale
fase storica è tutta nel segno del primato statunitense e della
prima egemonia culturale, oltre che economica e militare?
Gli interrogativi, in attesa della risposta dei fatti che saranno
davvero compiuti dai protagonisti in campo, sono troppo numerosi
e densi di alternative radicali per caricare il “sapere” di cui
disponiamo di un valore con qualche analogia con la scienza. Non
a caso, siamo del tutto privi di poteri previsionali e ordinatori,
che ci mettono in grado di esprimere giudizi affidabili in dimensione
storica: oggi inutilmente evocata dai media quotidiani, fastidiosamente
loquacissimi.
Quanto a giudizi etici di qualche dignità, li possiamo attingere
solo congiungendo le informazioni essenziali con il piccolissimo
patrimonio di onestà e di equità di cui eventualmente riusciamo
a disporre nei confronti dei popoli e continenti.
Con buona pace dell’ottimismo di Bacone, il sapere e l’informazione,
di per sé, non ci consegnano nessuna “potenza”: anzi, ciò che
veramente si sa già , se lo guardiamo in volto, ci consegna piuttosto
ad una grande debolezza pratica, sostenibile con l’abito dell’umiltà
piuttosto che con la divisa del coraggio e delle sfide gridate.
È vero: quanto è avvertito l’11 settembre va condannato
come inaccettabile e irripetibile.Va posto fuorilegge, come è
già fuori mercato. Ma la ricerca, l’arresto e la punizione dei
colpevoli di quel crimine esige un ordinamento giuridico, o almeno
una capacità di accordi, mediazioni, progettazioni e operazioni,
che lo stesso Bush, pur gettato e proiettato ad agire da un dolore
nazionale enorme, ha indicato non percorribili in tempi brevi:
ma allora, con quali energie morale con quali poteri istituzionali
ne potremo sostenere una praticabilità necessariamente lunga?
E la sua dinamica, a quali modelli giuridici darà luogo nel suo
svolgimento? Tra sei mesi, o dodici, o diciotto, saremo più forti
nell’alleanza che gli Usa propongono all’Occidente di allestire
e gestire nel mondo?
È possibile, anche se tutt’altro che sicuro. In questo caso, fortunato
o assolutamente il più augurabile, sarà cresciuta la sola egemonia
della forza americana o, augurabilmente e solo sorprendentemente,
avremo anche visto svilupparsi un profondo riequilibrio internazionale?
In questo ultimo e migliore caso, cose nuove dovrebbero consolidarsi,
di grande interesse, tra Usa e Russia, tra Nato e Ue; in Medio
Oriente, tra arabi ed ebrei; nel mondo e all’Onu, tra ricchi e
poveri; con le religioni che assumono in comune un ruolo grande
di pace, in tutte crescendo la distanza dall’errore integralista
e dall’eresia fondamentalista. Sarebbe di fatto, una sorta di
rifondazione dell’Onu, per aver finalmente una istituzione adeguata
ai bisogni crescenti di legalità e parità del genere umano.
Ma se, invece Dio non lo permetta, le cose dovessero profilarsi
drammatiche e pesantissime, per tutti, per la guerra santa di
Bin Laden e per la crociata di Bush: se, dopo tante parole
sovrabbondanti, le iniziative concrete non ottenessero risultati
significativi; se a lungo rimanessimo con Bin Laden non catturato,
e la resistenza dei Talebani sufficientemente forte per destabilizzare
paesi islamici entrati avventurosamente nell’alleanza promossa
dagli Stati Uniti: con Israele e Palestina in fiamme più di quanto
non siano già ora; con morti innocenti orribilmente più numerosi
in Asia di quelli già contati con dolore e umiliazione nelle torri
di Manahattan e negli uffici di Washington: che cosa potremmo
dire di “sapere”?
*Saggista, editorialista

La pancia e la testa
Riccardo Perissich*
Le tragedie hanno l’effetto di semplificare tutto. In
condizioni “normali”, abbiamo tempo e voglia di dare spazio
alla riflessione, al trattamento analitico dei problemi, al
rispetto delle procedure, alla ricerca dei compromessi. Idee nuove
hanno il tempo di germogliare, di essere dibattute, se sono buone
di imporsi. Le condizioni “normali” conducono anche a
comportamenti perversi. L’interesse particolare tende a
prevalere su quello generale; i dettagli ingigantiscono di
importanza; si perde il senso della priorità; la morale lascia lo
spazio al moralismo. La paziente ricerca del consenso si trasforma
in diritto di veto; i processi decisionali rallentano, poi si
paralizzano; i problemi, che sembrano marginali si accumulano
senza soluzioni. La tragedia, quando arriva, semplifica ed
accelera tutto. Le priorità ritrovano istantaneamente il loro
posto; ciò che sembrava gigantesco una settimana fa diventa
irrisorio, mentre scopriamo improvvisamente che problemi lasciati
nascosti sotto il tappeto contenevano candelotti di dinamite.
L’azione diventa più importante del compromesso. Il grigio
cessa di essere un colore di moda. La tragedia, soprattutto
quando é provocata da eventi umani premia l’istinto sulla
riflessione, la pancia rispetto alla testa, la forza rispetto al
consenso. Il pronome “noi”, che sembrava così ambiguo,
acquista una chiarezza abbagliante. Improvvisamente le ragioni
nostre diventano molto più importanti delle ragioni degli altri e
le ragioni della politica riprendono il sopravvento su quelle
dell’economia.
Ritorniamo con la memoria ai giornali di prima dell’11
settembre. Gli Stati Uniti dibattevano dell’opportunità e entità
di tagli fiscali. L’Europa si trastullava nella ripartizione di
modesti fondi regionali in vista dell’allargamento dell’Unione
Europea; oppure bloccava importanti decisioni sulla organizzazione
dello spazio aereo o sui mercati finanziari a causa dello Statuto
del territorio di Gibilterra; Stati Uniti e Europa cercavano di
mettere fine alla guerra delle banane. Le manifestazioni di Genova
erano riuscite a convincere persino una parte
dell’establishment che la “Tobin tax” costituisce il nodo
principale per l’organizzazione di un ordine mondiale più
giusto. L’Italia si trastullava nella determinazione del
probabile “buco” nelle finanze statali. Il giornaliero bagno
di sangue stava facendo lentamente entrare il Medio oriente nella
categoria dei problemi insolubili “con cui bisogna convivere”.
Non sappiamo cosa ci riservi il futuro, ma di una cosa possiamo
essere certi: tutte queste cose hanno improvvisamente cambiato
dimensione e il loro posto nelle priorità collettive. La tragedia
dell’11 settembre ha anche fatto in pochi minuti giustizia di
una convinzione ormai profondamente radicata in America: che le
guerre possono essere combattute e vinte senza alcuna perdita di
vite umane da parte nostra.
Non so se bisogna chiedersi, ma io non ne posso fare a meno, se
sia meglio la normalità o l’eccezione, la pancia o la testa,
l’istinto o la riflessione. Da questo punto di vista la storia
non ci insegna quasi nulla. Nell’agosto del 1914, il trionfo
delle emozioni condusse a una spirale perversa che spazzò via in
poche settimane il paziente, anche se bizantino, lavoro di
diplomatici che avevano assicurato all’Europa 40 anni di pace e
la condusse a una guerra suicida che nessuno aveva veramente
voluto. D’altro canto, negli anni 30, il prevalere della
prudenza concesse ad Hitler alcuni vantaggi strategici quasi
decisivi e rese la guerra allo stesso tempo più probabile e più
terribile.
Gli americani scoprono per la prima volta nella loro storia che il
loro territorio é vulnerabile; una cosa che gli europei sanno da
sempre. E’ facile prevedere che sceglieranno più facilmente
l’istinto, mentre l’Europa sarà più facilmente portata alla
riflessione. Sarebbe un bene se ciò ci conducesse a una sintesi.
Sarebbe un disastro se fosse fonte di disunione. Il pericolo
é grande, perché le tragedie, proprio perché semplificano,
premiano l’azione unilaterale su quella multilaterale, il
nazionalismo economico sulla cooperazione internazionale. Il mondo
invece, anche se deviato da due anni di dibattito sbagliato sulla
globalizzazione, avrebbe bisogno di più azione multilaterale e di
più globalizzazione governata. Nulla é ineluttabile. Si uscì
dalla prima guerra mondiale, gestita dagli europei, con
Versailles, le crudeli riparazioni economiche e l’’umiliazione
della Germania. Si uscì dalla seconda guerra mondiale, gestita
dagli americani, con il piano Marshall, Bretton Woods e la Nato.
Chi ha assistito in diretta televisiva alla commemorazione
avvenuta nello Yankee Stadium, non può non essere stato
profondamente colpito da quella straordinaria sintesi di orgoglio
civico, di patriottismo nazionale di sincretismo religioso e di
recupero di valori universali che ha caratterizzato tutta la
cerimonia. Con grande sforzo di tensione morale un paese
multiculturale cercava la mobilitazione, nel dolore, intorno a
valori condivisi. Non credo che esistano precedenti nella storia.
Non é detto che ciò produca buoni risultati, ma lo sforzo é
impressionante. Dobbiamo lucidamente dirci che é difficile
immaginare che una simile tensione morale una simile proiezione
verso il futuro, potrebbe prodursi oggi in un qualsiasi paese
europeo. Il momento della cerimonia che strappò gli applausi più
scroscianti fu la dichiarazione del Sindaco Giuliani: “Dicono
che New York non sarà più quella di prima. È vero; sarà
migliore”. È probabile che l’uccello da cui si devono
guardare gli americani sia il falco. Per l’Europa non é la
colomba, ma lo struzzo. Negli ultimi giorni i governanti europei
hanno detto e fatto tutte le cose giuste. Spenta la televisione
con la cerimonia di New York, rimane però la preoccupazione per
l’assenza, in Europa, di un analogo messaggio unificante e
mobilizzante. Come se i nostri governanti ci volessero dire che la
situazione é certamente grave, ma che cercheremo di gestirla con
un equilibrato dosaggio di pragmatismo, di determinazione e di
buon senso. Che, al di là della retorica, questa é una
“guerra americana”. Il rischio é che questo atteggiamento,
così profondamente europeo, non riesca a dare all’opinione
pubblica né tranquillità né coraggio
Mai come nelle tragedie, siamo nelle mani dei leader. Il
guaio é che scopriamo solo in ritardo se erano all’altezza o
no. Ma non dimentichiamo che conta anche moltissimo il
comportamento di ogni singola persona. Dipenderà anche da ognuno
di noi se cederemo alla paura, o se continueremo a viaggiare, a
consumare, a lavorare. Dipenderà da ognuno di noi se faremo
sentire al nostro vicino mussulmano il peso della nostra paura.
Dipenderà da ognuno di noi se i nostri governanti saranno, o non
saranno, tentati di fare, come in passato, vigliacchi accordi con
i terroristi per guadagnarsi un po’ di tranquillità e, se
continueranno a fare dell’anti-americanismo, o del
filo-americanismo, per pura strumentalizzazione della politica
interna.
In ultima analisi vale sia per noi che per i governanti il
principio kantiano dell’unica morale che riesce a conciliare la
ragione e il cuore: agire come se il principio che ci guida avesse
valore di legge universale. Facile.
*Dirigente Pirelli

Spettatori,
vittime e attori
Elena Pulcini*
La prima sensazione che si prova nell’accingersi a fare una
riflessione sull’attentato terroristico negli USA è il timore
di diventare immediatamente obsoleti, di essere rapidamente
superati dagli eventi. La “velocizzazione del tempo”, che è
una delle cifre della nostra epoca, ha raggiunto il suo apice
laddove la realtà diventa vertiginosamente anticipatrice
dell’immaginazione.
L’ingresso nell’ètà globale si è simbolicamente e
traumaticamente compiuto nello choc e nello stupore collettivo
davanti al fuoco che divampa nelle Twin Towers, che ci strappa dal
passivo ruolo di “spettatori”, nel quale finora potevamo, sia
pure illusoriamente, rifugiarci alla ricerca di un luogo, di un
punto di osservazione immune dagli eventi del mondo. Neppure il
filtro massmediale che ancora agiva con il suo impatto
derealizzante durante la Guerra del golfo, rendendola, nonostante
tutto, astratta e lontana, funziona più di fronte all’immagine
di corpi che si lanciano nel vuoto; rendendo improvvisamente
cruenta l’immagine familiare e patinata della metropoli
americana.
L’immunità, su cui la modernità aveva costruito il suo
progetto e fondato la sua legittimità, affidando allo Stato e
alla politica la salvaguardia della vita umana e la possibilità
della convivenza pacifica, è ora irrimediabilmente finita. Non
solo perché è stata colpita al cuore la sovranità dello Stato
più potente dell’Occidente; non solo perché ne è stata minata
la mitica capacità di controllo e di previsione; ma anche perché
è immediatamente emersa la consapevolezza di una condizione di
insicurezza globale, che si fa beffe di frontiere nazionali e di
confini territoriali, coinvolgendo bruscamente l’intero
“genere umano” nei futuri scenari possibili. Se la
globalizzazione è interdipendenza, “compressione
spazio-temporale”, perdita dei confini e del controllo, e
contagio planetario, in virtù del quale un evento “locale”
produce effetti mondiali e, viceversa, decisioni mondiali possono
trascinare nel proprio gorgo le più remote realtà locali, le
Twin Towers ne sono evidentemente il simbolo che autorizza, come
è stato fatto, a parlare dell’inizio di una nuova era.
Guerra globale, si ripete sempre più spesso; senza forse rendersi
sufficientemente conto che per la prima volta viene detto
l’indicibile, viene “pensato l’impensabile”, viene agitato
nella domestica quotidianità delle nostre vite inermi e quasi
meccanicamente fiduciose nella saggezza della ragione, quello che
finora era solo uno spettro virtuale, una minaccia tanto più
spaventosa quanto più facilmente sottoponibile a rimozione:
quella dell’autodistruzione del genere umano.
Ma l’inverarsi di questa possibilità dovrebbe spingerci ad una
presa di coscienza più profonda, che non si lasci sedurre, come
mi pare stia accadendo, dal ricorrere a facili dicotomie tra bene
e male, tra civiltà e barbarie, tra ragione e irrazionalità.
L’efficacia del terrorismo trae alimento dalle passioni
“disinteressate” di popoli che rivendicano il loro diritto
all’identità religiosa e culturale, e che non è possibile
liquidare con frettolose accuse di arcaismo o anacronismo. Ma non
solo. La violenza del terrore si serve dell’uso freddo e
sapiente dei più sofisticati strumenti prodotti dallo sviluppo
occidentale moderno (dalla tecnica, alla rete di informazioni,
alla speculazione finanziaria). La globalizzazione crea queste
contaminazioni paradossali, in virtù delle quali l’attuale,
efferato nemico dell’Occidente trae forza parassitariamente da
ciò che l’Occidente ha di fatto reso possibile. S’impone
allora una assunzione di responsabilità che ci spinga tutti ad
interrogarci sul senso e sulla legittimità di un modello di
sviluppo e di sapere che ha generato, come sua possibilità
endemica e spettralmente reale, la distruzione dell’umanità e
del pianeta. Il terrorismo è solo la punta dell’iceberg
costituito dai “rischi globali” (minaccia nucleare, disastri
ambientali, epidemie virali, global warming): effetto spesso
invisibile e irreversibile del potere economico e tecnologico che
varca ogni confine, e del suo automatismo prometeico, ormai libero
di scatenarsi in assenza di efficaci istanze di controllo e di
previsione.
La politica, certo, svolge ancora il suo ruolo, soprattutto se si
è disposti a riconoscere il vuoto creato dalla crisi della
sovranità degli Stati e la necessità di una governance
transnazionale; purché questa sia capace non solo di assumere
l’onere dell’emergenza, ma anche di aprire nuovi spazi di
contrattazione e di decisione tesi a future operazioni preventive.
Ma la posta in gioco è troppo alta per affidarla unicamente a
soluzioni istituzionali. I pericoli della globalizzazione esigono
una mobilitazione soggettiva, in cui ciascuno si riconosca, al di
là delle legittime differenze, membro di uno stesso genere umano
e si pensi come nodo di una rete, coesa e fragile allo stesso
tempo; in cui ciascuno sappia vedersi nella triplice e simultanea
funzione di spettatore, vittima ed attore.
Nella sua terribile crudezza, l’evento americano cela forse al
suo interno un’immagine simbolica rivelatrice di questa
possibilità o, se si preferisce, di questa speranza: l’immagine
di quei passeggeri dell’aereo che hanno consapevolmente scelto,
sulla base di una drammatica e lucidissima deliberazione comune,
di opporre resistenza al terrore, votandosi a morte certa e
salvando così molte vite umane; l’immagine di un piccolo
scampolo di umanità che “di fronte all’estremo”, non ha
esitato a varcare la soglia dell’individualismo compiendo il
salto verso un agire disperatamente solidale.
* Docente di Filosofia politica all’Università di Firenze 
L’ultima parola
Sergio Rostagno*
Personalmente non riesco a pensare ad altro. Non ci sono mezzi più
civili per far valere le proprie ragioni? Veramente esiste solo
questo mezzo, l'attacco terroristico efferato? Queste sono domande
che poniamo agli autori dell'atroce gesto, ma che dovremmo farci
per primi. Non sono per caso stati i nostri governi occidentali a
ironizzare su ogni sforzo per il riavvicinamento dei popoli?
Davvero l'Onu andava indebolita e scavalcata ogni volta che fosse
possibile? Governi e Servizi segreti non stanno forse raccogliendo
quel che hanno essi stessi seminato? Tutte le volte che il mondo
si trova sull'orlo di un baratro, ci si ricorda dei buoni
propositi; passato lo spavento, si comincia come prima. Il
terrorismo è colpevole illusione di poter arrivare da soli e
direttamente, laddove le persone ragionanti impiegano tempo. Sono
scorciatoie irresponsabili, oltreché atroci. Ma per essere meno
cinici, occorre anche trovare interlocutori.
Giorni fa su
“Repubblica” Augias, se non ricordo male, invocava un
messaggio risoluto da parte delle tre religioni monoteistiche.
Qualche cosa gli deve essere rimasto nella penna: che c'entra
essere tre o cinque, essere o non essere monoteisti? E non sarebbe
meglio dare qualche notizia su ciò che le
religioni hanno già detto e fatto da decenni? Forse che le
religioni
aspettano l'11 settembre per parlare? Sono sveglie da tempo. Chi
non lo è,
invece, dovrebbe essere svegliato. Sono anni che le religioni
avvertono che
sarebbe finito così.
Le religioni possono dire (e dicono) quel che nessun politico si
può
permettere: chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Certo c'è
modo e modo
di dirlo; e piangere con le vittime fa anche parte del conforto
religioso.
Accanto a ciò, deve starci un richiamo fermo rivolto alla propria
parte e al
proprio paese. Non vi è dubbio che l'assassino tale resta e va
fermato. Ma
nessuno può lavarsi le mani come se fosse innocente. Questo le
religioni non
hanno difficoltà a dirlo, sia pure nel loro linguaggio sempre un
po' velato
e liturgico. Più difficile, per loro, denunciare il
fondamentalismo interno.
Si è sempre tentati di identificare la propria causa con la causa
di Dio. Si
aspetta anche il buon momento per lanciare messaggi 'profetici',
talvolta
ambigui. Altre sono le necessità, per esempio la maturazione
efficace di un
messaggio di umanesimo: non vi è altra soluzione.
Ma quante volte
è stato
detto questo dal Dalai Lama, dalle assemblee ecumeniche cristiane,
dai
pulpiti più modesti o più autorevoli? È stato detto in tutti i
toni. Non ci
avete mai dato ascolto e ora venite a chiederci di parlare.
Il futuro è preoccupante abbastanza. Non si può tornare
indietro, e non si
sa dove si stia andando. Alla mossa dei terroristi, si risponde
con
contromosse. Ammettiamo che ci sia qualche ragione tattica per
farlo;
sicuramente non è una soluzione di lungo respiro. Il mondo non può
essere
governato così. Occorrono politici lungimiranti.
Il crimine non giova alle iniziative lungimiranti delle persone
laiche o
religiose che vogliono costruire. Taglia loro le gambe e allontana
da loro
il consenso. Gli atti terroristici non giovano mai al pensiero
umanistico,
capace di distinguere laicità e religione, che vuole rispetto
delle
convinzioni per la causa comune dell'umanità, che crede nella
scuola per
informare correttamente e aumentare la duttilità e la profondità
delle
convinzioni stesse. Il terrorista non vuole niente di questo. Il
mondo ora
pare suo. Speriamo che non abbia l'ultima parola.
Ma perché non
l'abbia,
occorre che le parole ritrovino il potere di analizzare,
convincere,
illuminare.
Mi è accaduto sentire in treno una persona augurarsi che vengano
mandati a
combattere i giovani dei motorini e telefonini, perché
"provino un po' anche
loro cosa vuol dire". Altri parlano di "pace" solo
per poter continuare a
vivere come se nulla fosse stato. Queste insensatezze vanno prese
sul serio
e confutate con l'informazione.
*Ordinario di teologia sistematica, Facoltà Valdese di Teologia,
Roma.

Ipocrisia
di governo
Paolo Sylos Labini *
La tragedia di New York e Washington e le sue conseguenze
potrebbero portarci a ragionare intorno a molte cose, dal
conflitto di civiltà alle guerre di religione, ma ritengo che
spostare lo sguardo all’interno dei nostri confini possa
aiutarci a fotografare la situazione e a mettere in evidenza
alcuni aspetti della politica italiana.
Il crollo delle torri del World Trade Center e l’aereo
abbattutosi sul Pentagono portano all’evidenza della nostra
attenzione un disegno di legge progettato prima dell’11
settembre, ma che da questi eventi trae nuova e, ritengo, più
forte rilevanza. Si tratta del provvedimento, già approvato al
Senato e che tra poco sarà discusso alla Camera, che renderebbe
le rogatorie internazionali molto complicate. In sostanza, a pochi
giorni dgli attentati terroristici, una tra le massime priorità
del governo italiano è di portare in porto un disegno di legge
che di fatto pone ostacoli ad indagini che, al di fuori dei
confini nazionali, riguardino persone sospettate di reati gravi,
come quelli connessi al terrorismo, al riciclaggio di denaro, al
traffico di stupefacenti, a crimini di mafia.
Come può, questa situazione, non suscitare l’imbarazzo di chi,
all’interno della maggioranza o dell’opposizione, si rende
conto della estrema gravità che pesa sull’approvazione di
questo provvedimento, della vergogna che ne scaturirebbe per gli
italiani di fronte alla comunità internazionale proprio in giorni
come questi, in cui non si parla che di collaborazione dei Paesi
civili in una lotta senza frontiere al terrorismo.
E come non vedere allora, e mettere in evidenza, l’ipocrisia di
coloro che da una parte deprecano il terrorismo come uno tra i più
grandi mali da debellare dalla nostra società, mentre
dall’altra si privano di uno strumento efficace, come quello
delle rogatorie internazionali, per portare a compimento questa
lotta.
Se quella che stiamo cercando, di fronte allo sconcerto degli
attentati terroristici, di fronte alla paura e all’orrore, è
una risposta razionale, la risposta del governo italiano, con la
volontà di approvare in tempi brevi questo disegno di legge, non
ha nulla a che fare con la razionalità, ma rappresenta, al
contrario, la negazione della ragione.
*Economista 
Vittime
del nostro egoismo
Laura Toscano*
Quelle immagini in diretta dell’11 settembre sono ancora nei nostri
occhi. Quell’urlo collettivo dalle macerie di una civiltà è ancora
nelle nostre orecchie. Il mito dell’indistruttibilità non esiste.
Non esiste più. Fino a ieri il catastrofismo di certe immagini
sembrava solo un’ostentazione hollywoodiana. Ma dentro a quelle
torri non c’erano eroi. C’erano vite, amori, problemi. C’erano
segretarie, camerieri, studenti, pompieri, poliziotti, non i guardiani,
dei destini del mondo. Potevamo esserci noi. Tragica forza dei
media. Quando l’emozione sarà passata, e passerà, perché la nostra
memoria ha un passo corto, forse cominceremo a farci domande.
Ci chiederemo come sia potuto succedere, ci chiederemo come sia
possibile che la maggiore potenza mondiale si sia fatta beffare
da un centinaio di uomini armati di temperini, ci chiederemo perchè
l’Occidente è considerato l’Impero del Male? Da dove viene tanto
odio? La colpa di quali ingiustizie passate e presenti stiamo
pagando?
Oggi si pensa “ad una necessaria reazione armata degli Stati Uniti
e degli alleati”. Contro chi? Osama Bin Laden? I Talebani? Afghanistan?
E chi altri? Sulla base di quali prove? Possibile che improvvisamente
a pochi giorni da quei tragici fatti che hanno colto di sorpresa
il mondo intero, ora sia tutto chiaro? È pacifico che un attentato
così grave non possa restare impunito ma i “venti di guerra” che
emotivamente spirano in tutto l’Occidente fanno temere la possibilità
di altri “errori” di altre orrende ingiustizie: fanno temere reazioni.
Si parla di nucleare, di guerra chimica.
Da qui lo smarrimento. Giusto quindi orientare la ragione, riflettere,
capire. Giusto quindi che , al di là dell’ovvia partecipazione
ad una tragedia così esecrabile, qualcuno ci spieghi.
Giusto quindi ribadire con fermezza un no alle vendette affrettate,
alla compensazione vendicativa con altre vittime innocenti.
E chiederci se la radice del male non sia in un senso di “giustizia”
troppo utilitaristica che spesso ha mosso l’Occidente in direzione
di esclusiva opportunità, a scapito dei più deboli, di quelli
senza voce. Altrimenti perché correre in soccorso del Kuwait e
non del popolo curdo da anni disperso, massacrato dalla Turchia?
Il terrorismo e l’ideologia fanatica trovano fertile terreno proprio
là dove le ingiustizie sono più gravi e plateali.
E se questa operazione “giustizia infinita” dovesse diventare
solo la guerra del ricco Occidente contro i diseredati del mondo,
avremmo già perso. Almeno nel profondo delle nostre coscienze.
Si dice che dall’11 settembre la nostra vita è cambiata. Non me
ne sono accorta. L’attimo dell’orrore e dell’incredulità è passato
scavalcato da altre preoccupazioni.
De l resto la nostra vita non è cambiata per i sei milioni di
ebrei trucidati dai nazisti. Non è cambiata per le vittime dell’atomica
di Hiroscima e Nagasaki. Non è cambiata per il milione di bambini
iracheni morti in seguito all’embargo. Abbiamo una capacità di
adattamento agli eventi che solo una grande tragedia collettiva
può mutare. La nostra miopia circoscrive gli orizzonti, ci porta
a credere che le colonne d’Ercole delle abitudini del nostro quotidiano
siano invalicabili. Ci siamo chiusi sempre di più in un egoismo
esistenziale che di tanto in tanto viene smosso da violente
scariche di adrenalina. I problemi privati si enfatizzano. La
televisione è il nostro unico interlocutore. Se l’attentato dell’11
settembre servisse a riaprire la nostra mente alle emozioni collettive,
alla solidarietà, al dialogo, alla comprensione della diversità,
all’equanimità di giudizio sulle tante ingiustizie del mondo,
invece che alla vendetta cieca, allora forse il terrorismo nascerebbe
sconfitto e i Bin Laden della terra e gli altri folli assassini
come lui non avrebbero seguito né scampo.
*sceneggiatrice
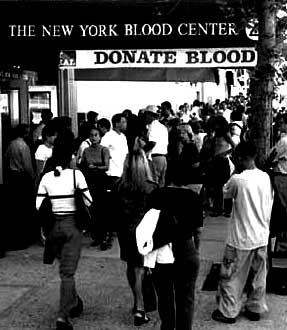
Libertà contro
paura
Marco Vitale*
I nemici di uno sforzo serio per un nuovo ordine all'altezza delle
grandi sfide alle quali ci troviamo di fronte sono l'ignoranza,
la mistificazione, i fondamentalismi, le "elite" che
prive del potere satrapesco che derivava loro dai regimi collettivismi
cercano, attraverso il caos dei rispettivi paesi, di impadronirsi
del potere economico (James parla di "elite sponsored caos"),coloro
che, nell'incertezza delle nuove prospettive, temono di trovarsi
tra i perdenti e tanti altri. Sufficienti per permetterci di concludere
che la speranza di una evoluzione verso una globalizzazione "soft",
che pure avevamo nutrito, è da ripiegare e mettere ordinatamente
nel cassetto. Come tutti i grandi processi della storia dobbiamo
mettere in cantiere passaggi molto dolorosi. E' questo che fa
dire, ben prima di Genova e di New York, a James: "vi sono
almeno quattro ragioni per pensare che una violenta reazione (al
processo di globalizzazione) "sia inevitabile". E dunque
dobbiamo prepararci, organizzativamente ma ancor più moralmente,
a fronteggiarle.
E questo mi sembra che sia anche il significato principale dell'immane
tragedia di New York e Washington. Non voglio aggiungere troppe
parole alle tante che sono già state dette. Mi sembra che
la natura dell'attacco e la responsabile risposta dell'America
non lascino spazi al minimo dubbio. Dobbiamo essere tutti al fianco,
senza la minima esitazione, dell'America. L'11 settembre ho inviato
al console americano a Milano un messaggio di condoglianze dicendo:
oggi mi sento newyorkese. Ed ancora lo sono, anzi sempre di più
osservando gli ammirevoli comportamenti dei cittadini di quella
meravigliosa città. Dirò di più. Non di una
solidarietà astratta contro un terrorismo senza volto si
tratta. Ma di una presa di posizione aperta contro il fondamentalismo
islamico e contro le sue radici culturali e religiose. E' vero
che dobbiamo evitare lo scontro di civiltà o indebite e
grottesche classifiche di superiorità tra civiltà?
Come è vero che la civiltà ed il pensiero islamico
sono cosa ben diversa dal pensiero di questi assassini. Ma il
fondamentalismo islamico se non è l'Islam fa pur parte
dell'Islam . E quindi è necessario contrastarlo anche sul
piano culturale, religioso e politico, senza timori. Dobbiamo
chiamare il pensiero islamico serio a fare passi avanti sulla
via della libertà, dei diritti civili, del laicismo, come
noi abbiamo fatto, circa mille anni fa rigettando per sempre i
tentativi di imporre un regime teocratico, che pure ci sono stati
anche nei paesi cattolici. E dobbiamo chiamare i saggi dell'Islam,
i tanti personaggi di grande cultura di questi paesi a prendere
posizione aperta e non equivoca nei confronti di questi loro concittadini
e compagni di fede che si buttano contro le Twin Towers con aerei
pieni di vittime sacrificali, pronunciando le magiche parole Allah
Akbar. Sono loro e non noi che devono dirci e soprattutto dire
ai loro concittadini e compagni di fede se Allah è d'accordo
e questa è la Jihad di cui parla la loro religione, e se
non lo è che cosa è. Ma non devono dirlo solo con
le parole di solitari studiosi. Lo devono dire pubblicamente,
ufficialmente, rumorosamente, affinché i popoli odano e
comprendano.
Ma tutto ciò non deve impedirci di riflettere e di fare
anche le nostre autocritiche. Pochi giorni dopo l'attentato sono
andato a Bombay e questo mi ha dato la possibilità di guardare
alla tragedia anche da un punto di vista indiano. Anche qui tutti
quelli che ho incontrato erano a fianco dell'America. Il governo
ha indetto, per il 18 settembre, il giorno della solidarietà
contro il terrorismo; tutti i partiti sono stati compatti su queste
posizioni; il capo di governo ha fatto pubblicare sui giornali
intere pagine contro il terrorismo, affermando: "ogni indiano
deve essere parte di questa guerra globale contro il terrorismo.
Noi dobbiamo scacciare, e ci riusciremo, questo demonio dalla
nostra terra e dal mondo". Ma le stesse pagine pongono l'immagine
dell'attacco alle Twin Towers al termine di una serie di altre
immagini che rappresentano altri gravi attentati terroristici,
subiti dall'india, dalle stesse fonti terroristiche, negli ultimi
dieci anni; per sottolineare l'unitarietà della lotta e
dell'impegno comune.
Vi sono tre punti sui quali dobbiamo riflettere e tentare delle
nuove risposte mi hanno detto degli amici indiani: l'America ha
contribuito a creare personaggi come Osama Bin Laden e come Sadam
Hussein; perché? Quali sono le forze ed i motivi che inducono
tante persone a sacrificare la loro vita e di tanti altri per
dare una lezione all'America? Perché l'America si muove
solo quando il terrorismo la colpisce direttamente; lo sapete
che l'India ha avuto 53.000 vittime del terrorismo e nessuna solidarietà?
Queste domande non sono poste con intenzione polemica ma come
necessità di riflessione, per costruire una solidarietà
mondiale vera, una globalizzazione, anche di pensiero, vera, contro
i mali del mondo. La speranza di una nuova più costruttiva
politica non può non passare anche attraverso una riflessione
critica di questo tipo. Qui, oltre che nell'azione di polizia
internazionale, può radicarsi la speranza.- Se non vogliamo
che tutto il mondo si riduca come si è ridotto Israele
nel suo confronto senza fine con i Palestinesi.
Nella fermezza, dunque, ma dobbiamo avviare una revisione critica
profonda di tante cose. Come scrive Harold James:
"Questi mutamenti ci rendono consapevoli di come la nostra
attività è ormai legata con il destino di altri
miliardi di esseri umani nel mondo. Il dramma delle trasformazioni
economiche che stiamo vivendo richiede un riordino sostanziale
delle nostre istituzioni, non un loro abbandono ma un ripensamento
completo delle politiche tradizionali, come esse si sono sviluppate
nel corso del secolo scorso"
Nell'immensa tragedia che ci ha colpito io vedo anche dei segnali
potenzialmente positiva. Innalzi tutto la natura allucinante dell'attentato
stesso mi sembra espressione più di un delirio che di una
forza; mi sembra un atto di disperazione di chi non ha un disegno
ed una prospettiva (come le BR con l'uccisione di Moro; come la
mafia con l'assassinio di Falcone e Borsellino). Vedo, invece,
un maturo equilibrio nei governi, un desiderio diffuso di tornare
a pensare; una maggiore consapevolezza che il mondo richiede maggiore
responsabilità ed unione; una apertura nuova in certi paesi
islamici; la stupita amarezza degli americani nello scoprire che
non tutti li amano; la sensazione che una fatica lunga e dolorosa
ci aspetta ma che può trattarsi di una fatica positiva,
illuminata da una luce, da un senso: costruire veramente un mondo
più unito in una globalizzazione più seria e profonda;
la riscoperta profonda dei nostri valori più autentici
ed universali, quelli che fecero dire a Truman nel suo discorso
inaugurale, il 20 gennaio 1949, sulla collina di Washington:
"Il popolo americano desidera, e per questo è pronto
a lavorare, un mondo in cui tutte le nazioni e tutti i popoli
siano liberi di governarsi come meglio credono e di raggiungere
una vita decente e soddisfacente. Sopra ogni altra cosa il nostro
popolo desidera, e per questo è pronto a lavorare, la pace
nel mondo - una pace immediata e duratura - basata sullo spontaneo
accordo liberamente raggiunto tra uguali…
Il nostro scopo dovrebbe essere quello di aiutare i popoli liberi
del mondo, attraverso i loro stessi sforzi, a produrre più
cibo, più vestiti, più materiali per costruire le
loro case e più energia per alleggerire il peso delle loro
vite.
Noi invitiamo gli altri Paesi a mettere insieme le loro risorse
tecnologiche per realizzare questa impresa. Ogni loro contributo
sarà caldamente benvenuto. Questa dovrebbe essere un'impresa
di cooperazione in cui tutte le nazioni lavorano perfettamente
insieme attraverso le Nazioni Unite e la le loro agenzie specializzate.
Deve essere uno sforzo che coinvolga il mondo intero per il raggiungimento
della pace, della ricchezza e della libertà.
Tutti i Paesi, compreso il nostro, trarrà enormi benefici
da un costruttivo programma per un migliore uso delle risorse,
umane e naturali, del mondo. L'esperienza ci insegna che il nostro
commercio con altri paesi si espande se questi paesi progrediscono
a livello industriale ed economico.
Solo aiutando il meno fortunato dei suoi membri ad aiutare se
stesso, la famiglia degli esseri umani può raggiungere
una vita decente e soddisfacente che è diritto di ogni
individuo.
Soltanto la democrazia può fornire la forza vitalizzante
necessaria a sollevare individui di tutto il mondo verso azioni
trionfanti dirette non solo contro i loro oppressori umani, ma
anche contro i loro antichi nemici come la fame, la miseria e
la disperazione….
Noi siamo aiutati da tutti coloro che desiderano vivere liberi
dalla paura, ed anche da coloro che oggi vivono oppressi per la
paura verso i loro governanti ..."
Forse questo appello può suonare un po' retorico oggi.
Ma non era retorico allora. E può ritornare a non suonare
retorico oggi. Parte importante degli impegni assunti in quell'appello
(la ricostruzione dell'Europa; la resistenza sino alla vittoria
contro il terrore comunista) sono stati portati a termine.
Altri devono essere ripresi, nello stesso spirito e la stessa
convinzione, oggi. E noi Europei, che allora non esistevamo più
ma che oggi esistiamo di nuovo, anche grazie all'America ed a
quell'appello, dobbiamo fare la nostra parte. Senza viltà
ed astuzie e sapendo rimettere in gioco un po' del nostro futile
modo di vivere.
Se così sarà, allora se è vero, come tanti
hanno scritto, che l'11 settembre 2001 ha cambiato il mondo, si
potrà aggiungere: ma, come è di tutte le grandi
prove e tragedie, forse non lo ha, necessariamente, cambiato in
peggio.
*Economista d'impresa

Prima definiamo
il campo di battaglia
Michael Walzer*
C’è una vecchia vignetta di Bill Mauldin nella quale due attempati
gentiluomini siedono in un club per signori. Uno si piega
verso l’altro e fa: “Ti dico che è guerra, Throckmorton,
e ti dico anche : “Combattiamo!”
A Washington dall’11 settembre si sono sentiti molti discorsi
del genere. E si sono sentiti anche in tutta la nazione:
ci sentiamo un po’tutti come l’amico di Throckmorton. Ma
c’è la guerra? E se c’è, come dobbiamo apprestarci a combatterla?
Di certo tutti noi abbiamo un nemico, qualunque sia la nostra
ideologia politica, qualunque sia la nostra fede religiosa. Le
nostre esistenze e il nostro modo di vivere sono stati attaccati
– lo dicono tutti, ma è vero. Quest’attacco può aver avuto le
sue origini più dirette nella Guerra del Golfo; può essere stato
alimentato dai risvolti fanatici e profondamente distorti
del blocco Iracheno e del conflitto tra Palestinesi e Israeliani.
Ma le sue cause sono molto più profonde: il rancore verso la potenza
americana e l’odio per i valori che a volte, almeno, guidano la
sua politica. Comunque questa non è una “guerra di civiltà”, dal
momento che il nostro nemico non rappresenta una civiltà.
Non siamo in guerra con l’Islam, anche se i terroristi sfruttano
il fervore religioso Islamico.
E’ dunque guerra? Il termine è inoppugnabile, purchè coloro che
lo utilizzano si rendano conto che è una metafora. Non c’è, in
questo preciso momento, uno stato nemico, non c’è un ben definito
campo di battaglia. Il termine “guerra”, comunque, si può
prestare bene come metafora che stia a significare lotta, impegno,
resistenza. L’azione militare, sebbene possa arrivare, non è la
prima cosa a cui dobbiamo pensare. Piuttosto, in questa
“guerra” al terrorismo, altri tre aspetti hanno la precedenza:
un lavoro intensivo delle forze di polizia al di là dei confini
nazionali, una campagna ideologica per impadronirsi di tutti gli
argomenti e le giustificazioni a favore del terrorismo ed eliminarli,
ed uno sforzo diplomatico serio e sostenuto.
Ciò che le forze di polizia devono fare è ovvio, ma c’è un compito
anche per i capi religiosi e gli intellettuali, perché l’ambiente
intellettuale in molte parti del mondo non è sufficientemente
ostile al terrorismo. I terroristi vengono protetti moralmente
come fisicamente, ed il solo rimedio è la discussione politica.
I nostri diplomatici devono fare molto di più di quanto
hanno fatto nel costruire la coalizione che ha combattuto la Guerra
del Golfo. Quella era un’alleanza scadente, adatta al momento
ma non alle lunghe distanze. L’alleanza contro il terrorismo
dev’essere strutturata per durare: deve riposare su patti esigenti
e che possano essere fatti rispettare.
Ma ciò di cui tutti vogliono parlare è l’azione militare – non
la metafora della guerra, ma la guerra vera. Che cosa possiamo
fare, quindi? Ci sono due condizioni da soddisfare prima
che si possa combattere in maniera giusta. Dobbiamo identificare
dei validi obiettivi – persone effettivamente impegnate nell’organizzazione,
nel supporto o nell’esecuzione delle attività terroristiche.
E dobbiamo essere in grado di colpire tali bersagli senza uccidere
un gran numero di innocenti.
A dispetto delle critiche per gli “assassinii” Israeliani da parte
di ufficiali statunitensi, io non credo che importi, da un punto
di vista morale, se gli obiettivi sono gruppi di persone o singoli
individui, a patto che queste due condizioni vengano rispettate.
Se non riusciamo a rispettarle, difenderemo la nostra civiltà
semplicemente imitando i terroristi che la stanno attaccando.
Da questi due criteri consegue che le incursioni dei reparti d’assalto
sarebbero verosimilmente meglio di attacchi con missili e bombe.
Quando il bersaglio è, per dire, un piccolo e sparpagliato gruppo
di terroristi durante le esercitazioni, un soldato armato di fucile
è più abile della bomba più efficace. Ma cosa succede se
lo scopo del nostro attacco è quello di costringere i governi
che appoggiano le attività terroristiche a consegnare i terroristi
o a smettere di finanziarli? Questo è certamente un valido scopo
– in realtà uno scopo necessario per qualsiasi alleanza che si
opponga al terrorismo. Ma le nostre capacità coercitive in tale
sfera sono moralmente limitate. Non possiamo convincere
i governi terrorizzando le loro popolazioni civili. In paesi disperatamente
poveri come l’Afghanistan, noi non possiamo cominciare a distruggere
sistematicamente ogni infrastruttura rimasta. Reti elettriche
e impianti di purificazione delle acque non sono obiettivi legittimi.
Possiamo bombardare gli edifici governativi, che probabilmente
saranno stati evacuati. E forse se il bombardamento sarà
spettacolare e i piloti eroici, quest’atto simbolico ci consentirà
di andare avanti con ciò che realmente bisogna fare. Gli stati
terroristi devono essere isolati, ostracizzati e messi sotto embargo;
bisogna chiudere le loro frontiere; bisogna penetrare le loro
organizzazioni segrete; bisogna rifiutare dovunque le loro giustificazioni
ideologiche.
Il pericolo più grande in questo preciso momento è che dopo aver
realizzato danni sufficienti – da qualche parte- ci allontaniamo
da quei compiti e da quell’impegno di risorse necessari per sconfiggere
il terrorismo.
Dobbiamo perseguire la guerra metaforica; aspettiamo, per
quella vera.
* Filosofo della politica all’ Institute for Advanced Study
di Princeton e co-direttore della rivista “Dissent”.
Questo articolo di Michael Walzer è stato
pubblicato sul New York Times
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da
fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui
Archivio
Attualita' |