Judith Butler
Vite precarie,
Meltemi Editore, pagg. 192, euro 15,00
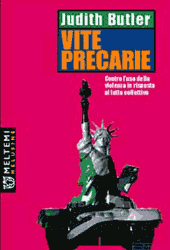 Quasi
tre anni sono passati da quel grande spartiacque storico
ed emotivo che ha cambiato il nostro modo di rapportarci
alla vita e alla politica. In questi tre anni, migliaia
di libri sono stati scritti su quel giorno, sulle
sue ragioni, sul terrorismo, sulla politica di Al
Qaeda e su quella dell’amministrazione statunitense.
Volumi cui spesso è facile assegnare, senza
troppi sforzi, un’etichetta, pro o contro Bush,
e che hanno inondato gli scaffali delle libreria rendendo
difficile distinguere le analisi più originali
e profonde. Tra queste ultime, è senz’altro
da ricordare un recente volume che ha avuto decisamente
meno risalto di quanto non solo e non tanto la fama
dell’autrice – Judith Butler, controversa
filosofa femminista – quanto l’acutezza
delle tesi in esso avanzate avrebbero meritato (forse
la non felice traduzione italiana del sottotitolo
e della foto copertina, troppo facilmente annoverabile
tra il repertorio della peggiore retorica antibushiana,
non hanno aiutato): Vite precarie. Contro l’uso
della violenza in risposta al lutto collettivo (Precarious
Life. The powers of mourning and violence), edito
da Meltemi.
Quasi
tre anni sono passati da quel grande spartiacque storico
ed emotivo che ha cambiato il nostro modo di rapportarci
alla vita e alla politica. In questi tre anni, migliaia
di libri sono stati scritti su quel giorno, sulle
sue ragioni, sul terrorismo, sulla politica di Al
Qaeda e su quella dell’amministrazione statunitense.
Volumi cui spesso è facile assegnare, senza
troppi sforzi, un’etichetta, pro o contro Bush,
e che hanno inondato gli scaffali delle libreria rendendo
difficile distinguere le analisi più originali
e profonde. Tra queste ultime, è senz’altro
da ricordare un recente volume che ha avuto decisamente
meno risalto di quanto non solo e non tanto la fama
dell’autrice – Judith Butler, controversa
filosofa femminista – quanto l’acutezza
delle tesi in esso avanzate avrebbero meritato (forse
la non felice traduzione italiana del sottotitolo
e della foto copertina, troppo facilmente annoverabile
tra il repertorio della peggiore retorica antibushiana,
non hanno aiutato): Vite precarie. Contro l’uso
della violenza in risposta al lutto collettivo (Precarious
Life. The powers of mourning and violence), edito
da Meltemi.
Le tesi della Butler non sono affatto “terziste”,
proprio perché non c’è affatto
bisogno di essere tali per evitare i passi falsi dell’appartenenza
ideologica preconcetta e della scarsità di
argomentazioni non scontate. Le critiche che la filosofa
americana avanza all’amministrazione Bush sono
pesantissime, ma scaturiscono da una originale analisi
fenomenologica e linguistica – portata avanti
in cinque densi saggi – dei temi della violenza,
della guerra, del terrorismo, dello stato di diritto
nell’era del post-11/9. Non solo la condanna
delle scelte politiche è netta, ma addirittura
l’autrice si scaglia contro le tesi riduttiviste
di chi sostiene che gli Stati Uniti hanno raccolto
ciò che hanno seminato: si tratta di un ragionamento
che capovolge il senso comune, perché condanna
la vittima, cioè coloro che hanno subito la
violenza. Allo stesso modo, è inaccettabile
dipingere gli attentatori come fantocci o meri ingranaggi,
perché si tratta sempre e in ogni caso di soggetti
responsabili. Tuttavia, seppure condannare
la violenza e chiedersi da dove viene sono istanze
separate, esse debbono essere prese in considerazione
insieme, perché esiste una relazione stretta
tra azioni e condizioni in cui l’azione
si volge, esiste una storia, relazioni causali che
vanno indagate e discusse.
Ciò che sgomenta di più, tuttavia è
la condanna che viene prontamente emessa su coloro
che dissentono dalla dottrina ufficiale: «Accusare
coloro che esprimono opinioni critiche di tradimento,
solidarietà con i terroristi, antisemitismo,
relativismo morale, post-modernismo, collaborazione,
anacronistico “sinistrismo” significa
tentare di distruggere non la credibilità di
quelle stesse opinioni, ma degli individui che le
sostengono. Ciò che ne consegue è un
clima di paura, in cui chi esprime una determinata
opinione viene “marchiato” e infangato
con un appellativo infamante» (pag. 18).
Il “monopolio” della morte
Accuse di questo tipo tuttavia impediscono di mettere
a fuoco, e conseguentemente di risolvere, il problema
che coloro che le pronunciano sembrano avere più
a cuore. Come mettere fine al terrorismo e interrompere
la spirale della violenza? A questo interrogativo
però si può rispondere solo operando
una analisi, fenomenologica prima e politica poi,
del tema della vulnerabilità e del modo in
cui tale aspetto è vissuto e affrontato. Il
tratto di maggiore originalità del libro risiede
nel fatto che la Butler si concentra soprattutto sulle
modalità con cui questi temi hanno fatto irruzione
e sono stati “gestiti” all’interno
del delicato ambito della sfera pubblica, così
come sulle conseguenze che determinate modalità
di veicolare fatti e loro interpretazioni hanno avuto
sul nostro modo di concepire la realtà, ciò
che è, letteralmente. «La sfera pubblica
è costituita in parte da ciò che può
apparire, e la regolamentazione della sfera del visibile
è un modo per stabilire ciò che è
reale e ciò che non lo è» (pag.
19). Un ambito cruciale e delicato, dove il modo in
cui gli eventi vengono fatti risuonare rischia di
produrre una vera e propria “distorsione ontologica”,
la cui gravità non è stata pienamente
compresa.
Duecentomila bambini uccisi durante la guerra del
Golfo. Abbiamo forse una sola immagine, un fotogramma
che ricordi una qualunque di queste vite, singolarmente
o di gruppo? Quei bambini avevano dei nomi?»
(pag. 55). Non si tratta di un interrogativo retorico.
La Butler analizza moltissimi casi, che purtroppo
non è possibile riportare, in cui si verificano
quelle che definisce “distribuzioni politiche
del lutto” asimmetriche. Il divieto di pubblico
cordoglio costituisce la sfera pubblica a partire
da quel divieto. Così, i morti arabi non
hanno né un volto né un nome, la loro
vita e l’angoscia delle persone che hanno visto
morire i propri cari vengono rimosse in una sorta
di derealizzazione collettiva funzionale all’obiettivo
militare, e che produce un «razzismo amorfo,
indefinito, razionalizzato dall’appello all’autodifesa».
Questo meccanismo viene analizzato in maniera sottile
e articolata, e utilizzato per fornire una chiave
di lettura originale di molti eventi, tra cui, in
primo luogo, il caso dei detenuti di Guantanamo (analizzato
in un saggio suggestivo, Detenzione finita,
in cui la Butler, richiamando la nozione di “governamentalità”
di Focault, opera una interessante analisi del tema
della sovranità nella postmodernità)
e quello delle presunte accuse di “antisemitismo
progressista” che cadono su chi dissente dalle
scelte politiche di Israele: accusa infamanti e insensate
che l’autrice smonta nel penultimo saggio, L’accusa
di antisemitismo, ad esse interamente dedicate.
Vulnerabilità e violenza
Il punto centrale, tuttavia, è che il meccanismo
che interdice il lutto delle “altre” morti
e accusa di debolezza coloro che tentano di denunciarlo
non risolve in nessun modo la paura di chi lo mette
in atto nel tentativo di difendersi. Alla fine del
testo, in una riflessione di carattere più
strettamente etico, la Butler rilegge la proposta
etica del filosofo francese Levinas in chiave politica,
alla luce di quanto detto e di quanto avvenuto negli
Stati Uniti dopo gli attacchi alle Torri gemelle.
Il “volto” dell’altro, che in Levinas
costituisce una vera e propria “categoria”
etica, genera infatti sempre un profondo conflitto,
tra l’imperativo che esso porta con sé
e che evita di uccidere, e la paura dell’altro,
generata dall’angoscia della propria vulnerabilità,
paura che è sempre a rischio di generare aggressione.
Il volto ha anche una dimensione politica, non solo
perché esso si lega intrinsecamente al
discorso, ma anche perché il modo in cui
esso viene rappresentato (o cancellato, rimosso) è
funzionale alla sua umanizzazione o alla sua disumanizzazione.
La paura della morte non si risolve con l’uccisione
dell’altro, a meno che non si continui ad uccidere
sempre, senza interruzioni. Infatti, noi siamo esseri
strutturalmente dipendenti, e questa dipendenza è
impossibile da controllare e soggiogare. Essa tuttavia
non è unicamente un’esperienza da temere:
il suo riconoscimento permette secondo la Butler di
dare finalmente voce all’aspirazione a vivere
in un mondo nel quale la vulnerabilità fisica
sia protetta senza tuttavia essere annientata. Proprio
la sofferenza, la sua accettazione può condurre
a intravedere una nuova etica comune, quello che la
Butler chiama un «nuovo umanesimo». Infatti:
«da dove, se non dalla preoccupazione per la
comune vulnerabilità umana, potrebbe emergere
un principio in base al quale ci impegniamo a proteggere
gli altri dalle stesse sofferenze che noi abbiamo
patito?».
Il dolore non solo dà vita a un senso complesso
di comunità politica, ma è in grado
di «evidenziare quei legami e quelle relazioni
necessari a teorizzare ogni forma di dipendenza fondamentale
e di responsabilità etica» (pag. 42).
Prestare ascolto alla vulnerabilità, esserne
prossimi senza temerla o senza reagire, e «stabilire
modalità di visibilità e udibilità
pubbliche in grado di rispondere al grido dell’umano
nella sfera dell’apparenza» (pag. 176):
questa è la sola stretta via che può
condurre a far cessare la violenza, come tutti auspicano,
e generare soluzioni politiche, e non militari ai
gravi problemi conflitti che ci affliggono. «La
sofferenza può condurre ad un’esperienza
di umiltà, vulnerabilità, di sensibilità
e dipendenza, tutte possibili risorse che, se non
vengono risolte troppo in fretta, possono spingerci
al di là contro la vocazione della vittima
paranoica che rinnova all’infinito le giustificazioni
della guerra».
Ecco perché, in conclusione, «certi
volti devono essere mostrati pubblicamente, devono
essere visti e uditi affinché si acquisti un
senso più profondo del valore delle vite, di
tutte le vite. Dunque, non è che il lutto sia
l’obiettivo della politica, ma senza la capacità
di elaborarlo si perde quel più profondo senso
della vita di cui abbiamo bisogno per opporsi alla
violenza. E che anche se per qualcuno il lutto può
risolversi solo con la violenza, è chiaro che
quest’ultima si porta dietro altre perdite e
che l’incapacità di tenere conto della
rivendicazione della precarietà della vita
porta solo, e continuamente, alla sterile sofferenza
di un’ira politica senza fine» (pag. 17).
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti
da fare? Scriveteci il vostro punto di vista a
redazione@caffeeuropa.it
