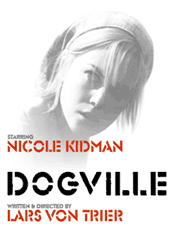 Di Lars Von Trier, il regista danese che ha inventato
il manifesto cinematografico Dogma (www.dogme95.dk)
per poi smantellarlo pezzo a pezzo, si è detto
un po' di tutto: che è un genio e che è
un bluff, che è insopportabile e irresistibile,
che è personalmente odioso e professionalmente
inattaccabile. Su un'etichetta lo stesso Von Trier
sarebbe inequivocabilmente d'accordo: quella di sadico.
Di Lars Von Trier, il regista danese che ha inventato
il manifesto cinematografico Dogma (www.dogme95.dk)
per poi smantellarlo pezzo a pezzo, si è detto
un po' di tutto: che è un genio e che è
un bluff, che è insopportabile e irresistibile,
che è personalmente odioso e professionalmente
inattaccabile. Su un'etichetta lo stesso Von Trier
sarebbe inequivocabilmente d'accordo: quella di sadico.
Lars Von Trier (come dimostra anche il docu-drama
Le cinque variazioni) è un sadico
nel senso in cui lo "deve" essere ogni personalità
creativa. Mi spiego meglio: anni fa, durante un corso
di sceneggiatura, un docente entrò in aula
con in mano un coniglio di peluche e, senza profferire
parola, procedette a seviziare il coniglietto per
un quarto d'ora. "Ecco", disse alla fine,
"questo è quello che dovete fare ai protagonisti
delle vostre storie".
Ciò che intendeva dire, al di là del
compiacimento perverso che quel docente - come Lars
Von Trier - sembrava provare nell'illustrare la sua
teoria, è che per far "muovere" una
narrazione bisogna mettere a confronto il protagonista
con difficoltà sempre crescenti, con dilemmi
veramente esistenziali, con ostacoli (le "variazioni"
calcistiche del docu-drama) via via più impervi.
L'azione drammatica è, in questo senso, sempre
violenta, anche quando il sangue non si vede. Altrimenti
il protagonista non cresce, la storia non cammina,
e lo spettatore si annoia mortalmente.
 Lars Von Trier si è specializzato in particolare
nel far soffrire le sue donne (almeno quelle cinematografiche):
di qui l'etichetta di misogino, oltre che di sadico
tout court. Ne è la prova la trilogia delle
Protagoniste Martiri (detta anche, più volgarmente,
delle Sfigate) composta da Le onde del destino,
Dancer in the dark e Dogville. In ognuno di questi
film - quasi l'intera produzione di Lars Von Trier,
che comprende anche il lungometraggio Idioti
e il serial televisivo The Kingdom - l'attrice
principale - rispettivamente, Emily Watson, la cantante
Bjork e Nicole Kidman - viene sottoposta a una serie
incredibile di tormenti, che lei subisce con quieta
rassegnazione, prevalentemente per amore.
Lars Von Trier si è specializzato in particolare
nel far soffrire le sue donne (almeno quelle cinematografiche):
di qui l'etichetta di misogino, oltre che di sadico
tout court. Ne è la prova la trilogia delle
Protagoniste Martiri (detta anche, più volgarmente,
delle Sfigate) composta da Le onde del destino,
Dancer in the dark e Dogville. In ognuno di questi
film - quasi l'intera produzione di Lars Von Trier,
che comprende anche il lungometraggio Idioti
e il serial televisivo The Kingdom - l'attrice
principale - rispettivamente, Emily Watson, la cantante
Bjork e Nicole Kidman - viene sottoposta a una serie
incredibile di tormenti, che lei subisce con quieta
rassegnazione, prevalentemente per amore.
La prima delle ossessioni di Von Trier è dunque
quella per le donne, viste come vittime della ferocia
di un mondo che si accanisce programmaticamente sul
loro destino (vedremo più tardi quanto l'elemento
di volontarietà giochi un ruolo importante
al proposito). La seconda è quella per la religione
cristiana che, nei film del regista danese, calvinista
nello stile ma cattolico per formazione, gioca un
ruolo di primo piano. La terza ossessione consiste
nel presentare l'occhio (di Von Trier e dello spettatore)
come strumento di potere - perché il cinema
è, prima di tutto, immagine - e contemporaneamente
di inganno - perché c'è una grande differenza
fra guardare e vedere veramente, e il compito del
regista, almeno uno "sadico" come Von Trier,
è quello di farlo presente allo spettatore.
Secondo questi parametri, Dogville è
il coronamento dell'opera di Lars Von Trier, dopo
di che non sappiamo dove il regista potrà andare,
se è vero che ogni artista ha un tema e uno
solo da raccontare, che ci arriva per approssimazioni
successive e che, dopo averlo enunciato al meglio,
non fa che ripeterlo ad nauseam. Intanto però
godiamoci quello che potrebbe essere l'apice della
poetica del regista, provando a scomporre Dogville,
un film di tale frammentarietà e complessità
da consentire infinite letture e riletture.
La capacità di stimolare riflessioni è
il primo punto decisamente a favore di Dogville.
I critici, anche quelli che hanno odiato il film,
anche quelli cui è risultato - programmaticamente,
direi - indifferente, si sono prodotti in lunghe recensioni
estremamente dettagliate, che quasi invariabilmente
contenevano la scomposizione dei termini utilizzati
per descrivere i concetti relativi alla storia, a
indicare una sorta di ansia semantica che è
il diretto riflesso dello sforzo filologico del regista.
Dogville, sceneggiato, montato e girato con
la camera a spalla dallo stesso Von Trier, è
innanzitutto un lavoro di ricerca grammaticale (e
parliamo di grammatica filmica tanto quanto linguistica),
un processo di risalita a radici etimologiche tanto
quanto etiche.
Dogville è un film essenziale nel
senso che mira all'essenza, e questo processo di denudamento
fino al cuore (nero) delle cose e degli individui
viene effettuato prima di tutto grazie alla messinscena.
Una precisazione: la messinscena non conduce all'essenza
semplicemente perché è essa stessa essenziale
(segni bianchi tracciati su un selciato nero, ad indicare
i confini delle case e dell'unica strada di una cittadina
immaginaria sulla Montagne Rocciose americane, Dogville)
ma anche perché tutto, nell'allestimento formale,
è talmente innaturale e artificioso, che risulta
difficile concentrarsi sulla storia. E questo è
un bene, perché l'essenza del film, il cuore
nero di Von Trier, risiede altrove, e ne avvertiamo
il battito precisamente perché il nostro occhio
è talmente impegnato a ricostruire porte e
pareti che la nostra testa e il nostro stomaco non
riescono ad opporre resistenza ai concetti più
"repellenti".
Lo spettatore è talmente impegnato a ricostruire
mentalmente le pareti che separano i cittadini di
Dogville che non riesce a difendersi da ciò
che accade fra di esse. Solo così, dopo averci
deconcentrato, dopo averci fatto abbassare certi scudi
(facendone sollevare molti altri), Von Trier può
offenderci, nel senso di ferirci, tagliarci, aprirsi
un varco. Con l'effetto collaterale di offendere,
nel senso più comune del termine, molti di
noi.
Lo stesso scopo ha la reiterata frammentarietà,
non solo della scenografia - che oltre ai segni per
terra comprende anche alcuni dettagli in verticale,
costringendoci continuamente ad uno sforzo di immaginazione
tridimensionale - ma anche dei dialoghi, che vengono
intenzionalmente spezzettati, e soprattutto del montaggio,
che interrompe "inutilmente" le scene non
per agevolare lo scorrere della narrazione (come di
solito fa il montaggio) ma per intralciarla, impedendoci
una visione continua (leggi: conseguente) delle cose.
A questo servon o anche gli intertitoli che scandiscono
il racconto, senza nulla aggiungere alla comprensione
di ciò che accade nel film; l'effetto straniante
di una recitazione naturalistica all'interno di un
set completamente artificiale; la continua sovrapposizione
della voce fuori campo alla narrazione filmica.
Ricordiamo che la linea bianca sul selciato nero,
per convenzione automobilistica occidentale, se spezzata
contiene un invito implicito a "superare".
Sempre per convenzione occidentale, la linea tratteggiata
in generale indica la necessità di piegare,
tagliare, collegare: in qualche modo, comunque, intervenire
su un percorso volutamente interrotto che richiede
il completamento da parte di chi guarda.
L'occhio dello spettatore di Dogville supplisce
agli sbalzi e ai vuoti amplificando la prima sostituzione
- continuità al posto di frammentarietà
- che sta alla base della finzione cinematografica,
secondo la quale una successione di fotogrammi viene
percepita come una sequenza fluida. E la fatica cosciente,
da parte di chi guarda, di supplire all'artificiosità
della messinscena con uno sforzo costante di immaginazione
lascia scoperta la parte subcosciente, nuda davanti
a una vicenda di crudeltà spietata ("priva
di pietas", cioè di capacità di
condivisione emotiva).
La decostruzione della messiscena, come quella del
fluire narrativo, ha l'effetto di "rimando ad
altro' della poesia, costringe cioè lo spettatore
a riempire gli spazi, a colmare le assenze proiettandovi
la propria interiorità, a immaginare ciò
che è escluso dal gioco coatto delle parti
secondo le rigide regole di un deus ex machina - da
presa.
Nel momento stesso in cui lo spettatore accetta il
patto scellerato offerto da Von Trier - quello di
sottoporsi a due ore e mezza di martirio cinematografico
perpetrato attarverso una continua scomposizione della
storia e della scena - inizia il suo percorso di apprendimento
- esattamente come succede alla protagonista, Grace.
Chi ha lasciato la sala, o si è addormentato
- e sono in molti - ha rifiutato quel patto, e dunque
non ha tratto alcuna soddisfazione dal lavoro di Von
Trier che, come sua prima condizione, richiede la
complicità dello spettatore - esattamente come
succede al calvario di Grace.
La messiscena scarnificata, di per sé, non
è una novità, soprattutto se ci spostiamo
dal cinema al teatro. E qui mi tocca fare la lunga
lista dei riferimenti colti relativi agli allestimenti
da palcoscenico di mezzo Novecento: da Brecht (la
cui Jenny dei pirati è la diretta
ispirazione di Dogville, tanto che Grace
cita letteralmente una delle frasi della Jenny brechtiana)
a Beckett, passando, in Italia, per Luca Ronconi e
Mario Martone. Anche quanto a sceneggiatura, Dogville
ha molti autorevoli padrini: il Tennessee Williams
che faceva dire alla sua Blanche "ho sempre contato
sul garbo degli estranei" o il Thornton Wilder
di Piccola città, ad esempio,
oltre ai già citati Beckett e Brecht.
Così come è infinita la lista dei referenti
letterari, esemplificata da quella voce fuori campo
che molti hanno giudicato insopportabilmente fastidiosa
proprio nella sua letterarietà. Mettiamoci
allora Dickens e Dürrenmatt, Dostoevskij e Faulkner,
Bernhard e Fielding, Hawthorne e Thackeray. E mettiamoci
pure i filosofi, soprattutto Nietzche, collettivamente
messi alla berlina da Von Trier attraverso il personaggio
del "pensatore" Tom.
Lars Von Trier chiama questa summa, prevalentemente
europea, "cinema fusionale" (cinema+teatro+letteratura),
dove l'impianto teatrale subisce l'innesco di interventi
filmici (il movimento di macchina, il totale dall'alto,
l'abbondanza di primi piani, i bisbigli degli attori)
e l'aggiunta degli sbrodolamenti letterari. Aggiungiamoci
le belle arti, sotto forma di alcuni espliciti richiami
visivi: uno per tutti, il quadro vivente formato da
Grace sdraiata sul retro del camioncino del garzone,
un Klimt cinematografico con donna rivestita di luce
dorata contro sfondo di natura morta (mele) accanto
a figura ritorta di uomo.
In fondo, Von Trier non fa altro che allargare il
gioco assemblatico e riepilogativo che Tarantino e
Kitano, per dirne due, fanno con il cinema (e non
a caso entrambi raccontano, come Von Trier, parabole
di colpa, punizione e redenzione). Come per Tarantino
e l'ultimo Kitano, può sembrare difficile trovare
nei film di Von Trier, Dogville in particolare,
qualcosa di originale all'interno della compilation
di cose già viste. Ma questa è la riporva
della paradossale umiltà - su innesti caratterialmente
arroganti - di Von Trier, Tarantino e Kitano nel dichiarare
apertamente con i loro film che non c'è niente
di nuovo sotto il sole, che siamo troppo imbevuti
di cultura, troppo saturi di un immaginario collettivo
condiviso, per sperare di creare (o contemplare) qualcosa
di veramente innovativo. Il massimo che possiamo fare
è riflettere su quanto è già
universalmente conosciuto con una misura di nudità
percettiva.
Al centro di Dogville resta proprio il recupero
della nostra capacità di vedere invece che,
semplicemente, fare da spettatore. Ricordiamo, per
restare all'interno dell'opera di Von Trier, che Selma,
la protagonista di Dancer in the Dark, era
afflitta da cecità progressiva, dunque "vedeva"
con crescente chiarezza la nuda crudeltà degli
uomini a mano a mano che la vista oggettiva le veniva
a mancare. E ricordiamo, per allargare all'ambito
cinematografico generale, che due grandi maestri del
cinema contemporaneo, Stanley Kubrick e Steven Spielberg,
hanno dedicato i loro ultimi film (Eyes Wide Shut
e Minority Report) alla differenza fra guardare
e veramente vedere.
Non è un caso che anche in Dogville
fra i cialtroni del villaggio ci sia un cieco che
finge di vedere (Ben Gazzara) e una ottenebrata coppia
padre-figlio che porta ironicamente il nome di Thomas
Edison, l'inventore della lampadina. Chiunque abbia
visto, o anche solo guardato, il film è rimasto
turbato soprattutto dalla scena del primo stupro,
proprio perché quello stupro si svolge sotto
gli occhi di tutti, se solo volessero vedere (e l'eco
sinistro della scena sta proprio nella coscienza che
tutti abbiamo di quanto le violenze domestiche seguano
proprio quell'iter: si svolgono a distanza di un muro,
mentre tutti voltano la testa dall'altra parte).
Attraverso questa visione amplificata, Dogville consente
numerose chiavi di lettura. Ne accenniamo qualcuna,
senza la pretesa di averle individuate tutte. C'è
quella più ampia, di riflessione sulla natura
umana: sull'homo homini lupus, anzi canis,
visto che alla fine resta vivo, e in carne, solo il
Cerbero, "fiera crudele e diversa", a guardia
del regno delle tenebre di Dogville, oltre
le quali Orfeo non deve osare avventurarsi, e del
regno degli angeli caduti, come Lucifero: Tom avverte
l'angelica Grace che, se si avventurerà oltre
i limiti del paese, rischierà di precipitare,
dimenticando che, come scriveva Nietzche, è
la compassione l’abisso più profondo.
C'è la chiave di lettura politica, sanzionata
dalla canzone di David Bowie (Young Americans)
cantata sopra le immagini finali della Grande Depressione
(il periodo nel quale è ambientato Dogville)
del fotografo Jacob Holdts, che le ha raccolte in
un volume intitolato American Pictures. E
sappiamo che Dogville è il primo segmento
di una trilogia (anti)americana che proseguirà
con Mandeley e Washington (senza Nicole Kidman,
che dopo le angherie di Von Trier e i mancati riconoscimenti
a Cannes ha deciso di tirare innanzi) e che è
stato preceduto da un prologo, Dancer in the Dark.
E' un sunto dell'antiamericanismo di Von Trier
la scena del pranzo del Quattro di Luglio, dove i
presenti cantano America the beautiful (come
nel finale del Cacciatore, non a caso il
film di un figlio di immigrati, Michael Cimino, la
cui opera omnia è uno studio dell'ambigua accoglienza
americana verso il diverso e lo straniero), e immediatamente
a seguire cominciano a rivoltarsi contro Grace. Dopotutto
parliamo del paese in cui un immigrato legale, fino
al momento in cui non è stato naturalizzato,
resta un "alieno".
Dentro la chiave di lettura antiamericana c'è
infatti il più ampio contrasto, già
illustrato da Dancer in the Dark, all'interno
della coppia ospitalità/ostilità, la
cui prossimità semantica (hostis,
cioè straniero o nemico, e hopses,
cioè ospite invitato), nella concezione di
Emmanuel Lévinas e poi di Jacques Derrida,
sta ad indicare l'ambivalenza di fondo della relazione
fra i due concetti e i due atteggiamenti, secondo
cui l'essere amico e l'essere nemico si oppongono
e si associano continuamente.
Sia in Dancer in the Dark che in Dogville,
la società americana rappresenta un modello
di accoglienza dell'estraneo ma anche di ritorsione
repentina contro lo straniero che diventa pericoloso
per la comunità, essenzialmente perché
sfugge alle sue regole. In qualche modo, anche chi
non si ribella ai soprusi si sottrae infatti a una
dinamica (capitalistica, ergo "americana")
di potere che comprende un oppressore ed un oppresso,
entrambi con diritti-doveri ben codificati.
In quest'ottica il perdono è, effettivamente,
una forma di arroganza, che non solo non tiene conto
delle dinamiche dell'ordine costituito (dunque è
perturbante, direbbe Freud, e potenzialmente sovversiva)
ma presuppone anche una posizione di superiorità,
o anche solo di estraneità (hostis, semanticamente
anche ostile), da parte di colui che si colloca nella
posizione di colui che perdona.
Arriva qui la chiave di lettura etico-religiosa, legittimata
fin dalla scelta dei nomi dei personaggi: la protagonista
è Grace (la Grazia), il cane si chiama Mosè,
i figli di Vera (Vera anche nella versione inglese)
hanno tutti nomi da mitologia pagana (Giasone, Atena,
Olimpia, Pandora!). Se i toni della storia, e la conclusione
finale, sono puro Antico Testamento, la via Crucis
della protagonista, con tanto di stazioni segnalate
dagli intertitoli, è puro Vangelo.
All'interno della chiave di lettura religiosa ci
sono almeno un paio di spunti interessanti: quello,
già citato, dell'arroganza del perdono e quello,
speculare e contrario, della difficoltà dell'essere
umano ad accogliere la Grazia. Grace comincia il suo
calvario nel momento in cui accetta di essere accolta
da Dogville in cambio di una serie di favori,
secondo un processo di captatio benevolentiae
(nel suo significato etimologico) che è contrario
al comandamento cristiano "Gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date" (Mt 10, 8).
Si potrebbe pensare che Grace, come tutti noi, paga
il prezzo di una vita "normale", tanto più
alto quanto più codificate e claustrofobiche
sono le regole della comunità di (auspicata)
appartenenza. Ma in realtà quello offerto da
Grace non è uno scambio, è un dono:
e il dono che non consente ricambio mette "in
imbarazzo" colui che lo riceve - per lo meno
nella nostra società del "niente per niente".
E' "umanamente" difficile, per Dogville
(di per se, un anagramma di Godville, in cui God diventa
Dog, Dio diventa cane), accettare che esista una Grazia,
e che sia a disposizione gratuita di ognuno
di noi. I conti non tornano, il patto di reciprocità
sul quale è strutturato l'intero ordine sociale
non è rispettato. E' più facile sovvertire
quell'ordine secondo le familiari regole della sopraffazione
(capitalistiche, ergo "americane") che secondo
quelle della carità "cristiana".
Del resto, a ben guardare, anche il dono di Grace
ha per lei un valore "commerciale", che
non è quello della conquista dell'accettazione
sociale, ma quello del pedaggio necessario per intraprendere
un viaggio di conoscenza di sé, ben oltre la
negoziazione della mera sopravvivenza.
Forse la più interessante fra le chiavi di
lettura di Dogville non consiste tanto nel
contenuto ma, ancora una volta, nella forma. Dogville
vive di coppie di opposti (esasperato-esasperante,
come la disponibilità di Grace; ospitalità-ostilità;
umiliazione-umiltà, in un paese dove gli umili
non sono umili per niente; vittima-carnefice) e funzione
come una sorta di palindromo, rileggibile in tutti
e due i versi: quello che Grace impara dagli abitanti
di Dogville, loro imparano (o disimparano, regredendo
allo stato ferino) da Grace, e viceversa.
Così come la ragazza viene a patti con la propria
natura, la città si libera delle proprie ipocrisie.
E' un processo di spoliazione e di rivelazione reciproco:
se il matririo di Grace fosse completamente unilaterale
(come quello di Bess ne Le onde del destino
o di Selma in Dancer in the Dark) Dogville
non avrebbe la sua redenzione. Grace e Dogville si
sbucciano a vicenda, come cipolle: che è precisamente
ciò che Lars Von Trier fa con gli spettatori
(e quello che il sadismo registico fa a Lars Von Trier,
a giudicare da Le cinque variazioni).
Alla divina frase finale di Cristo "Padre, perdonali
perché non sanno quello che fanno" corrisponde
l'umana frase di Grace “Papà, quando
è che mi daresti il potere di cui mi parlavi?”,
cui segue, “Uccideteli tutti e poi bruciate
il paese”. E arriviamo al rapporto padre-figlia
(altra chiave di lettura) raccontato in Dogville,
che si abbina fin dall'inizio (anche se, sulla base
delle informazioni che ci ha dato il narratore, non
lo "sappiamo") alla valenza paternalistica
di Grace in posizione di perdono: come scrive Derrida,
"Lo straniero porta e pone la temibile questione:
si sa in anticipo messo in discussione dall'autorità
paterna e razionale del logos. L'istanza paterna del
logos si prepara a disarmarlo, a trattarlo da pazzo,
e questo nel momento stesso in cui la questione da
lui posta, la questione dal di fuori, sembra eversiva
solo in questo richiamo a ciò che dovrebbe
essere chiaro persino ai ciechi." Superfluo sottolineare
la differenza fra chi guarda e chi effettivamente
vede.
Il fatto che alla fine del film Grace si trasformi
in un angelo sterminatore ha il senso (e la violenza
biblica "giustificata in quanto giusta")
del ripristino dell'ordine delle cose. Con la vendetta
finale, la funzione di Grace cessa, la parabola (altrettanto
"insensata" di quella del Figliol Prodigo,
ma con una conclusione molto più accettabile
per l'homo homini lupus, cioè noi)
è conclusa. Il destino di Grace si compie contemporaneamente
a quello del villaggio, l'uno indispensabile all'altro.
Del resto, ogni film (come ogni romanzo e ogni piece
teatrale) ha già inscritto il destino dei suoi
personaggi, e compito del regista è proprio
quello di farcelo dimenticare per la durata della
finzione scenica.
Il cane, a cui Grace all'inizio del film aveva sottratto
l'osso, ritrova la sua dimensione materica, come se
fosse stato sciolto l'incantesimo (dictus ac factus,
cita la scritta all'ingresso della miniera di Dogville)
che lo incatenava alla sua assenza. E il continuo
entrare e uscire dalla miniera da parte di Grace per
nascondersi (rimanendo in piena vista dello spettatore)
ai gangster è speculare al ripetuto entrare
e uscire della macchina dei gangster da quel cul
de sac che è Dogville, strada
la cui uscita coincide solo ed esclusivamente con
l'entrata.
Link:
Il sito ufficiale del film Dogville (in inglese
e danese)
La
versione italiana
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti
da fare? Scriveteci il vostro punto di vista a
redazione@caffeeuropa.it
