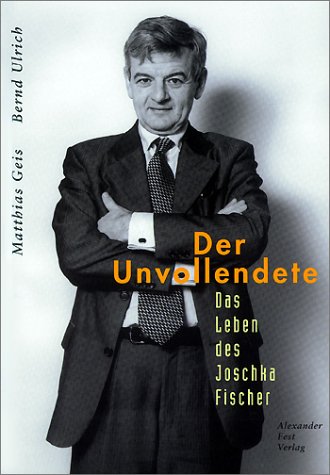 Matthias
Geis e Bernd Ulrich, Der Unvollendete. Das Leben
des Joschka, Fischer (“L’incompiuto. La
vita di Joschka Fischer”), Alexander Fest
Verlag, Berlino 2002, pag.256, Euro 24,90
Matthias
Geis e Bernd Ulrich, Der Unvollendete. Das Leben
des Joschka, Fischer (“L’incompiuto. La
vita di Joschka Fischer”), Alexander Fest
Verlag, Berlino 2002, pag.256, Euro 24,90
Joschka Fischer, per molti, è già un
mito. La BBC gli ha dedicato una lunga monografia
in cui lo definisce “il politico più
interessante d’Europa”, mentre in Germania
l’80% dei suoi connazionali ne approva trasversalmente
l’operato. Della vita dell’attuale ministro
degli Esteri tedesco si sono occupati già diversi
libri, l’ultimo dei quali è L’incompiuto.
La vita di Joschka Fischer, in cui gli autori
Matthias Geis e Bernd Ulrich, rispettivamente giornalisti
di Die Zeit e di Tagesspiegel, raccontano
affascinati l’avventura di una vita intensa,
di un uomo che negli anni Sessanta occupava la case
e oggi è il principale candidato alla poltrona
di ministro degli Esteri dell’Europa allargata.
Joschka Fischer, secondo un collega un po’ snob,
non era che “un teppista che non sa nemmeno
annodarsi la cravatta”. Nato nel Württemberg
nel 1948 da un macellaio ungherese, l’irrequieto
Joschka visse un’infanzia povera e ribelle.
A Francoforte divenne un leader del Putz,
l’Unione Proletaria per il terrore e la distruzione,
presso cui era noto come “ministro della difesa”.
Arrestato un paio di volte, quando alcuni terroristi
tedeschi selezionarono i passeggeri ebrei di un Air-France
dirottato Joschka percepì quella che avrebbe
chiamato “tutta la nostra grande follia”.
Tramontata l’utopia rivoluzionaria, per sei
anni Fischer fu tassista a Francoforte, per poi lanciarsi
con passione nell’utopia riformista. Entrato
nei Verdi, nel 1985 divenne ministro dell’Ambiente
(“il primo ministro verde del pianeta”)
dell’Assia, esperienza che i radicali del suo
partito resero per lui un incubo, ma che avrebbe contribuito
non poco alla nascita del mito, grazie ad una foto
e a due scarpe da ginnastica, quelle che indossò
il giorno del giuramento e che oggi sono esposte in
un museo.
Preso il comando di quel partito che non aveva mai
amato, vinte le elezioni del 1998, Joschka Fischer
divenne ministro degli Esteri, per il semplice fatto
che quella poltrona gli apparteneva. Nel 1992, nel
libro La sinistra dopo il socialismo, della
politica estera europea aveva scritto: “Se non
troverà la propria unità, l’Europa
ricadrà nella sua antica lacerazione e nei
conflitti d’egemonia, nel nazionalismo e nell’odio
dei popoli, e verrà dominata dall’esterno”.
Unione europea o barbarie, questa già allora
la base del suo pensiero.
Da quel 1992, Fischer avrebbe ancora attraversato
due fasi. Egli, dicono Matthias Geis e Bernd Ulrich,
gli autori de L'incompiuto, non fu mai un
pacifista in senso stretto, ma quando il 12 luglio
1995 i serbi assalirono Srebrenica, selezionando i
musulmani e conducendoli fuori dall’enclave
con un bus per poi ucciderli, Fischer non se la sentì
di appoggiare l’invio delle truppe tedesche
laddove avevano infuriato, disse, le “soldatesche
di Hitler”.
Lo Joschka Fischer ministro degli Esteri, continuano
gli auotir, è invece un uomo che si pente di
non aver salvato i musulmani bosniaci. In questa seconda
fase, che dura tuttora, egli sa realizzare una perfetta
sintesi delle sue passate esperienze, mostrando oggi
una saggezza trasversalmente riconosciuta (così
simile a quella di Adriano Sofri, di cui peraltro
è amico) e che si è concretizzata con
successo in tre momenti decisivi della politica estera
europea degli ultimi anni: la guerra in Kosovo, l’impegno
per la pace in Medio Oriente e la missione in Afghanistan.
Nel 1999 Fischer si prese la responsabilità
di riportare in guerra la Germania per la prima volta
dal 1945, per di più senza mandato dell’Onu.
La decisione fu sofferta e non apprezzata da tutti
(come il pacifista che al congresso dei Verdi lo colpì
all’orecchio lanciandogli una busta di vernice).
Per giustificarla venne utile a Fischer proprio l’argomento
con il quale aveva rifiutato la missione in Bosnia,
ovvero il precedente hitleriano: “Non ho solo
imparato: mai più guerre – disse –
Ho imparato anche: mai più Auschwitz”.
In Medio Oriente, come già nel Kosovo, egli
svolse un ruolo di primo piano, per di più
in un momento in cui la sua credibilità era
scesa improvvisamente a livelli minimi, a causa della
pubblicazione di alcune vecchie foto in cui, con casco
e tuta nera, picchiava selvaggiamente un poliziotto,
e della contemporanea imbarazzante deposizione al
processo contro il terrorista Klein. In un’intervista
di quello stesso gennaio 2001, Fischer negò
inoltre di aver mai partecipato, da giovane, ad un
congresso dell’Olp. Ma delle foto del 1969 lo
smentirono clamorosamente. Ne seguì una campagna
di stampa diffamatoria, che lo portò quasi
alle dimissioni e alla depressione, evitata grazie
ad amici come Cohn-Bendit e l’ex Segretario
di Stato americano Madeleine Albright, che gli disse:
“Sapevo che eri un cattivo ragazzo, ma non così
cattivo: interessante”.
A fine maggio era a Tel Aviv quando un kamikaze si
fece esplodere in una discoteca sulla spiaggia, uccidendo
22 giovani e ferendone quasi cento. Furono giorni
terribili, raccontano Geis e Ulrich, in cui Fischer
non si fece condizionare né da quelle foto
appena pubblicate né dal suo essere tedesco:
parlò con Sharon, spiegò alla tv israeliana
che quei giovani morti avevano la stessa età
dei suoi figli, e ciononostante fu ottimo interlocutore
di Arafat.
In occasione della missione in Afghanistan, Fischer
dovette poi ancora una volta vincere l’ostilità
del proprio partito, perché mancato consenso
avrebbe portato ad una crisi di governo. “Non
esiste una politica estera verde, ne esiste solo una
tedesca”, si sfogò, e confermò
la linea filoamericana bipartisan che era stata di
Adenauer, Brandt, Schmidt e Kohl. Il rapporto di Fischer
con gli americani, e Colin Powell lo sa, è
un rapporto leale, tanto che gli stessi statunitensi,
a poche settimane dall’11 settembre, chiesero
proprio a lui di andare in Iran a spiegare il senso
della coalizione anti-terrore, e tanto che il New
York Times lo definì allora come un politico
“dall’alta reputazione di filoamericano”.
Se oggi si è schierato contro la guerra in
Iraq, puntualizzano Geis e Ulrich, non è stato
per calcolo economico o per nazionalismo, ma perché
il suo pragmatismo si nutre ancora di valori e di
passione. Il suo rapido riavvicinamento all’America,
dopo la battaglia del Palazzo di Vetro, non è
opportunistica debolezza, ma la volontà di
non perdere mai di vista la forza e la politica, perché
egli, come scrivono Geis e Ulrich, “si trova
a casa ovunque si tratti di Potere”. Egli sa
che l’amata Europa non deve inimicarsi gli Stati
Uniti, perché sono oggi troppo potenti, e Fischer
non è tipo da combattere contro i mulini a
vento.
La biografia di Matthias Geis e Bernd Ulrich si lascia
leggere con piacere, per la serena brillantezza della
scrittura e per l’onestà con cui i due
autori ammettono la loro ammirazione verso il personaggio
ma, senza lusinghe, non nascondono nulla della sua
storia. Le molte foto restituiscono il senso dell’avventura,
alternando gli occhialoni dell’adolescente con
i ritratti “cheguevariani” del periodo
francofortese, l’estrema pinguedine delle vacanze
toscane con l’asciutta severità del maratoneta
di New York.
Il Tageszeitung ha lodato gli autori per
aver letto la vita di Fischer non alla luce di una
possibile coerenza delle idee, ma alla luce del rapporto
tra Fischer e il Potere e l’esperienza di sé.
L’unico punto critico, relativo alla domanda
se egli sia o meno un opportunista, suona in realtà
come retorica. Di Fischer ci si può fidare,
perché la sua Realpolitik non è mai
né amorale né fine a se stessa. Fischer
il pragmatico e Fischer il metafisico, colto in una
recherche inquieta che passa attraverso un
continuo movimento (anche di donne e di peso) che
oggi lo porta ad una solida visione fondata su due
punti fermi: l’Europa e la Realpolitik (che
lo fa “cardinale tra i vescovi”, “Senatore
americano quando è alla Casa Bianca”,
e sempre abitante della “stratosfera della diplomazia”).
Dell’Europa disse, in un celebre discorso all’Università
Humboldt, che deve essere unita e forte, anche militarmente,
ma che anzitutto non deve essere percepita come uno
Stato lontano e burocratico: “I cittadini non
devono amare l’Europa, e neppure volerla. Basta
che la accettino”.
Stimato dagli amici e rispettato dai nemici, europeista
convinto ispirato alla concezione globale del Potere
di Henry Kissinger, secondo Geis e Ulrich nella sua
miracolosa sintesi di Realpolitik e passione la politica
estera europea Fischer potrebbe trovare una soluzione
alla sua crisi. La sua coraggiosa indipendenza non
è venuta meno né in occasione delle
proteste degli antiamericani del suo partito per le
missioni in Kosovo e in Afghanistan, né quando
in febbraio, durante un incontro ufficiale, smise
improvvisamente di parlare in tedesco e, in perfetto
inglese, improvvisando spiegò chiaro e tondo
ad un gelido e imbarazzato Rumsfeld perché
la maggioranza dell’Europa rifiutava la guerra.
Joschka Fischer dovrà divenire ministro degli
Esteri della nuova Europa allargata, dicono gli autori
del saggio tedesco, semplicemente perché quella
poltrona gli appartiene. Solo allora, forse, avrà
termine l’avventura dell’“Incompiuto”.
Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti
da fare? Scriveteci il vostro punto di vista a
redazione@caffeeuropa.it
